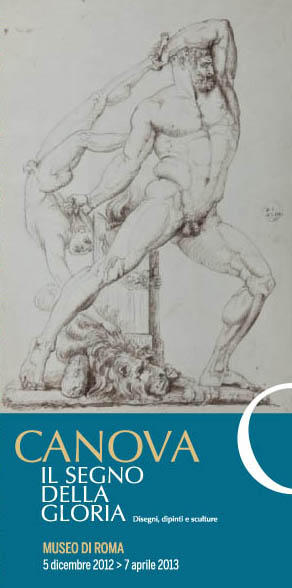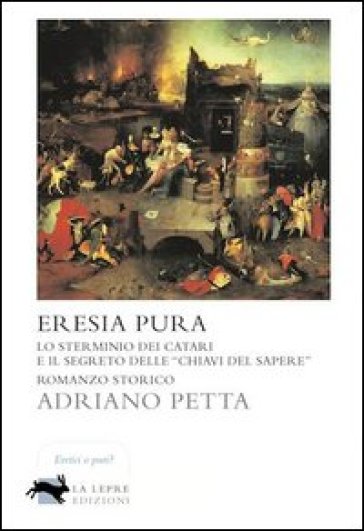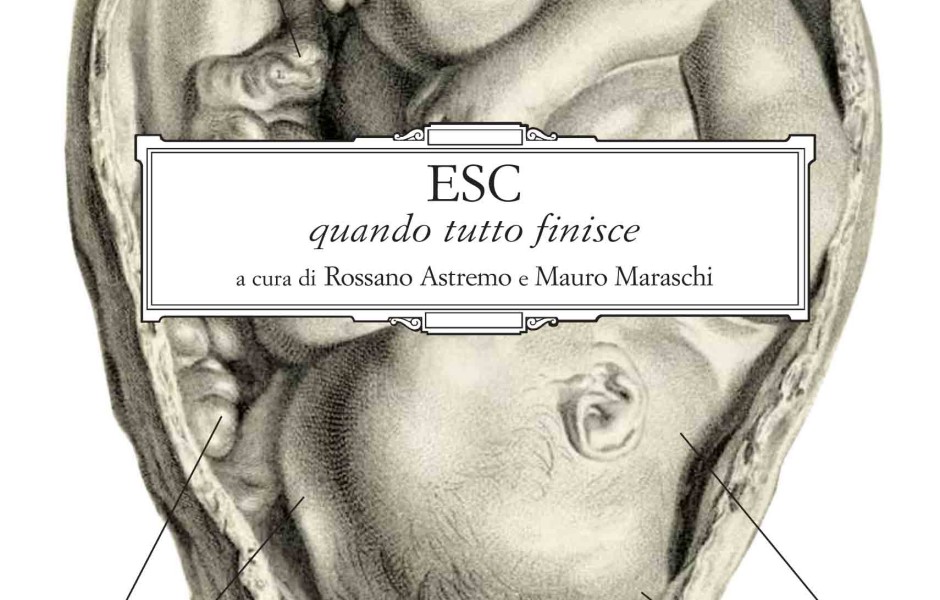«Magnificent». Questo è stato il commento di Ezra Pound quando si è trovato tra le mani le 9 Liriche di Lucio Piccolo, barone solitario, nato a Palermo nel 1901 e autore di versi mirabili di cui si è persa per lungo tempo memoria.
Piccolo trascorse una vita d’isolamento dall’intensa coloritura letteraria. Dopo la fuga del padre a Sanremo con una ballerina, negli anni Trenta si era trasferito, e quindi segregato, in una villa in stile ottocentesco sulle colline di Capo d’Orlando e aveva fatto giuramento di non sposarsi mai insieme con i fratelli Casimiro e Agata Giovanna.
«Il palazzo di Capo d’Orlando più che una casa sembrava una favola campata in aria. Onde marine, nubi, folate di vento, gabbiani, corvi, gatti neri, spiriti, anime di crociati, anime in pena e santi vagabondi stanchi di paradosi dividevano con il nostro poeta quella solitudine dorata» (Gonzalo Alvarez Garcia, Le zie di Leonardo, Scheiwiller, Milano, 1985).
Nella solitudine della villa ben discosta dalla vita di paese, protetti dalle maschere che fanno ancora bella mostra sulla doppia rampa di scale dell’ingresso, i tre fratelli si dedicavano a studi esoterici e allo spiritismo, tentando di entrare in contatto con le anime dei defunti. «Pertugi, sgabuzzini, ambienti / nascosti tra le quinte / dove monomania / di specchi in ombra / accolse i sedimenti / d’epoche smorte, di fasi sbiadite / che il riflusso dei giorni in un torpore / lasciò fuori del sole» (“Gioco a nascondere”, in Gioco a nascondere, Canti barocchi e altre liriche, Mondadori, Milano, 1960). Casimiro era convinto anche di poterli immortalare in fotografie e riproduceva poi le sue visioni in pregevoli acquerelli di gnomi, elfi ed ectoplasmi. Agata Giovanna aveva cura del giardino, in cui arrivavano piante rare da tutto il mondo, e del cimitero dei cani, unico in Italia e tra i pochi in Europa.
«Quando viene l’oscurità, e la casa si interiorizza, diventa ombra, spazio in cui andiamo errando e ritrovando le figure care, persone care che ci sono state vicine», aveva dichiarato Lucio in un’intervista rilasciata nel 1967 a Vanni Ronsisvalle per la RAI, Il favoloso quotidiano.
Villa Piccolo, con i suoi soffitti alti e decorati e le sue stanze affacciate su un verde lussureggiante, ospitò per diversi mesi Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cugino dei Piccolo da parte di madre, garantendo la quiete e il silenzio necessari per la stesura di alcune parti del suo Gattopardo, la cui versione manoscritta, dopo il rifiuto di Mondadori del 1956 e prima dell’insperata fortuna, rimase a lungo nella Villa, abbandonata su una consolle.
Sul rapporto di Lucio Piccolo e Giuseppe Tomasi, intervenne ancora lo stesso Piccolo nell’intervista a Ronsisvalle. Il passo che segue ci introduce anche alle letture del poeta, oggi conservate nella biblioteca della Villa che conta circa diecimila volumi in diverse lingue. Piccolo si concentrava soprattutto sugli autori europei suoi contemporanei e del secolo precedente (Keats – di cui tradusse “Ode To a Nightingale” all’età di sedici anni – Mallarmè, Valéry, Oscar Wilde, Yeats – di cui si definiva “discepolo” e con cui intrattenne un rapporto epistolare – Maeterlinck, Heredia, Kahn, Joyce, Proust, Montale) che avrebbero influenzato sensibilmente la sua produzione in particolare nella scelta degli aggettivi usati per dare forma e sentire umano agli oggetti e agli elementi della natura.
«C’era fra di noi una sorta di gara, a chi fosse più abile scopritore di interessanti novità. Ricordo che fu così a proposito del grande poeta Yeats, il grande poeta d’Irlanda che fui io il primo a leggerlo prima ancora di Lampedusa […] E così ci siamo accaparrati tutta la letteratura contemporanea europea, tedesca, francese. Ricordo anzi che fu proprio Lampedusa a introdurre a Palermo, nella Palermo colta, Rilke […] Poi passarono Joyce, Proust. Di Proust mi ricordo che una volta mi disse “Sai, c’è uno scrittore francese il quale per fare due passi da lì a qui ci impiega dieci pagine”. La prima immagine che io ho avuto di Proust è stata questa».
Queste dichiarazioni hanno uno straordinario valore documentario proprio per la rarità delle apparizioni in pubblico del barone e per la sua riservatezza. Solo una volta, nel 1954, si era convinto a far stampare privatamente in sessanta copie 9 liriche e a mandarlo a Montale. («Un libriccino stampato da una sola parte del foglio e impresso in caratteri frusti e poco leggibili», avrebbe scritto Montale a riguardo, scatenando l’ira del tipografo, sig. Zuccarello di S. Agata Militello (ME) che, irrimediabilmente offeso, aveva urlato: «Io lo denunzio questo Pontale, lo denunzio!»). Montale, entusiasta per i risultati raggiunti da quello che credeva essere un giovane poeta, lo aveva invitato a partecipare a Gli incontri letterari, manifestazione organizzata nel comune di San Pellegrino Terme e presieduta da una decina di scrittori già affermati (oltre a Montale, tra gli altri, Cecchi, Ungaretti, Comisso, Repaci, Bellonci e Alvaro) che presentavano ciascuno uno scrittore o un poeta inedito (oltre a Piccolo, quell’anno, Calvino, Lopez, Bassani, Zanzotto, Parise, Ballistani) per poi consegnare un primo e un secondo premio di 500 e 200 lire. Il barone era arrivato in treno, accompagnato da un servo muto e dall’immancabile cugino. E aveva vinto il primo premio.
«Quella coppia stranissima di titolati siciliani, goffi e un po’ traballanti, suscitò immediatamente la curiosità di ognuno: quasi un’apparizione carnevalesca di piena estate, un intermezzo in costume con due personaggi di fine secolo in cerca di autore».
Il primo capitombolo bislacco nel mondo letterario degli eletti contribuì sicuramente a far conoscere Lucio Piccolo e a suggerirlo all’attenzione della critica italiana, ma non giovò a porre le giuste premesse per un’indagine pacata e approfondita sul valore dei suoi versi. La produzione poetica del barone giungeva infatti in un momento storico e in un clima letterario che erano forse i meno propizi ad accogliere con favore una poesia unica, che rompeva con gli schermi del neorealismo e che nulla aveva in comune nemmeno con le prime prove della neoavanguardia.
Le 9 Liriche, con l’aggiunta di altre dieci poesie e con il titolo Canti barocchi e altre liriche, presero comunque posto nella prestigiosa collana Poeti dello “Specchio” Mondadori con prefazione di Eugenio Montale. Seguì nel 1960 una ripubblicazione con in più la sezione Gioco a nascondere e, nello stesso anno, una piccola diffusione della raccolta Plumelia da parte dell’editore Scheiwiller di Milano. Poi più nulla per molto tempo. Così Piccolo rimase appollaiato e ingufito sulla sua poltrona (u cuccu, “il gufo”, lo chiamavano in famiglia) e da lì non si mosse più fino alla sua morte, giunta all’improvviso nel maggio 1969.
«La casa era quieta, il resto del mondo lontanissimo. Fu così che mi resi conto come per Villa Piccolo passasse un meridiano come a Greenwich. Il meridiano della solitudine».
Osservò la cultura dall’esterno attraverso i segnali che questa, gentilmente, era solita recapitargli direttamente a casa. Dopo la pubblicazione del 1956 di Canti barocchi e altre liriche, Villa Piccolo, con i suoi abitanti e la sua storia, stimolò la curiosità di molti e divenne un cenacolo di cultura frequentato da amici, letterati, giornalisti, scrittori e fotografi. Tra i tanti visitatori ricordiamo Cesare Zavattini, Mario Soldati e Vincenzo Consolo.
«Frequentai Piccolo per anni, andando da lui, come per un tacito accordo, tre volte la settimana. Mi diceva ogni volta, congedandomi: “Ritorni, ritorni, Consolo, facciamo conversazione”. E la conversazione era in effetti un incessante monologo del poeta che io ascoltavo volta per volta ammaliato, immobile, nella poltrona davanti a lui. Era per me come andare a scuola da un grande maestro, a lezione si letteratura, di poesia, impartita da un uomo di sterminata cultura».
Piccolo sentiva di avere una memoria ancestrale e cantava un’umanità spoglia di attributi sociali e abiti storici attraverso la gloria degli elementi naturali, che si offrono all’uomo in forme ora chiare, ora velate e misteriose, ma con il dono eterno dell’autenticità. L’essere umano invece, soggetto con i suoi moti alla sozzura della storia e al lavorìo implacabile della memoria, è deformato dal tempo. Il suo essere autentico ha una durata effimera, impalpabile, che non lascia traccia nel mondo; per questo motivo il rapporto con l’autentico della natura risulta estremamente difficile e si inserisce in una generalizzata impossibilità di conoscere le cose che, con il tormento che ne deriva, Piccolo ha in comune con Montale, di cui non tralasciava di dichiararsi lettore con «devozione e grande attaccamento […] per il poeta e nobilissimo uomo al quale spiritualmente io tanto debbo; la sua opera è stata per me una di quelle forze che ci aiutano, che ci sono necessarie per la conoscenza e la conquista di noi stessi».
Vengono riproposte da Piccolo parole tipicamente montaliane come cuspide, turbine, spore, sottobosco, flussi, nocche e montaliana è anche la tendenza a collocare l’asserzione nella parte finale del componimento dopo una fase descrittiva caratterizzata da un procedere a elencazione.
Nel mondo poetico di Piccolo si incontrano cristianità, paganesimo e religioni orientali, in un intreccio di simboli così potenti da innalzare la poesia a unica religione in grado di creare l’agognato contatto con una realtà altra. Nel momento in cui la pagina scritta illuminata dalla candela è imbevuta dai versi, si compie il trasferimento della percezione dal reale al surreale attraverso l’unicità dell’atto creativo, che è pratica quotidiana, necessaria perché costruttrice di senso. «Scrivevo versi come altri passeggia o sta alla finestra: era un fatto naturale».
Caratteristiche del verso sono la musicalità e il ritmo, il gioco delle rime, delle assonanze e delle dissonanze, delle parentesi, dei frequenti interrogativi che l’uomo spoglio si pone davanti alla lussuria della natura in Canti Barocchi, davanti alle ombre in Gioco a nascondere: si tratta di ombre fisiche e concrete, ricavate dalla proiezione delle cose, ma anche di ombre sognanti ed evanescenti, provenienti dall’ignoto («Hai visto come al varcare la soglia / il lume ch’era nella mano manca / mentre l’altra fa schermo, ha dato uno svampo / leggero dal vetro s’è spento. / Tardo il passo né fu colpo di vento, / forse ha soffiato qualcuno, un volto / subito svaporato nell’aria? […] Ma non c’è nessuno / e sai che non bisogna tentare / il buio: rimemora, ha nostalgie, imprevisti, / l’ombra e le ombre, meglio pregare / a quest’ora, quel che gioco / sembra di giorno fa vero / di notte la notte che sogna – […] I morti / non hanno cifre per i nostri tesori, / singulti hanno in noi, / veglie / di fiamme basse, aneliti, / d’angoscia verso un nodo di vita / incompreso, e a volte una sera / che scende dall’alto a candori infiniti»). Si definiscono così i due poli dell’indagine metafisica di Piccolo: da una parte l’esterno, la natura, che ammalia e seduce («L’arbusto che fu salvo dalla guazza / dell’invernata scialba / sul davanzale innanzi al monte / crespo di pini e rubi […] la plumelia bianca / e avorio, il fiore / serbato a gusci d’uovo su lo stecco, / lascia che lo prenda / furia sitibonda / di raffica cui manca / dono di pioggia, / pure il rovo ebbe le sue piegature / di dolcezza, anche il pruno il suo candore»); dall’altra l’interno, la coscienza, che si materializza nell’esterno attraverso i simboli, nel labirinto e nella metafora della casa, e in un momento preciso, che è quasi sempre quello del crepuscolo, con la presenza imperante della memoria ingannevole e di Mnemosine, sua dea («Mobile universo di folate / di raggi / d’ore senza colore, di perenni / transiti, di sfarzo / di nubi: un attimo ed ecco mutate / splendon le forme, ondeggian millenni. / E l’arco della porta bassa e il gradino liso / di troppi inverni, favola son nell’improvviso / raggiare del sole di marzo»).
Il simbolismo piccoliano non affonda le radici esclusivamente in quello francese. Efficace e decisiva l’influenza dei poeti italiani come Gozzano, Rebora, Campana e Govoni, ma soprattutto delle religioni orientali e delle scienze esoteriche (numerose le presenze di rose, garofani, scale fuochi, specchi e numeri, in particolare il tre).
Volumi pubblicati postumi avevano convogliato l’interesse critico verso la poesia di Lucio Piccolo sollevando problematiche filologiche che però richiedevano, per essere approfondite e risolte, la rilettura delle bozze e dei manoscritti e le carte, a più di dieci anni dalla sua morte e malgrado i numerosi tentativi, continuavano a essere precluse agli studiosi per vicende giudiziarie legate all’eredità del patrimonio Piccolo. Sembrava che se ne fossero definitivamente perse le tracce.
«Inediti? Non ce n’è. Manoscritti? Non ce n’è. Lettera di Montale? Non ce n’è. Niente c’è. Nenti sacciu. Così rispondeva puntualmente, duro e deciso, a studenti e giornalisti e critici l’amministratore dei baroni Piccolo».
Solo nel 1981 è stato possibile analizzare il materiale esistente: oltre alle bozze, opere incompiute, progetti di opere, appunti, saggi completi su argomenti letterari, ma anche scientifici, filosofici e musicali, elenchi lessicali in varie lingue (arabo, greco, inglese, tedesco). La scoperta che di sicuro è più degna di nota è il manoscritto incompiuto L’esequie della luna, che ha ispirato Lunaria di Vincenzo Consolo, edito da Einaudi nel 1985, e un’opera teatrale diretta da Francesco Pennisi e rappresentata per la prima volta nel 1991 alle Orestiadi di Gibellina. L’esequie della luna, insieme ad altre quattro brevi pagine (L’orologiaio prodigioso, Il libro, La bussola, L’eclisse nella stanza)costituisce la prova in prosa dell’autore e racchiude tutto l’immaginario piccoliano. È una narrazione « volutamente barocca e ingenuamente romantica» che disorienta il lettore per la presenza fitta di simboli e le descrizioni malinconiche che si allontano dalla trama in digressioni che sembrano quadri astratti. Il protagonista del racconto è un viceré spagnolo che una notte sogna la caduta della luna dal cielo; il giorno seguente, tra lo stupore dei contadini, la luna cade davvero in una contrada che prenderà il nome di Lunaria. Gli astronomi di corte cercano inutilmente di spiegare il fenomeno e di rimettere a posto i pezzetti di luna, ma nel cuore del viceré la luna, che qui assurge a simbolo del potere, è caduta per sempre. La città descritta è una trasfigurazione fantastica della Palermo che Piccolo ha visto da bambino e che ora rivede con contorni sfumati, a metà strada tra il sonno e l’allucinazione. Su questo sfondo si muovono figure fiabesche e con nomi comuni (il Villano, il Capitano, le Dame, il Notaro).
Come non pensare allo Spavento notturno di Leopardi, frammento del 1819, in cui Alceta racconta a Melisso di aver sognato proprio la caduta della luna dal cielo?
(«Odi, Melisso / io vo’ contarti un sogno / di questa notte, che mi torna a mente / in riveder la luna»).
Reperire le opere di Lucio Piccolo risulta oggi molto difficile. Attendendo nuove edizioni e una maggiore diffusione della sua opera, invitiamo i lettori a visitare la Villa Piccolo di Calanovella, sita in C/da Piano Porti a Capo d’Orlando che oggi è un museo aperto al pubblico e affidato alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.
«Ci sono uomini che in determinate epoche arrivano alla perfezione, sciogliendosi dall’ambiente in cui vivono e dalle cose del loro tempo, assumendo coscienza della fine e salvandosene nel distacco, nella superiorità, nell’autosufficienza. E in questo senso, Piccolo partecipa di una tale perfezione, nella sua vita come nella sua poesia» (Leonardo Sciascia, “Le soledades di Lucio Piccolo”, in La corda pazza, Einaudi, Torino, 1976).
Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.
Sito internet : http://www.fondazionepiccolo.it/
Contributo di Vincenzo Consolo in Il barone magico, in Manifesto. Obliqui egregi nella storia e nel tempo, sezione di antologia e critica letteraria del sito di Oblique Studio: http://www.oblique.it/manifesto_piccolo.html
Gli acquerelli di Casimiro Piccolo. Contributo youtube con immagini dei quadri e della villa: http://www.youtube.com/watch?v=A32hgm0qMro