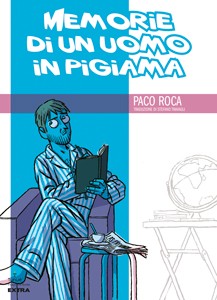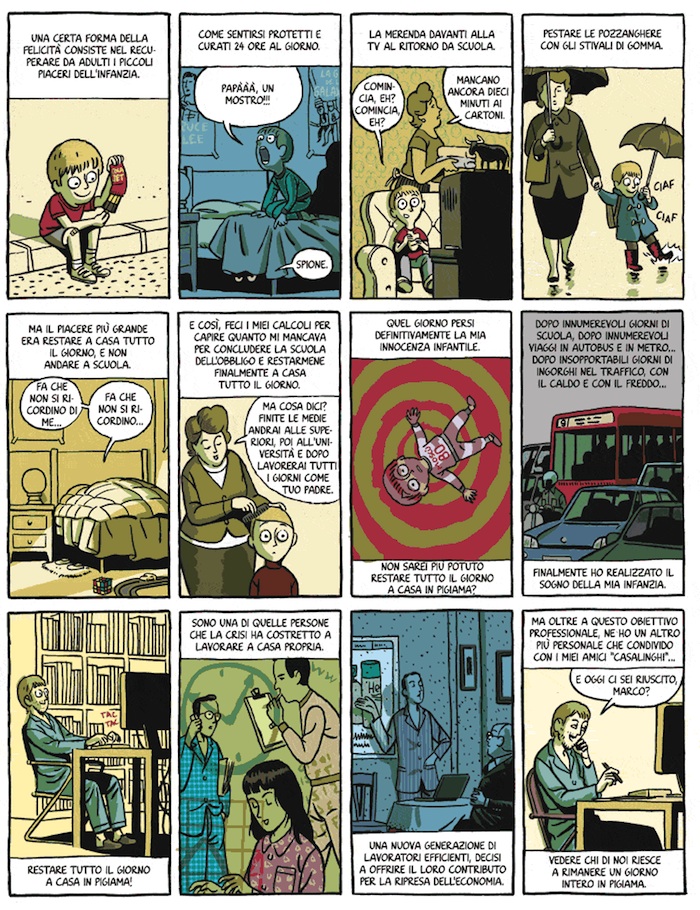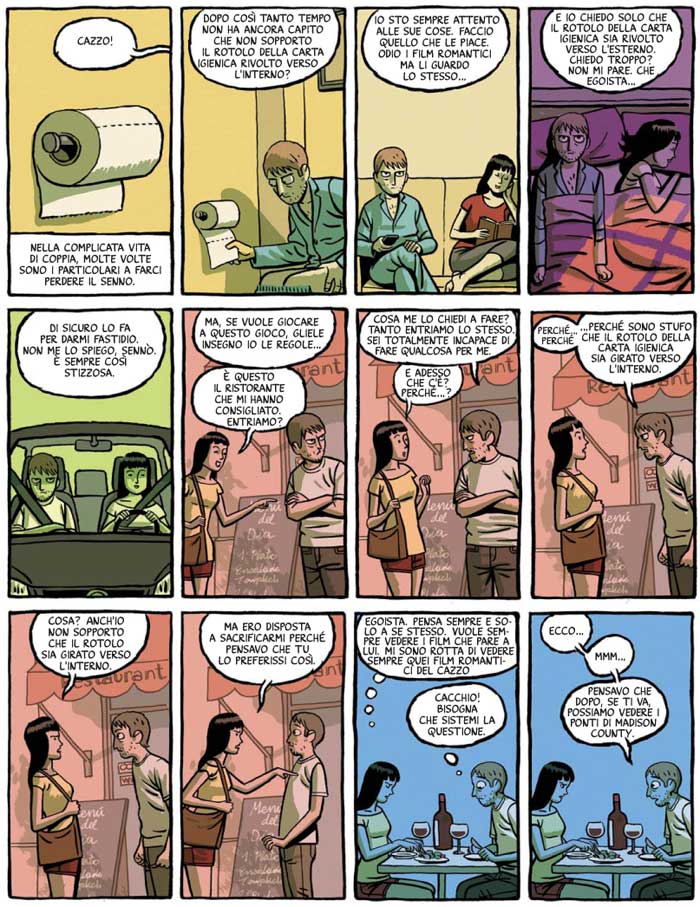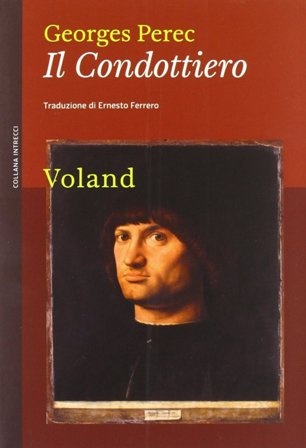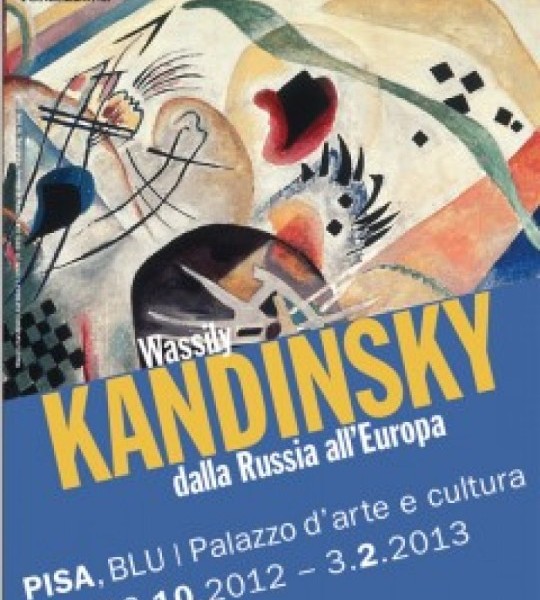Non capita tutte le sere di bere una tisana con Beppe Severgnini discorrendo del suo ultimo libro Italiani di domani. 8 porte sul futuro, edito da Rizzoli. È stata l’occasione per discutere di giovani, di Italia, di crisi e di futuro. Le 8 porte sul futuro, indicate dalle 8 parole che iniziano con la T – Talento, Tenacia, Tempismo, Tolleranza, Totem, Tenerezza, Terra e Testa –, ci mostrano le infinite possibilità che la vita ci può offrire e ci danno la speranza concreta di potercela fare, nonostante la tempesta, nonostante la pressione che ci impongono i viticoltori. Ma queste cose diventeranno chiare più avanti.
«Lei è il più vecchio di noi e non il più giovane di loro».
La costruzione del libro attraverso otto parole che hanno come iniziale la lettera T è una trovata molto divertente, oltre che funzionale per la suddivisione dei capitoli. Tutte parole semplici e allo stesso tempo illuminanti, ma quella che mi ha colpito di più è la Tolleranza. Che cosa vuol dire? Noi “italiani di domani” siamo un po’ rigidi.
L’idea delle otto T, che può sembrare infantile, io la chiamo l’applicazione alla saggistica della tecnica del cibo cinese. Il cibo cinese si tagliuzza, perché la gente lo mastichi e lo digerisca meglio e siccome la gente legge poco i libri in genere, se si offrono delle porzioni non facilmente commestibili, non lo avrebbe letto nessuno. Se questo libro fosse stato di 700 pagine, con 10 capitoli da 70 pagine, scritti fitti, non lo leggeva nessuno. Mi sono accorto che le cose che volevo dire si potevano sviluppare sotto alcuni macrotemi e ho deciso di chiamarli con parole che iniziassero con la lettera T. Per dare un consiglio a quelli della vostra generazione, perché di fatto questo libro è un consiglio per persone più giovani di me, però le parole “consigli” e “giovani” sono assenti, per fortuna. C’è il Talento, la Tenacia, il Tempismo, che non è opportunismo, ma avrei potuto chiamarle in altro modo. Mi sono accorto che le T potevano essere memorabili e non a caso anche tu ti sei accorta e ricordata di questa cosa. Poi ho giocato con il numero 8: è una sorta di confezione, se fai un regalo a qualcuno, l’importante è che il regalo sia bello e offerto con amore, ma vuoi anche metterlo in un bel pacchetto. Questa è l’operazione che ho fatto in questo libro e che in generale è la chiave della saggistica. Gli americani sono più bravi di noi a fare questo, ma avendo imparato un po’ di cose da loro, ho acquisito l’importanza di una buona presentazione, così da non far scappare il lettore medio.
La Tolleranza è, tra tutte la T, più difficile da spiegare, perchè dire a un ragazzo o a una ragazza di capire il proprio talento perché sarà il proprio valore aggiunto e che se non si è portati per qualcosa ci si troverà a competere con persone che invece lo sono, oppure che ci vuole Tenacia, Tempismo e Tecnica è più semplice, ma dire che c’è bisogno anche di Tolleranza, è più difficile. Per alcuni è sinonimo di sopportazione e dire adesso che si deve essere tolleranti può essere inteso come un invito a sopportare l’insopportabile ed essere paziente con gente, situazioni o condizioni che invece non dovrebbero essere sopportati. Quella che intendo io è una Tolleranza intelligente e bisogna capire che la parola compromesso non è una bestemmia, ma che qualche volta è il modo per evitare un conflitto. Le persone intelligenti devono capire che il compromesso giusto è una qualità. Il compromesso buono è quello che puoi rendere pubblico, senza imbarazzo, il compromesso sbagliato è quello che non è riferibile, che comprende azioni immorali, illegali o illecite. Una delle chiavi della Tolleranza è l’ironia, che è una grandissima qualità che bisogna imparare presto nella vita, perché se nel mondo del lavoro per esempio ti dovessi trovare davanti a un capo che ha l’abitudine di urlare, se riesci a vederlo in maniera ironica, come una delle tante stranezze della vita, diventa una forma di igiene mentale. L’ironica è una grande igiene mentale ed è una delle forme della Tolleranza.
Durante le presentazioni di questo libro lo ha definito «un libro per i nostri ragazzi, quindi anche per noi», facendo molta attenzione a evitare la facile etichetta di “consigli per i giovani”. I suoi libri sono letti da tutti, ma a chi stava pensando durante la stesura?
Io credo di averlo scritto per quelli che vogliono riprogrammare la propria vita, ragionare sull’uso del proprio Talento, sulla Tolleranza, sul Tempismo, sulle tecniche della vita quotidiana. Questo libro si può leggere anche a cinquant’anni, ma non c’è dubbio che il destinatario abbia un’età che comincia per 2. Ritengo che gli anni che cominciano per 2 siano fondamentali nella vita. Sto leggendo un libro che si chiama The Defining Decade, la decade che definisce, e penso che molte delle scelte che facciamo negli anni che vanno dai 20 ai 29 sono quelle che di fatto ci condizionano la vita: scelte di lavoro, scelte familiari, qualcuno dice anche scelte riproduttive. C’è tempo dopo e prima, ma questi sono gli anni fondamentali. Quindi ho voluto provare a rivolgermi a una generazione che non ha avuto ancora tempo di commettere grandi errori e che ha davanti grandi possibilità. La vera forza dei libri è questa: improvvisamente qualcuno di offre, attraverso delle pagine, un punto di vista, una voce dal nulla che ti può aiutare. Quando si legge un grande romanzo, e non è il mio caso, io sono un saggista, improvvisamente ci si accorge che ci sono nuove prospettive su un pezzo di mondo che magari non avevi preso in considerazione. Un libro è un po’ come un amico che sbuca dal nulla e che ti dice la frase giusta nel momento in cui ne hai bisogno. Non succede sempre, ma ogni tanto arrivano.
La settimana scorsa sono stato all’Università di Pisa per parlare con i ragazzi e ci hanno fatto vedere un film documentario girato da un regista cresciuto a Pisa, ma di madre materana e di padre londinese, Roan Johnson. Ha scritto anche un libro molto carino che si chiama Prove di felicità a Roma Est. Questo documentario tratta degli studenti universitari di Pisa, ragazzi tra i 20 e i 25 anni, e si chiama l’«uva migliore». Un ragazzo che studia agraria esordisce all’inizio del film dicendo: «Io ho studiato una cosa strana: quando la vite viene messa sotto pressione, o è in condizioni atmosferiche o di terreno difficili, fornisce l’uva migliore. Mi auguro che la nostra generazione, che è oggettivamente messa in grandissima difficoltà non per colpe nostre, possa fare come la vite, offrendo il nostro meglio». È una bellissima metafora. Noi viticoltori, della mia generazione, non dobbiamo usarla come scusa e non possiamo strangolare questa vite per obbligarla a dare l’uva migliore. Non siamo orgogliosi della condizione in cui vi abbiamo messo con il 37% di disoccupazione. Avete messo la barca in mare nel bel mezzo dell’uragano Sandy.
Queste riflessioni ci danno qualche speranza, perché se seguiamo il nostro Talento, usando Tempismo, Tolleranza, Testa e Tecnica in qualche modo ce la faremo. Sono pagine ottimistiche, molto rare quando si parla di giovani e di crisi.
Bisogna imparare a distinguere tra quelli che alla fine ti vogliono fregare e quelli che invece ti vogliono aiutare davvero. Qualcuno esiste, anche se la situazione è drammatica. I professori dovrebbero essere dei “minatori di talenti”, lavorandoci per farli emergere, perché vedere i propri studenti che sbocciano, è una grande soddisfazione, quasi egoistica. Ho cominciato questo lavoro con Montanelli e quando mi sono trovato a ringraziarlo lui mi ha detto: «Non devi ringraziarmi, perché mi hai consentito di dire di essere oltre che un grande giornalista, uno storico, un direttore di giornale, uno che capisce e riconosce un talento quando lo vede».
Avendo un’età che comincia per 2, mi sento coinvolta da questi argomenti e avendo messo la barca in mare durante la tempesta insieme agli altri ragazzi di Flanerí, vorrei provare con lei a ricostruire le nostre 8 parole, ma questa volta con la lettera P di Passione, che è quella che ci spinge a coltivare questo progetto. Mi aiuta?
Passione: di certo non vi manca, sennò non saremmo qui a parlarne, state facendo una cosa anche un po’ in controtendenza. Prospettiva: pensate che potrebbe diventare un lavoro. Pazienza: sarebbe la mia Tenacia, ricordate che i risultati non arrivano subito. Polso: bisogna essere solidi, ci deve essere un merito anche alla costanza. Principi: mi sembra che abbiate le idee molto chiare su cosa volete essere, le cose che volete e anche quelle che non volete. Personalità: siete diversi dagli altri, sennò fareste le cose che fanno tutti. Percorso: la strada è lunga e tortuosa, ma sicuramente porterà a cose buone. Potenziale: perché non sapete ancora che cosa può diventare questa cosa, però avete già capito che ha un certo potenziale. Ecco, abbiamo fatto dei ragionamenti seri, legati al progetto a cui tenete in un modo intellettualmente stimolante, facendo giocare le mie 8 T con le vostre 8 P.
«Voi non potete sognare, dovete farlo. Questo è l’unico ordine. Gli altri erano solo consigli».
Grazie Beppe, spero a presto!
(Beppe Severgnini, Italiani di domani. 8 porte sul futuro, Rizzoli, 2012, pp. 180, euro 15)