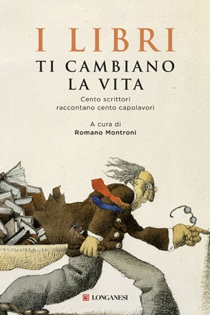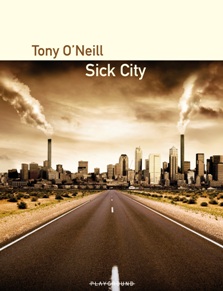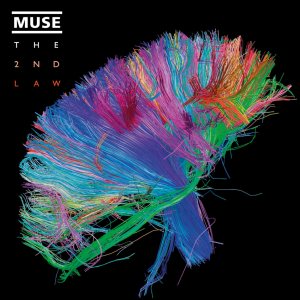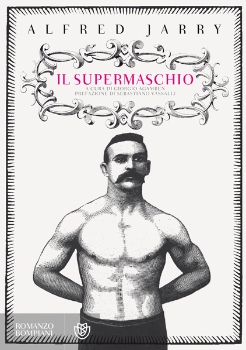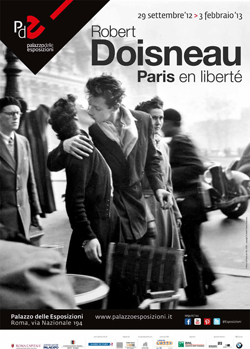Per narrare la storia un buon metodo è narrare storie. Concetto semplice, apparentemente banale ma, a considerare i palinsesti televisivi e teatrali, non così tanto. Le storie della storia sono scintille che illuminano la storia. Esattamente come i personaggi della vicenda narrata da Laura Curino. I personaggi di questa storia sono scintille che la illuminano. Due ragazze e una madre di una famiglia immigrata negli Stati Uniti d’America in cerca del grande sogno americano. La vita grigia che vi trovano diviene tuttavia la loro prigione. Queste vite, che somigliano alle migliaia partorite dal “sogno americano”, possono essere illuminate solo nel momento in cui la storia si inginocchi e forse si sieda per un attimo a contemplare lo sfacelo di ciò che può produrre l’uomo. Peccato che illuminare una vita grigia richieda il sacrificio di qualcuno. Questo qualcuno, in questo caso, è la donna. La donna di inizio ’900 diventa improvvisamente funzionale al capitalismo. C’è odore di contestazione in giro. La donna vuole un suo posto nella società. Che posto sia, ma con produzione. La donna richiede il riconoscimento sociale che la incatenerà alla logica produttiva allo stesso modo in cui incatenava l’uomo prima di lei. Una catena d’oro che potrà scintillare solo grazie alle grida di orrore di donne morte sul lavoro. È a questo punto che entrano in gioco le scintille che illuminano la storia con il loro dolore. Diciotto minuti d’inferno in una fabbrica di camicie illumineranno per un attimo la condizione delle operaie immigrate in America. Poi il buio. Perché la storia richiede sangue per parlare di verità. In mezzo emozioni e piccoli gesti di una vita quotidiana in cui le donne assumono tutta la concretezza del reale. Gettandosi nel vuoto o bruciando vive non muoiono personaggi storici della pagina stampata, ma donne con cui, tramite Laura Curino, abbiamo svolto un intenso percorso di vita. Una sola voce per tre personaggi, Laura Curino riesce nel difficile compito di addomesticare un testo che potrebbe facilmente portare allo sbilanciamento dei ruoli nell’intreccio. Il suo corpo sa reagire ai cambiamenti di personaggio con grande duttilità vocale e mimica.
D’altra parte appaiono limitate e talora retoriche le soluzioni registiche messe in scena da Laura Sicignano. Se da una parte la macchina per cucire riesce a dar forma alla scala d’emergenza dell’impianto industriale in fiamme, dall’altra è una chiosa non certo scintillante l’accendere un lume per le donne-scintille ormai spente. Allo stesso modo scarsa è la varietà introdotta dalle luci, che pure avrebbero un ruolo non secondario in una messa in scena fissa nello spazio e nel tempo. Retorica appare anche la supplica di non dimenticare la vicenda narrata rivolta al pubblico, posto nella posizione di quella storia che non ha esitato a osservare staticamente il sacrificio delle sue figlie. Questo momento spezza la tensione narrativa senza d’altra parte fornire altri strumenti allo spettatore. Un messaggio indimenticabile ha davvero bisogno di dirsi tale? Una scintilla che davvero illumini ha davvero bisogno di proclamarsi illuminante?
Scintille
testo e regia di Laura Sicignano
con Laura Curino