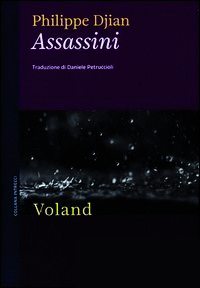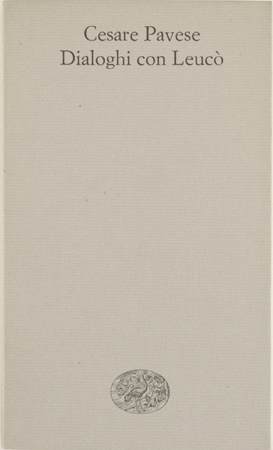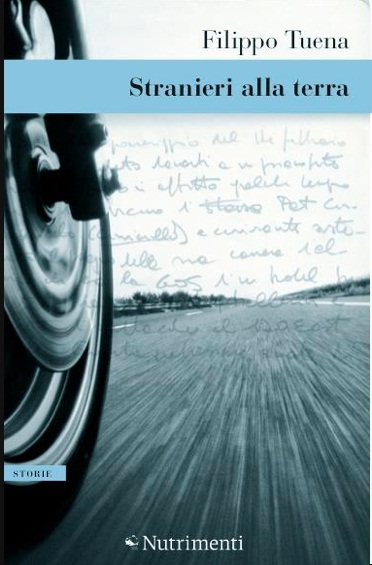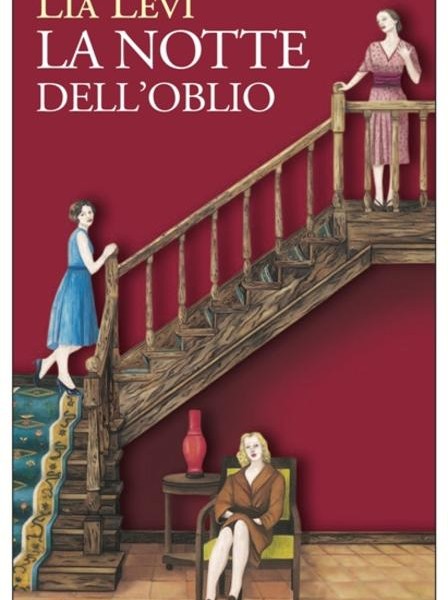«Le api vivono la loro vita senza chiedere nient’altro che quell’unica cella indistinguibile, dove sono nate, dove moriranno e dove saranno sostituite. L’ape vola senza essere libera. Per tutta la vita fino alla fine del mondo.»
Con sguardo da entomologo, Giovanni Di Giamberardino scruta le esistenze dai contorni sfumati dei personaggi, marcati stretti dalla solitudine e dalla morte, del suo romanzo d’esordio, già finalista al premio Calvino 2009 con il titolo che allora era ancora più bucolico (nel senso di virgiliano) di Aristeo e le sue api.
Ora le Edizioni Socrates lo ripropongono, come seconda uscita nella collana di narrativa breve Luminol, con il titolo, all’apparenza più ambiguo per chi non è apicoltore professionista, de La marcatura della regina, riferendosi a quella tecnica utilizzata dagli allevatori di api per distinguere dalle altre l’ape regina, marcandola con una goccia di colore indelebile e vivace, preferibilmente appena dopo essere stata fecondata all’inizio della primavera o dell’autunno.
Ma il romanzo del giovane scrittore romano non ha niente a che fare con gli ameni paesaggi e la semplice vita rurale di virgiliana memoria. Si tratta infatti di un noir italiano, anzi di ambientazione romana che dalle api riprende il principio costruttivo ad alveare, racchiudendo in ventiquattro celle, quante sono le ore di una giornata, i pensieri, le visioni e le ansie di personaggi di varia natura, dalla zanzara alla prostituta, dall’eroinomane al tassista separato con prole, da un medico legale a una cameriera, da un barbone alcolizzato a un nero bengalese, da un giardiniere a un commissario di polizia di cui non si sa quanto fidarsi. Nessuno è protagonista anche se tutti avrebbero le caratteristiche per divenirlo della propria storia tanto che i ventiquattro capitoli potrebbero benissimo essere considerati ventiquattro racconti.
C’è però un filo rosso come il sangue che li unisce tutti senza che questi si incontrino o meno: in qualche modo sono tutti testimoni diretti o indiretti dell’occultamento del cadavere di una donna assassinata, sembra sgozzata, e poi gettata in un cassonetto di via Nomentana a Roma, davanti all’ambasciata afghana. Sembrerebbe profilarsi addirittura un caso diplomatico ma in realtà il luogo del ritrovamento c’entra ben poco. La vicenda attira l’attenzione dei media anche per via di un video che gira su YouTube che lascia intravedere l’attimo in cui un uomo dal cappotto verde getta qualcosa di molto pesante somigliante a una persona nel secchione.
La marcatura della regina è però un noir sui generis perché le indagini rimangono a fare da sfondo alle vicende di esistenze ordinarie, di vite indistinguibile e interscambiabili proprio come le laboriose api che si aggirano in un’arnia-mondo, brutto, sporco e cattivo, artificiale e assetato del dolore altrui spettacolarizzato (Vespa docet) e razzista (primo indiziato è un extracomunitario).
In questo romanzo che la giuria del premio Calvino ha definito «una odierna sociologia della solitudine», la maestria del suo autore sta nel rendere, con frasi brevi e uno stile lucido e rapido nel passare da un registro all’altro, le inquietudini e le ansie, la solitudine e la sofferenza dei vari personaggi.
Il lettore passa da una vicenda all’altra in un vortice centripeto che porta verso quel corpo nudo gettato tra i rifiuti procedendo in una vera e propria peregrinatio mortis perché gli eventi, alla fine, come in ogni giallo che si rispetti, prenderanno una piega inattesa. Al termine della storia il dolce miele delle api si scioglierà nell’amara constatazione dell’inafferrabile ubiquità del dolore nell’esistenza umana.
(Giovanni Di Giamberardino, La marcatura della regina, Edizioni Socrates 2012, pp. 194, euro 9)