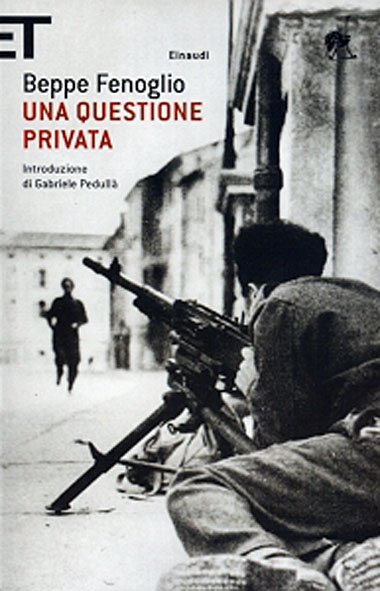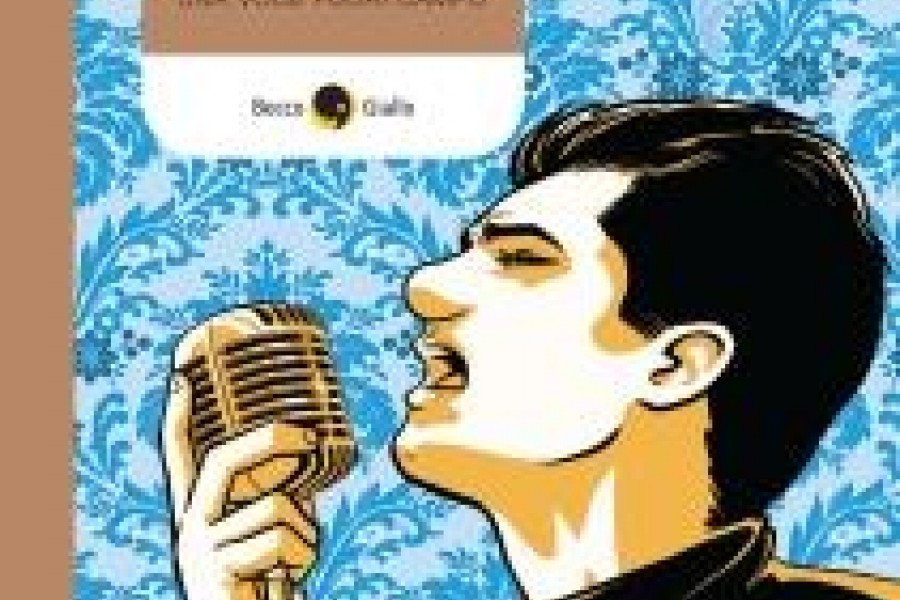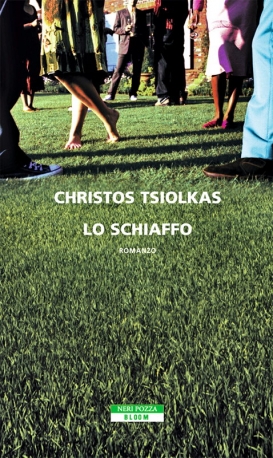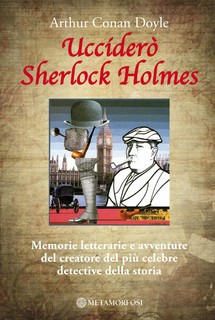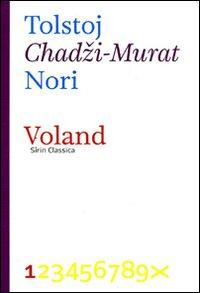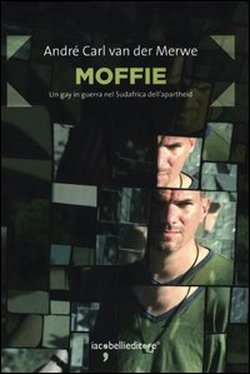«È questo, e forse l’otterremo in cielo, / attingere l’eccelso: / non lodi né vittorie, / soltanto essere ammessi / come parte di una Realtà innegabile, / come le pietre e gli alberi».
Come Gogol’, anche Borges si è interessato a suo tempo di cappotti, ed è a questi che Fervore di Buenos Aires deve forse parte della sua iniziale fortuna.
Infilando buona parte delle copie stampate della sua prima opera in versi nelle tasche dei cappotti appesi nell’anticamera della sede della rivista Nosotros, Borges diede inizio a una circolazione sfacciatamente e innocuamente clandestina che permise al testo di arrivare a molti interessati lettori di Buenos Aires. Un gesto in qualche modo di gentile avanguardismo per una poesia che delle avanguardie europee si è nutrita durante la sua gestazione.
Difatti il Borges del 1923, anno della pubblicazione di Fervore, reduce dell’esperienza europea, torna in patria con la volontà di ricongiungersi con la sua città: «Questa città che credevo il passato / è il mio avvenire, il mio presente; / gli anni vissuti in Europa sono illusori, / io sono stato sempre (e starò) a Buenos Aires». Un punto di partenza che segue probabilmente l’ideale convinzione borgesiana della ricerca di un principio – parziale, poiché individuale – necessario per poter seguire il proprio percorso ideale e poetico.
Parlare del primo Borges significa parlare anche di Ultraismo, movimento poetico debitore della poesia europea che coinvolge il giovane poeta in prima persona, ma da cui egli stesso si allontanò per seguire un percorso decisamente personale. Non a caso Néstor Ibarra, traduttore e amico del poeta, sarà il primo a dire che il periodo ultraista di Borges finì con le prime poesie ultraiste che scrisse.
Certo è che tracce di questa fase – in cui si compone poesia cercando di utilizzare come primo elemento creativo la metafora, veicolo di suggestione costruito e usato per evitare digressioni e aggettivazioni inutili – sono giunte anche in Fervore, ma per la maggiore sono da rintracciare in quelle poesie che Borges andò escludendo, anni più avanti, quando si accinse a «limare le asperità» nei suoi versi, dando poi alle stampe le edizioni revisionate dell’opera. Non bisogna però vedere questa operazione come una presa di distanza o come la negazione di un passato poetico-espressivo. C’è da tener presente invece che il periodo della prima poesia di Borges combacia con la certezza del bisogno di una ricerca linguistica, tematica e semantica tutta in divenire, che acquista di senso anche perché segue un percorso grazie al quale potranno nascere le tematiche tipicamente borgesiane che caratterizzeranno la sua scrittura. Non a caso, lo stesso Borges dirà che tutto ciò che scrisse dopo Fervore non è stato altro che lo sviluppo dei temi che lì aveva trattato per la prima volta, come se il resto della sua vita l’avesse passata a riscrivere quell’unico libro.
Consideriamo innanzitutto il tema della città. Il modo in cui Borges ci fa conoscere Buenos Aires è attraverso il ritorno a essa, alla Buenos Aires dei sobborghi, lontana dal rumore metropolitano, immergendosi nella realtà di quelle strade «quasi invisibili per l’abitudine» che dipinge nella sua prima poesia, “Le strade”. Diviene questo il punto partenza di quel lento processo di riappropriazione reciproca che avviene tra la città e il poeta, quasi come se entrambi ricominciassero lentamente a percepirsi e a riconoscersi.
Borges sfrutta il dato della ricongiunzione fisica con la città, mostrando come da questo si possa accedere al sentimento che i luoghi possono suscitare. Il sobborgo non è altro che «il riflesso del nostro tedio», fatto di quelle piazze e quelle strade che fanno da ponte per l’emotività dell’uomo che sente quei luoghi, uomo che qui è Borges ma che al tempo stesso è tutti gli uomini che vivono quegli isolati «differenti e uguali / come se tutti fossero / monotoni ricordi perpetui / di un unico isolato». E mentre la città spesso provoca una riflessione sul suo stesso essere – in poesie come “Il ritorno”, “Piazza San Martin”, “Un patio” o “Strada sconosciuta” – altre volte invece sarà dipinta dai versi quasi come in un quadro espressionista in cui le albe e i tramonti dominano lo spazio e scandiscono il tempo.
La Buenos Aires dei sobborghi non è soltanto quella del vissuto giovanile del poeta, quella da ritrovare, ma è soprattutto quella in cui può avviare il processo di mitizzazione personale e collettiva. È simbolo personale come anche traccia viva di un passato ancora sensibile dove è il patio, con il suo mostrarsi come tramite tra terra e cielo, forse uno dei simboli più forti di questa mitologia. «Il patio è il declivio/ per cui si spande il cielo nella casa./ Serena,/ l’eternità è in attesa a un crocicchio di stelle», i patios sono costruiti in armonia con l’universo e per essere da questo penetrati, mediatori o templi di divinità non dichiarate, «i patios così certi e antichi/ i patios che hanno fondamenta/ nella terra e nel cielo».
Il problema della lettura della poesia di Borges, e anche la sua bellezza, sta però nel non essere ferma al solo obiettivo della rappresentazione, e questo poiché segue la volontà di toccare una molteplicità di temi che si servono della realtà in primis come strumento allegorico, sfruttando soprattutto il suo potenziale metaforico. Borges, infatti, che ha dovuto anche affrontare problemi di cecità fin dall’infanzia, è stato spinto a guardare alle cose in una maniera via via sempre meno realistica, parlando sempre più per immagini o più esattamente attraverso simboli.
La città, che come abbiamo visto è tema poetico in Fervore, è anche cornice al cui interno il poeta inserisce in piccola parte anche il tema storico-politico (vedi “Rosas”, poesia che ritrae il dittatore argentino «famosamente infame / quel nome fu desolazione nelle case / idolatrico amore fra la gente gaucha / e orrore di morir sgozzati») poiché a questo tema lega particolari significati quale quello mitico-eroico della sua discendenza; tutto però assume un ruolo di secondo piano o semmai diviene funzionale all’intento filosofico che vediamo guidare la raccolta.
Quella di Borges è infatti poesia filosofica, ricca di riferimenti intertestuali che si esprimono attraverso una voce e un lessico immediati. Se la cecità ha impedito la penetrazione del suo sguardo nella realtà in maniera chiara, allora Borges capisce che può tentare la ricerca della rappresentazione di qualcosa di meno tangibile e osservabile, ma che della realtà è parte. Soprattutto il “tempo”, come categoria filosofica, è ossessione centrale perché, per Borges, questo contiene tutto ciò che esiste attorno all’uomo e attraverso il quale, usando un lessico borgesiano, l’umanità scrive il suo libro. Il tempo si lega inesorabilmente all’uomo perché in esso vive – e il verbo presente segue esattamente il punto di vista borgesiano – tutto ciò che l’uomo ha generato e, soprattutto, tutte le persone che è stato l’uomo.
Nel tempo il poeta è se stesso. Borges sa di essere Borges, come al tempo stesso sa di essere qualcun altro prima di lui; come Omero nel cantare del destino umano, come Dante a cercare la visione del tutto, come Whitman che dice “myself” e canta ogni uomo, come in una partita a carte un giocatore diviene quello che replica una mossa già compiuta: «E giacché le alternative del gioco / da sempre si ripetono, / i giocatori di questa notte / copiano antiche prese».
Bisogna allora immaginarselo, il tempo di Borges. Rinunciare a quella che diventa l’illusione del “qui e ora” creata dalla scansione degli orologi (come in “Fine d’anno”) e non tener conto della fine del vivere attraverso la morte, perché «è giusto aggiudicare all’ombra tali orpelli / e il marmo non dica quando tacciono gli uomini. / L’essenziale della vita terminata / – a tremula speranza, / il miracolo implacabile del dolore e la sorpresa del piacere – / continuerà per sempre. / Reclama ciecamente permanenza l’anima arbitraria / giacché le vite altrui gliel’assicurano, / giacché tu stesso sei la replica e lo specchio / di quanti non raggiunsero il tuo tempo / e altri saranno (e sono) la tua immortalità su questa terra».
Fervore di Buenos Aires ha un ruolo capitale all’interno dell’opera di Borges, quello di farci conoscere quei simboli che saranno poi tipici nella sua scrittura (come il labirinto, lo specchio o il libro), e che a questa sua bùsqueda del tempo sono rivolti soprattutto per i significati e i concetti che gli attribuirà.
Borges attraversa questa ricerca del senso del tempo e del vivere che risiede in esso: «Vibrante nelle spade e nell’ardore/ e assopita nell’edera,/ solo la vita esiste./ Sono sue forme spazio e tempo,/ sono strumenti magici dell’anima,/ e quando questa si spegnerà,/ si spegneranno insieme spazio, tempo e morte,/ come al cessare della luce/ si estingue il simulacro degli specchi/ che l’imbrunire aveva quasi spento». È così perché il tempo di Borges è anche quello di Schopenhauer e di Berkeley («Nella profonda notte universale / che a stento contraddicono i lampioni […] Attento all’ombra / e intimorito dalla minaccia dell’alba / rivissi la tremenda congettura / di Schopenhauer e di Berkeley / che afferma essere il mondo / un atto della mente / un sogno delle anime, / senza base o intenzione o volume»), dove la vita si mostra all’uomo con le cose, attraverso il tempo, finché delle cose si avrà ricordo, contatto mentale, anche il solo saperle nominare; mentre invece senza la percezione del tutto, il tutto svanisce e anche la morte smette di esistere. In quest’ottica anche il sogno, altro tema di grande rilevanza che lo ha lungamente impegnato, acquista con Borges una particolare capacità, quella di confondersi o mischiarsi con la realtà come se in essi non ci fossero separazioni o differenze, poiché davanti agli occhi così come nel sogno «sono l’unico spettatore di questa strada; se smettessi di vederla svanirebbe».
Quello che si potrebbe dire è che il tempo serve a Borges per raccontare, come Borges serve al tempo per raccontarsi. Il suo è un racconto comunque aperto ai sentimenti che nutre e che riscopre nel momento in cui percepisce quella realtà, poiché, se questa ha valore in quanto risultato del tempo, allora vorrà dire che sarà la sua memoria a rivestire il ruolo fondamentale nel dar senso a ciò che sta vivendo nella ritrovata Buenos Aires. Se la memoria è ciò che porta fuori i punti su cui Borges struttura il suo discorso, sarà sempre da questa che si partirà per il recupero di qualcosa di perduto ma di ancora percepibile, come l’amore.
Buenos Aires è anche il luogo in cui Borges conosce Concepción Guerrero – a cui probabilmente molte delle poesie di Fervore fanno riferimento – primo grandissimo amore che sarà destinato poi a vivere in quel ricordo che animerà le poesie della raccolta. Anche in queste è interessante notare come sia il tempo a scandire il modo in cui si esprime il sentimento, con il suo mostrarsi attraverso la memoria e attraverso il confronto con la realtà, perché è la memoria a dar sostanza al tempo.
La solitudine si esprime attraverso le immagini di una città che acquista sempre più valore simbolico ed evocativo. In tutti i luoghi «come ciechi si cercano le nostre solitudini», e l’assenza è soltanto una condizione, qualcosa che determina lo stato esteriore delle cose poiché c’è nella realtà più di un segno che ridona vita a ciò che si è perso ma che non rinuncia a “essere”. In “Assenza” appaiono i segni dati dalla persistenza delle cose nel tempo e nella memoria, capaci anche di determinare il proprio futuro («Dovrò di nuovo erigere la vasta vita, / specchio di te ancora», «Sere che ti hanno accolto come nicchie, / musiche dove trovavo te ad attendermi, / parole di quel tempo, / dovrò distruggervi con queste mani. / In quale baratro potrò celare l’anima / perché non veda la tua assenza, / fulgida come un sole orribile / che non tramonta mai, spietata, eterna?»), e il contatto con la realtà non spezza ma anzi aggiunge consapevolezza all’amore dal momento che il ritorno significa poter rivivere ciò che altrimenti non potrebbe essere vissuto: «Nel nostro amore c’è una pena/ che assomiglia all’anima. / Tu, / ieri soltanto tutta la bellezza / sei anche tutto l’amore, adesso».
Contenere tutto questo non lo può semplicemente un libro, e forse è per questo che Borges ha sempre avuto la convinzione di non aver fatto altro che riscrivere per tutta la vita Fervore di Buenos Aires. Ma anche se questa fosse una delle verità dell’esperienza poetica di Borges, bisogna accorgersi che alla base sta la semplicità con cui il percorso si è generato: «Il cancello del giardino / si apre arrendevole come la pagina / che una frequente devozione interroga / e dentro non occorre / che lo sguardo si fissi sugli oggetti, / precisi già nella memoria».
Sembra difficile parlare di Borges se non con le parole di Borges. Forse questo però dipende dal fatto che con Fervore di Buenos Aires egli non fa altro che farci arrivare alla consapevolezza che quelle sue stesse parole avremmo potute utilizzarle noi, ed essere quindi altri Borges, se l’ironia del caso non avesse voluto diversamente. Ed è quello stesso caso che ha voluto Borges come padre dei versi che leggiamo e non noi, che siamo invece destinatari, eventuali e fortuiti, come ci dice nel prologo «All’eventuale lettore: Se le pagine di questo libro offrono qualche verso felice, mi perdoni il lettore la scortesia di averlo usurpato io per primo. I nostri nulla si differiscono poco; è banale e fortuita la circostanza che di questi esercizi sia tu il lettore e io il redattore»; ed è ancora lo stesso caso che adesso, come allora, ci fa scoprire, controllando le tasche del cappotto, lo scherzo del caso e di Borges.