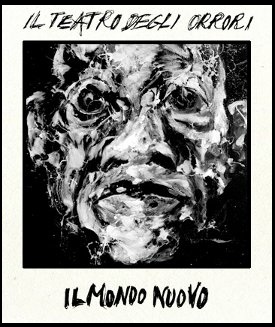Mi chiamo Giancarlo. Sono un ingegnere di trentanove anni. Lavoro per una società di quelle satellite, cioè per una società che lavora per un’altra società più quotata che lavora a sua volta per un grande cliente statale, o per dirla diversamente: lavoro per una delle terze parti di una multinazionale aggressiva che ha in appalto un progetto ministeriale. Potrei continuare per ore a cercare di ridefinire il mio lavoro senza aggiungere nulla. La cosa importante è che il vecchio manager è sparito da un mese, si dice che sia in Tibet in ritiro spirituale. Troppo stress o forse un’offerta migliore. Nel mio lavoro succede spesso che le persone spariscano da un giorno all’altro. Il brutto è che riusciamo a vivere la notizia senza eccessiva partecipazione. Diciamo che l’indifferenza è forse la caratteristica più marcata della consulenza. Insomma, tornando a me, non faccio il mio vero mestiere: all’università ho studiato il sistema per innalzare ponti, costruire canali d’irrigazione e ricordo ancora tutte le virtù del cemento armato, ma adesso mi ritrovo a fare l’impiegato nell’universo informatico. Cioè ho gli occhi arrossati che guardano il mio personal computer IBM per dieci ore al giorno.
Cosa faccio?
Aspetto…
Cosa aspetto?
Aspetto che “girino” programmi infiniti che rimescolano dati.
Sì, ma cosa faccio?
Aspetto.
È davvero un circolo vizioso. Aspetto… aspetto che le ore scorrano senza misericordia. Se mi dice male alla fine succede una catastrofe, due o tre signori con la cravatta vengono da me. Hanno studiato quando ancora si usavano i cavalli come mezzi di locomozione. Hanno il telefonino dell’ultima generazione nella tasca della giacca sopra la camicia con le iniziali, ma non trovano il tasto per rispondere alle chiamate. Ebbene questi personaggi vorrebbero sapere un “compenso”, un “consuntivo”, un “fatturato”. Sono il loro oracolo, faccio previsioni di Business Intelligence e non smetto di tenere il naso sul PC per due giorni di seguito nel tentativo di capire cosa stia facendo veramente. D’altra parte, se mi dice bene lavoro dieci minuti la mattina e poi, invece di decifrare il sudoku del quotidiano o scambiare messaggi on-line con quarantacinquenni in menopausa che fingono di avere venticinque anni, come molti miei colleghi fanno, beh io leggo su internet le poesie di Walt Whitman:
O me! O vita! Domande come queste mi perseguitano,
D’infiniti cortei d’infedeli, città gremite di stolti,
Io che sempre rimprovero me stesso, (perché più stolto di me, chi di me più infedele?)
D’occhi che invano anelano la luce, scopi meschini, lotta rinnovata ognora,
Degli infelici risultati di tutto, le sordide folle ansimanti che in giro mi vedo,
Degli anni inutili e vacui degli altri, e io che m’intreccio con gli altri,
La domanda, ahimè, che così triste mi persegue – che v’è di buono in tutto questo,
o vita, o me?
Risposta.
Che tu sei qui – che esistono la vita e l’individuo,
Che il potente spettacolo continua, e che tu puoi contribuirvi con un tuo verso.
Di versi non ne ho trovati molti tra i corridoi dritti e stretti del palazzo cubico dove lavoro. In compenso ho conosciuto prima e sposato poi una “donna agenda”. Mia moglie è il nuovo manager del progetto, dopo che il vecchio è sparito, e io non ho alcun rispetto per l’autorità. Non ne ho mai avuto e oggi meno che mai, soprattutto sto perdendo la speranza e il rispetto di me stesso. Ricordo tutto fin troppo nitidamente: ero stufo di faticare a trovare uno scopo, e m’illusi di raccogliere il significato della mia vuota esistenza sulle scale. Era bellissima, ma era anche il mio capo. I capelli corti, gli occhiali con la montatura scura appena poggiati sul naso, il fisico snello e sensuale, il profumo delle gerbere in un lago. Erano le 21.15 di un lunedì piovoso. Piangeva sulla rampa di scale del secondo piano, eravamo ancora a lavoro. Quando le sono passato accanto non ho resistito, credendo che fosse una persona diversa dalle altre. Non mi aveva nemmeno sfiorato l’idea che ero ancora lì per un ordine che lei s’era ricordata di infliggermi all’ultimo minuto. Per l’intero pomeriggio avevo guardato le nuvole annerire la volta celeste e poi mi era toccato rinchiudermi fino a notte fonda per una delle solite “catastrofi”. Le avevo chiesto se voleva una mano. Mi aveva confidato di essere in dolce attesa, di un uomo sposato e che non amava. Mi diceva che era ormai al terzo mese di gravidanza, di colpo aveva paura della vita: per la prima volta aveva paura della sua vita. Mi parlava di lenzuolini, di dover colorare di nuovo le pareti di una stanza vuota, mi diceva che ce l’avrebbe fatta, e che avrebbe smesso con .xls, .ppt, .prj. Allora credevo che fosse sincera. Oggi posso aggiungere amaramente di essere stato un ingenuo e di essere diventato un cinico. Sembrava davvero convinta di parlare delle problematiche che ha una famiglia, sembrava capace di essere comprensiva, dolce, e non invece una delle tante che incontravo a lavoro, una di quelle che ti inseriscono tra una lezione di Yoga e un’uscita a teatro, che ti fanno sentire un “aperitivo” mentre loro assomigliano tanto a… un’agenda.
Sì, ho sposato una donna agenda: una fitta rete di spazi bianchi da riempire con attività disparate, curiose, avventurose, inutili forse, ma soprattutto frenetiche attività. Donne che si auto-definiscono single, ma si ritrovano col compagno, l’amante, l’autista, il marito. Donne che segui a fatica, soprattutto se tu hai molto tempo, se ti piacciono le passeggiate lunghe e non parli troppo, ma vorresti ascoltare. Queste donne sono abituate a flussi di dati considerevoli, cascate, valanghe di informazioni, hanno tre cellulari, due portatili, sono capaci di iniziare il sabato mattina andando di corsa a lezione di pianoforte, fare la doccia in palestra, cambiarsi, suonare il primo movimento di una sinfonia di Chopin, tornare in palestra, cambiarsi di nuovo, fare una lezione di full-contact, rilassarsi con una sauna, sopravvivere con una carota, inforcare gli occhiali da sole d’inverno in un giorno di pioggia, telefonarti mentre salgono in macchina e poi incontrarsi con le amiche per un pomeriggio di shopping. Tutto rigorosamente annotato sulla loro inseparabile agenda. Così nel sabato fitto di impegni tu sei una voce, diventi lo striminzito momento di pausa, la tregua dalle fatiche di una corsa veloce. Credevo che mia moglie fosse diversa, ma era il mio capo in ufficio, ora lo è diventato anche a casa. È capace di arrabbiarsi in una riunione e di organizzare già il lavoro di una settimana; speravo che avesse capito che non contava l’etichetta di un vino pregiato, ma che fossero importanti la famiglia, il senso materno, la dolcezza!
Non so bene come, né precisamente quando, so solo che in uno di quei modi in cui un venditore di auto usate ti rifila un catorcio facendoti credere che sia una fuoriserie, ebbene… alla fine la famiglia e compagnia bella, le poppate, i ruttini, le pappine, i bagnetti, l’asilo, la scuola elementare, tutto si è incastrato perfettamente, per ispirazione divina, manco a farlo a posta, in modo organizzato e preciso, tutto è finito sulla sua agenda nuova. Un’agenda elettronica. Ironia della sorte. Di qui la mia frustrazione irrisolta. Mi tocca dividere il letto con il mio capo, due gemelli maschi piccoli, modello elementari nella stanza accanto che fanno partite di calcio nel salotto. Unisco tutto al fatto di aver smesso di fumare e penso di essere diventato vittima di una mutazione genetica. Chiamo il mio male frustrazione, a volte disillusione, ma il sostantivo migliore è decisamente “sconfitta”, l’aggettivo che l’accompagna egregiamente è “vigliacca”. Non mi arrabbio mai. Sconfitta vigliacca!, ripeto tra me sommessamente e amaramente. Sfogo il mio istinto, perché si deve sfogare il proprio malumore fisico in qualche modo, aprendo il frigorifero di notte, a mezzanotte in punto per esempio. Peso 125 kg. Avevo deciso di scrivere una pagina al giorno nel tentativo di dimagrire, la fame era diventata inarginabile. Avevo preso questa decisione, guardando la curva che la mia cravatta rossa disegna sul mio profilo. La giacca blu mi stava stretta sulle spalle. I pantaloni stavano per esplodere. Avevo deciso di scrivere quando i morsi della fame si facevano più forti, quando le poesie non bastavano più, come adesso. Ma poi ho avuto la strana idea di rileggere tutto. Di capire che non potevo essere certo come Proust e che ero rimasto dieci minuti a vagare nel corridoio di fronte alla stanza G317, e volevo addentare un gianduiotto. Ma ho resistito. Pensavo a mia moglie. Stava nella stanza G316 dello stesso piano. Lei è norvegese da parte di padre, italiana da parte di madre. Ha il cognome impronunciabile come Mazinga e… Che diavolo! Stava annotando con il pennino elettronico l’ultimo appuntamento sulla sua agenda, proprio mentre io indugiavo sulla la seconda pagina del mio diario, la più difficile di tutte.
Un brivido mi ha scosso. È stato freddo. È stato duro. Potevo diventare anch’io un uomo diario!? Il colmo! Di qui una risata fragorosa e forte come lo scoppiettare d’ali di una colomba e la decisione copernicana di lasciare che le mie ansie e soprattutto la mia indole vigliacca mi costringessero a qualcosa di meno artistico della letteratura….
Lei si è voltata, chiedendomi a bruciapelo:
«Cosa stai pensando?»
«A niente. A parte che sei davvero dolcissima, ho mentito».
«Sciocchino!»
Mi ero salvato, ma da allora e da quell’ultimo mio pensiero ho deciso di non andare più oltre sul sentiero della parola scritta. Così, frugando a lungo sotto i miei riccioli neri, affondando le dita nell’oceano della mia testa cespugliosa, arrivando fino alla fronte larga e piana, ebbene ho deciso di dedicare il mio tempo libero a qualcosa di più logico e interessante del racconto della mia vita: il fantacalcio.