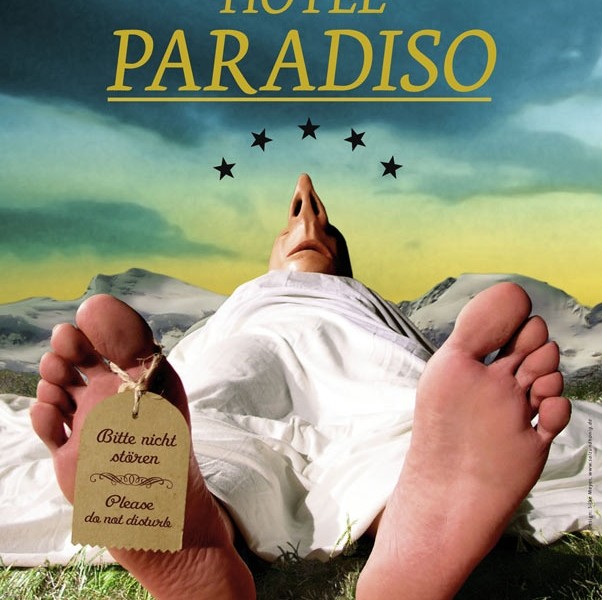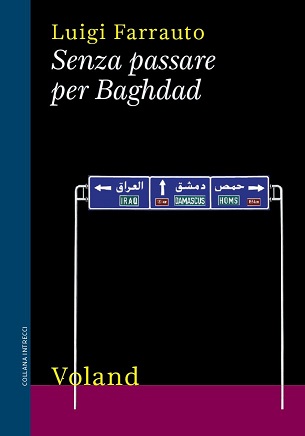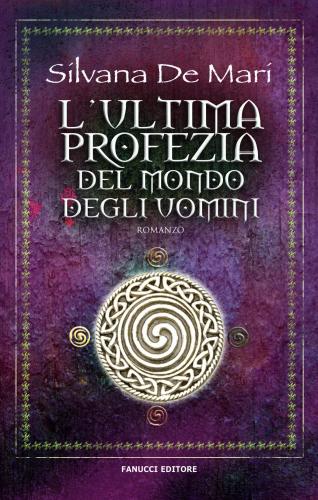Abbiamo intervistato per voi Otello Marcacci, autore di Gobbi come i Pirei, un romanzo divertente ma al tempo stesso capace di commuovere e far riflettere. Ecco che cosa ci ha raccontato.
Leggendo Gobbi come i Pirenei si prova quello che Pirandello definiva «il sentimento del contrario», ciò che distingue l’umorismo dal comico: come nascono la storia e ilpersonaggio umoristico di Eugenio Bollini?
È come se lei, davvero, avesse capito tutto del romanzo. Questa domanda ne è la riprova. Durante le presentazioni che facciamo per promuovere il libro molto spesso parlo proprio del saggio di Pirandello sull’umorismo. E anche di quello di Henry Bergson, prima di lui, sulla comicità. Secondo il filosofo francese la comicità è il castigo sociale con cui la comunità individua, respinge e corregge una serie di comportamenti percepiti come contrari allo slancio vitale con cui si identifica la vita stessa. Il riso corregge comportamenti che metterebbero in pericolo la sopravvivenza della specie. Nella comicità viene bandita l’empatia. Un’anestesia momentanea del cuore, dove non c’è alcuna identificazione. Per Pirandello invece, nell’umorismo, c’è una riflessione ulteriore che porta a un sentimento di identificazione e compassione della persona di cui ci si prende gioco. Gobbi come i Pirenei gioca molto su questa dualità comicità-umorismo. Ho tentato cioè di mettere il lettore di fronte a una serie composita di situazioni lasciandolo libero di scegliere quali per lui siano, di volta in volta, l’una o l’altra cosa. E cosa invece sia ironia, che è ancora diversa. A seconda di quale parte adotterà, lui stesso sarà in grado di capire, semmai lo volesse, a quale categoria del consesso umano appartiene. Eugenio Bollini ad esempio è inglobato in quella degli anti-eroi moderni. Uno di quelli che può vincere le battaglie della vita solo perdendole. Bollini erano molti anni che cercava di parlarmi affinché raccontassi la sua storia. Come sosteneva Calvino «la fantasia è un luogo dove piove dentro» e alla fine quando la pioggerella è diventata diluvio e rischiavo di annegare e non ne potevo più di sentire Bollini che mi supplicava di parlare di lui, allora mi sono arreso e ho deciso di assecondarlo. Ed eccoci qua.
Uno dei punti di forza del romanzo, a mio parere, è la facile tendenza a identificarsi con il protagonista. Credo che più o meno tutti, da adulti, ci siamo scontrati con la disillusione delle nostre ambizioni infantili. È proprio quando diventa consapevole di ciò che Bollini trova la forza di dare una svolta alla sua vita. In che modo, senza svelare troppo la trama, il suo personaggio affronta questo disagio?
Su questo punto non sono completamente d’accordo. Sull’arrivo della disillusione probabilmente ha ragione. Capita più o meno a tutti, ma la presa di coscienza di chi realmente siamo rispetto a ciò che credevamo essere, la scoperta e l’accettazione dei nostri limiti, che poi è uno dei leitmotiv del romanzo è tutt’altro che scontata. Presuppone una sensibilità molto sviluppata e un’intelligenza per rielaborarla non banale. Conosco tanta, troppa gente, che si crede matura ed equilibrata e che ancora oggi è convinta di avere qualità che nemmeno la loro madre sarebbe più disposta a riconoscergli. Io stimo ancora, però, solo coloro che invece cominciano a fare i conti con il fatto che “l’ipertrofia dell’io” è, per i bipedi umani, una jattura paragonabile a ben poche altre sciagure. E fare i conti con se stessi genera momenti, allo stesso tempo, drammatici e catartici.
Ed è proprio ciò che capita a Bollini che si trova a convivere con una mente e una sensibilità di grande spessore da un lato e con una vita non all’altezza dei denari che la Natura o Dio Onnipotente se si crede, gli ha donato, dall’altro. Il dramma si concreta nel percepire la quasi totale inutilità di tutto ciò che può realmente fare per modificare la sua realtà. Un po’ come essere incastrato in un’immensa sabbia mobile dove stai andando inesorabilmente a fondo ma dove anche, se ti muovi per cercare di uscire, muori ancora prima di quanto capiterà se invece stai fermo e non fai niente. La catarsi invece sta nella presa di coscienza che, incredibile ma vero, la vita offre “second chance” a tutti, prima o poi. Insomma, la ruota gira. E forse, avendo preso piena e reale coscienza di sé, si può anche provare a morire con onore. Con dignità. Perché la cosa peggiore, il vero peccato mortale, non è davvero morire dentro le sabbie mobili della vita, quanto non aver nemmeno provato a metterci tutto il cuore per cercare di evitarlo.
Non crede che Gobbi come i Pirenei possa essere considerato anche un romanzo di formazione? In fondo Eugenio Bollini, nonostante non sia più tanto giovane, compie un processo di maturazione, è d’accordo?
Ah beh certamente, senza dubbio. In Bollini esiste un umanesimo che lo porta verso una formazione armonica di tutte le sue forze fisiche e spirituali attraverso un processo di sviluppo e di crescita che rappresenta il risultato di un incontro tra una legge interiore che alberga dentro di lui e le circostanze del mondo esterno. Si rappresenta in altre parole questo processo di maturazione di cui parlava lei, un’evoluzione che continua imperterrita nel tempo e non ha mai fine, come capita a chiunque abbia la capacità di guardarsi dentro senza avere, al contempo, totale disgusto di se stesso né un amore folle narcisistico. Del resto mi affascinava anche il linguaggio e come si evolve la comunicazione. In fondo il compito del romanzo, secondo me almeno, è raccontare il mondo. Uno spazio di riflessione dove porsi domande e cercare di azzardare risposte. Io come scrittore esprimo quello che sento l’urgenza di dire e non posso bluffare. In altre parole a me piace prendere un pezzo di mondo e trasformarlo aggiungendoci qualcosa che nel mondo non c’è. E anche come lettore ogni romanzo vorrei fosse romanzo di formazione. Vorrei in soldoni arrivare in fondo all’ultima pagina e rendermi conto che quel particolare libro è riuscito a spostare il mio punto di vista e che grazie a lui riesco a vedere le cose in modo diverso, finanche opposto. E spero con tutto il mio cuore che Bollini possa aver avuto quest’effetto nei tanti suoi amici che lo hanno letto con amore e passione.
Il suo romanzo è stato pubblicato da Neo Edizioni, giovane (in tutti i sensi) casa editrice indipendente lontana dalle logiche delle grande distribuzione. Come è avvenuto l’incontro con questa casa editrice?
Neo Edizioni è una casa editrice speciale. Unisce una qualità incredibile di cose prodotte (a parte il mio libro s’intende, che, capisco, potrebbe far pensare a ragione all’ignaro lettore, l’esatto contrario di quanto ho appena detto) a un’attenzione particolare sia verso il lettore stesso che verso l’autore. Al contrario delle grandi case editrici nazionali ripone molta attenzione agli scrittori emergenti o anche proprio esordienti tout court, scegliendo con attenzione maniacale e certosina le cose da pubblicare. Li ho sempre seguiti con interesse e quindi è stato facile mandar loro il manoscritto e, confesso, sono stato molto sorpreso e titubante quando mi hanno detto che avrebbero voluto pubblicarmi perché, proprio come diceva Groucho Marx, citato da Bollini in Gobbi «non vorrei mai far parte di un circolo che accettasse tra i suoi soci un tipo come me». Però alla fine mi hanno convinto facendomi ubriacare di Genziana. Sono stati fortunati, se la sono cavati con poco, sono un tipo facile. Quello che non sanno ancora è che, adesso che ne sono diventato dipendente, dovranno continuare a riempirmi la cantina ogni anno di quel nettare.
In ogni caso la piccola editoria indipendente va salvaguardata con qualsiasi mezzo anche se di fondo rimane l’annoso problema della distribuzione che è atavico in tutte le case editrici medio-piccole. La vera differenza tra un editore e un autore è che il massimo della vita per il primo sarebbe vendere una sola copia di un libro a uno sceicco arabo a 30 mila euro per massimizzare il profitto. Qualsiasi autore, invece, vorrebbe vendere 30 mila copie del suo libro a 0,01 cent, perché tutto ciò che chiede è di essere letto. Questo sistema di distribuzione non consente di soddisfare né le esigenze del primo, né quelle del secondo. Amen.
Avremo un seguito o le avventure di Bollini terminano qui?Quali sono i progetti futuri dello scrittore Otello Marcacci?
Con la pubblicazione di Gobbi come i Pirenei è avvenuta una cosa che non mi sarei mai aspettato. Il passaparola ha davvero funzionato molto bene e la tendenza a identificarsi con Bollini, come diceva giustamente lei poc’anzi, ha portato il libro a vendere moltissime copie nonostante la carente distribuzione di cui parlavamo. La cosa ancora più stupefacente è che, sin dai primi giorni dell’uscita, ricevo settimanalmente mail di lettori che, oltre a farmi del tutto immeritate lodi, mi chiedono in continuazione di raccontargli che fine ha fatto Eugenio Bollini. Insomma, la domanda è sempre la stessa: «E poi…?» Con appresso: «Ti prego, non puoi non dircelo!»
Inizialmente, quando scrissi il romanzo, non avevo programmato un sequel ma, quest’anno, sono state troppe le voci che mi hanno chiesto di raccontar loro che cosa fosse successo al loro caro Eugenio e alla fine ho pensato che sarebbe stato un vero e proprio tradimento all’incredibile affetto che nutrono per Bollini tutti questi nuovi amici, se non li avessi accontentati. E così il sequel tanto richiesto è stato finalmente partorito perché mi è piovuto dentro com’è stato per la prima volta. Quell’impiastro di Bollini ha preso possesso della mia testa che ha usato come mansarda e mi ha obbligato a raccontare la sua seconda storia. Adesso però arriva la parte più difficile, si tratta di trovare un editore che decida di pubblicarlo. Se qualcuno che legge questa intervista fosse interessato si faccia pure avanti e farà felici un nugolo di folli visionari che tanto amano il mio amico anti-eroe.
Prima però uscirà il mio secondo romanzo. Piccolo scoop che le regalo perché lei cara Chiara Gulino ha capito tutto di Gobbi come i Pirenei e ho deciso che fosse proprio lei la prima a sapere del secondo.
Il titolo è Il ritmo del silenzio e sarà edito da una giovane casa editrice romana. Il libro sarà in libreria credo a maggio 2012. In questo nuovo romanzo ho voluto raccontare la storia di una grande amicizia che va oltre le barriere del tempo, ma anche giocare con il concetto di tempo stesso, provando a mostrare come esso possa scorrere, in tutte le direzioni, avanti e indietro, sia velocemente che al rallentatore. Provando, in altre parole, a dimostrare, in modo letterario (si fa per dire), l’assunto di Einstein, secondo cui il tempo stesso è come un fiume dove il passato, il presente e il futuro, scorrono ed esistono contemporaneamente. Spero che i miei lettori e gli amici di Bollini trovino questa nuova storia interessante quanto la prima.
Infine, può dirci i titoli di tre libri che vorrebbe non mancassero mai nella sua libreria?
Questa è la domanda più difficile di tutte. Per prima cosa però voglio dirle che non credo che sia possibile avere solo tre libri guida imprescindibili. E poi penso anche che gli stati d’animo di un essere umano cambino in continuazione in funzione delle sue nuove esperienze di vita. Come dicevamo prima riguardo Bollini, ogni uomo che si possa definire tale è in continua formazione, non smette mai di evolversi. La risposta che le darò adesso quindi deve necessariamente tener conto di questa piccola premessa. Vale a dire, accetto il divertente gioco che mi propone ben sapendo tuttavia che rimane da un lato un gioco, nel senso che non è esaustivo di come Otello Marcacci è oggi e dall’altro pure ben consapevole che forse domani, se fossi chiamato a rispondere di nuovo, potrei scegliere altri libri perché magari l’esperienza di vita di quest’intervista o che so, l’aver incontrato una persona nuova mi ha fatto cambiare idea su quello che le sto per dire.
Il primo libro che non abbandonerei mai è Il giovane Holden di Salinger. Un po’ come dire che mi piace la cioccolata, me ne rendo conto. Insomma il capolavoro assoluto del ventesimo secolo non si può proprio non averlo in libreria.
Il secondo è Ghiaccio-Nove di Kurt Vonnegut per cui ho una venerazione quasi maniacale. So bene che Kurt è un tipo che fa incazzare gli esteti che considerano le sue trovate strampalate e assurde, ma il suo genio assoluto viene fuori proprio così. Lui inserisce dati bislacchi e apparentemente senza significato o importanza che si accumulano. E alla fine c’è qualcosa che rimette insieme tutto, una luce improvvisa che dà al tutto dei colori seducenti e del tutti unici. Per me il numero uno.
Il terzo è In fondo alla palude di Joe Lansdale, che se fossi omosessuale vorrei sposare perché è la ragione del perché Dio ha creato gli scrittori. Un uomo in grado di appassionare alla lettura anche persone che in genere leggono solo fumetti. Quando va bene. So che molti lo considerano di serie B. Trash. Letteratura minore. Ma guarda caso sono proprio coloro che scrivono libri illeggibili, inutili e dannosi alla salute, in cui arrivi a pagina dieci e già ne puoi più ad andare avanti.
Ah, dimenticavo, nella mia libreria non potrebbero mai mancare Gobbi come i Pirenei e pure Il ritmo del silenzio perché ogni scarrafone è bello a mamma sua.
Ciao.
Leggi la recensione di Gobbi come i Pirenei su Flanerí.