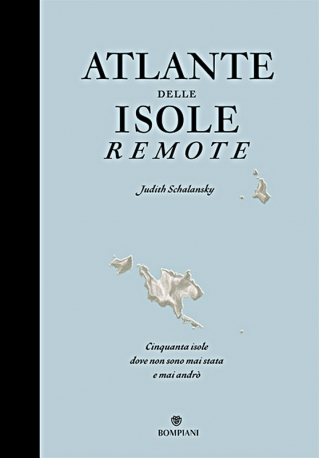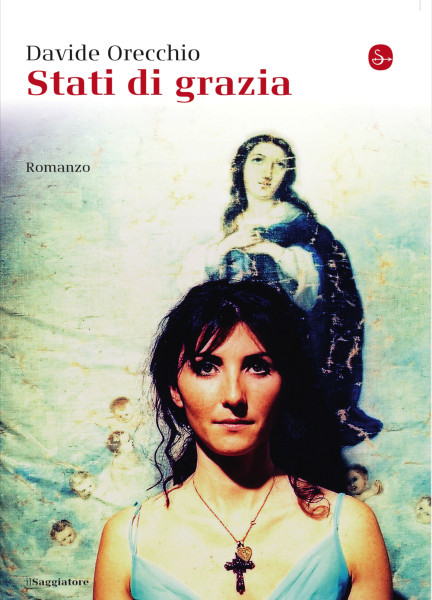Avere ottantaquattro anni e avere ancora tanta voglia di mettersi alla prova. È il modo più rapido per descrivere Clint Eastwood che torna al cinema come regista e produttore di Jersey Boys, commedia musicale tratta da un musical di successo di Broadway.
Frankie è un garzone di barbiere in un paesino del New Jersey poco lontano da Newark. Ha una voce incredibile per cui stravede il boss locale Angelo “Gyp” De Carlo, che lo incoraggia a cantare e lo difende ogni volta che finisce nei guai. Nel New Jersey di quegli anni le possibilità per un ragazzo di uscire dal confine della periferia sono: arruolarsi nell’esercito e rischiare di morire, entrare nella mafia e farsi ammazzare, oppure diventare famoso. Lo dice Tommy, amico di sempre di Frankie che gli dà un’opportunità musicale facendolo entrare nella sua band. Lentamente arriva il successo, grazie all’ingresso del tastierista e autore Bob Gaudio che scrive tre pezzi da prima posizione in classifica di fila. Frankie e i Four Seasons diventano famosi, ma qualcosa si rompe tra rivalità interne e problemi di debiti.
Frankie Valli e i Four Seasons esistono realmente. Hanno avuto un grosso successo con pezzi come “Walk Like a Man” e “Big Girls Don’t Cry”, poi Valli ha proseguito come solista incidendo la famosissima “Can’t Take My Eyes Out of You” e il brano di punta del musical Grease. Negli Stati Uniti sono ancora famosissimi. Valli è apparso in due stagioni dei Soprano (era Rusty Millio), hanno la stella al Walk of Fame e tutto il repertorio. Nel 2005 Valli e Gaudio hanno deciso di fare un musical dalla loro storia. È venuto fuori Jersey Boys che ha aperto la stagione di Broadway con un grande successo. Come sempre più spesso succede, il consenso di pubblico ha spinto a farne un film. È strano che il progetto sia finito tra le mani di Clint Eastwood. La passione di Eastwood per la musica è cosa nota ed è già stata al centro di tanto suo cinema (Bird, Honkytonk Man e il documentario del 2003 Piano Blues), ma la storia dei Four Seasons appare lontana dalla sua idea di musica, più orientata verso una musica popolare ma colta, non verso una forma di pop da successio radiofonico. Eppure ha sposato il progetto. Con Jersey Boys si diceva si sarebbe cimentato con il suo primo musical, cosa che da anni ha dichiarato di voler provare.
Non è andata così. Jersey Boys non è un musical, al massimo è una commedia musicale. Le canzoni ci sono, ma sono solo quelle che i Four Seasons eseguono sul palco. Eastwood sorprende in una direzione nuova, quella della commedia. Perché Jersey Boys è pieno di scambi veloci e godibili, di battute e ironia che attraversa tutto il film e coinvolge Eastwood in un entusiasmo nuovo (si concede, addirittura, un cameo, se si può definire tale la breve apparizione del se stesso protagonista della serie Rawhide). È probabilmente il film meno personale della sua recente carriera di regista. La tendenza all’approfondimento morale o politico è assente. Rimane solo la splendida, come sempre, fotografia di Tom Stern a scolpire con le ombre le avventure dei quattro ragazzi del Jersey. Eastwood sembra quasi giocare a fare lo Scorsese calandosi in questa storia tutta italo-americana. Sarà che il protagonista John Lloyd Young (che già era stato Valli a Broadway) sembra De Niro quando interpreta Frankie giovane – e sembra Pacino quando lo fa da grande – saranno gli spaghetti with meatballs e quella malavita quotidiana e dall’apparenza innocua, o la presenza di un Joe Pesci ragazzo che aiuta i Four Seasons a ingranare, ma sembra di assistere a una versione musicale di Quei bravi ragazzi.
Non tutto funziona in Jersey Boys, anzi. In primo luogo è troppo lungo: più di due ore con sequenze (la fuga e la fine della figlia di Valli su tutte) ampiamente trascurabili. In secondo troppo spesso si limita ad accennare: l’approfondimento psicologico dei personaggi a tratti risulta rudimentale, problematiche e personaggi appaiono e scompaiono a seconda dell’utilità del momento (la moglie Mary che sembra arrivare come un uragano sugli equilibri del giovane Frankie per non farsi più vedere fino alla parte finale; il boss Gyp, per quanto interpretato da uno splendido Christopher Walken, che appare a intermittenza senza che si chiarisca il suo ruolo). Quello che funziona, però, funziona bene. La costante ironia nostalgica, gli ammiccamenti della narrazione direttamente guardando in camera, aprono nuove, ulteriori, possibilità per un regista che sa sempre, comunque, sorprendere. E c’è quel carrello verticale che scala il Brill Building di New York, quando Frankie e Bob arrivano in città, che merita di essere ricordato.
(Jersey Boys, di Clint Eastwood, 2014, biografico, 134’)