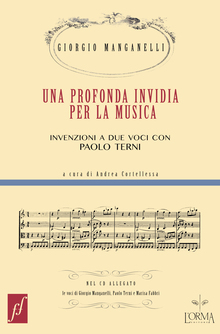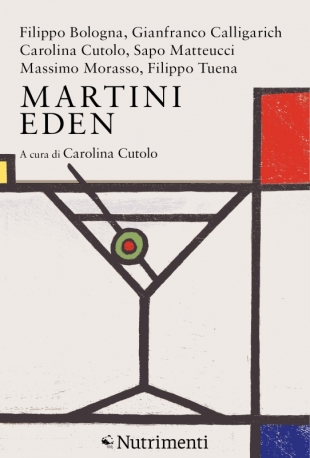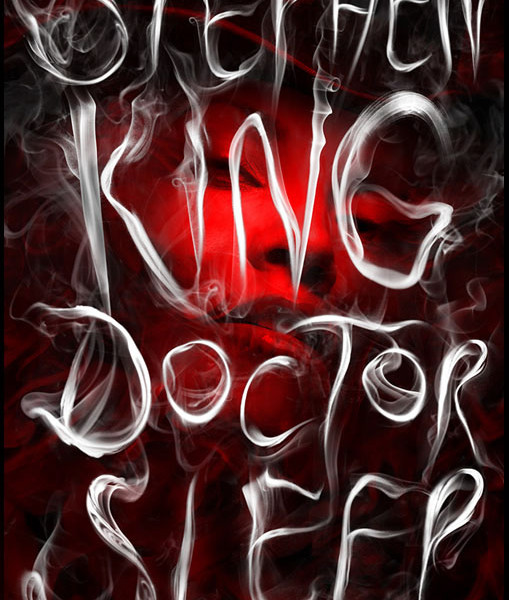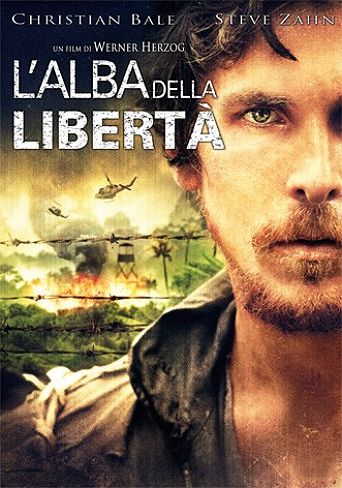Dove abbia vagato Chris Martin dall’uscita di X&Y (2005) a oggi, chi abbia preso il suo posto in questi otto anni, chi abbia trasformato i Coldplay dallo splendido gruppo che esordì con Parachutes, dove si potevano intravedere possibili, quantomeno potenziali, eredi dei Radiohead, a fenomeno strizzaocchi a fette di mercato così ampie e variegate da far pensare a una possibile prostituzione artistica – attraverso collaborazioni più o meno discutibili, nonostante quella con Brian Eno – è una domanda a cui probabilmente è impossibile rispondere.
Si arriva al 2014 dopo due album talmente barocchi e vuoti (Viva la vida or Death and All His Friends e Mylo Xyloto) nelle scelte degli arrangiamenti e delle sonorità – tentativo di mischiare Arcade Fire, scimmiottamenti degli Arcade Fire, con elementi techno-dance e una pseudo world music – da mettere in discussione tutto ciò che di buono era stato fatto fino a quel momento. Esce quindi Ghost Stories, album di nove tracce, anticipato dal singolo “Magic”, brano trascinato da una giro di basso che sembra il fratello buono di quello di “Atoms for peace” nell’album d’esordio da solista di Thom Yorke, The Eraser. L’estetica del sesto album della band di Londra ruota attorno a quella di una corrente pop/elettro/folk (in maniera diversa: Bon Iver, James Blake, Iron & Wine, José González e compagnia bella), di cui i Coldplay sono stati in qualche modo uno dei gruppi pionieri, che si è paradossalmente sviluppata negli ultimi anni, mentre i quattro inglesi erano alle prese con arrangiamenti massimalisti da feste sulla spiaggia.
Si parte con “Always In My Head”, ed è già da questo incipit che si avverte un cambiamento, uno stravolgimento nelle intenzioni: mentre negli ultimi anni è stato predominante un movimento verso l’esterno, ora si torna verso l’interno. Segue la già citata “Magic”. Passando per “Midnight”, secondo singolo uscito alla mezzanotte del 25 febbraio, un brano smaccatamente à la Bon Iver, si arriva alla sequenza “Another’s Arms”, forse il momento più alto con il suo basso dai tempi sospesi stile Massive Attack, e “Oceans”, che sembra esser stata ripescata direttamente da Parachutes. “A Sky Full Of Stars”, terzo singolo, completamente fuori contesto, unico pallidissimo riverbero delle infatuazioni dance post adolescenziali – se non contiamo quello, minimale e funzionale, che fa parte della coda di “Midnight”, che lontanamente può ricordare l’entrata della sezione ritmica in “The Rip” dei Portishead – che vive di luce opaca riflessa dai Killers di Day & Age. Si chiude con “O”, ballata al piano dove il dramma interiore può trovare soluzione cercando di guardare in alto, verso il cielo, verso un cielo individuale.
Ghost Stories riprende un discorso interrotto otto anni fa, e lo fa probabilmente in maniera meno potente di quanto avrebbe potuto fare se non ci fosse stata questa parentesi che nel tempo ne ha deformato la possibile percezione. Una certa sensazione di fondo dovuta a questa ambiguità può portare a pensare che il ritorno a un certo tipo di minimalismo faccia sempre parte di un discorso iperindustriale che ha caratterizzato l’ultimo decennio dei Coldplay; che quindi a un certo punto abbiano capito che fosse arrivato il momento di svoltare, di tornare, verso un certo tipo di pubblico (senza però dimenticarsi degli altri). In questo Martin e soci risulterebbero sempre un po’ furbi nelle proprie scelte, capaci di leggere in quale direzione si muove il mercato, agendo di conseguenza, quasi come si stesse parlando di un gruppo agli esordi che per emergere deve fare certi calcoli, e non di una delle band più influenti degli ultimi quindici anni; aspetti che, alla fine, comunque, non contaminano più di tanto un album piacevole, ma che all’interno della produzione dei quattro potrebbe risultare un po’ isolato.
(Coldplay, Ghost Stories, Parlophone, 2014)