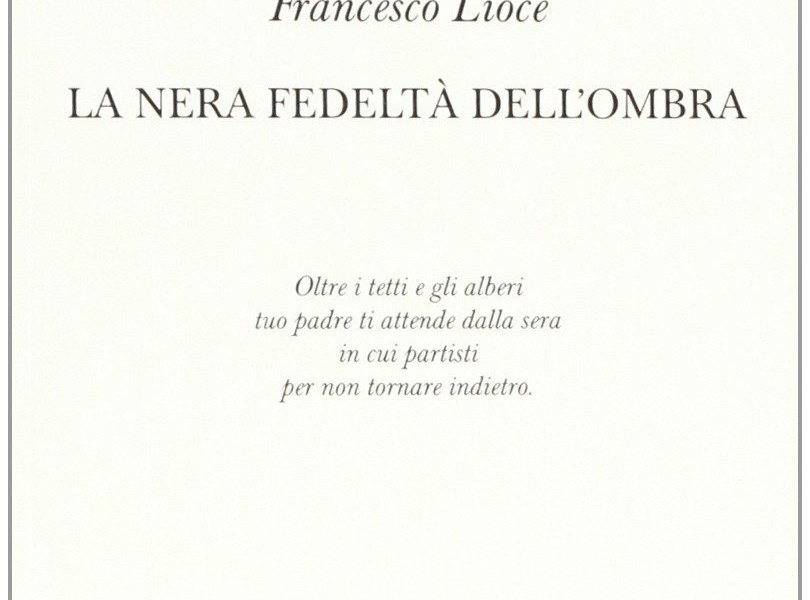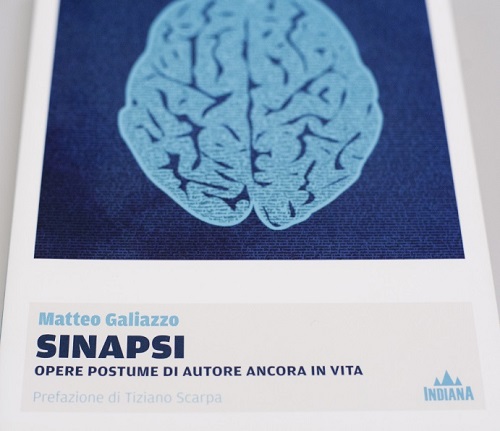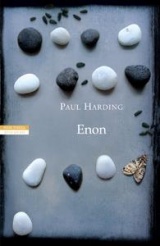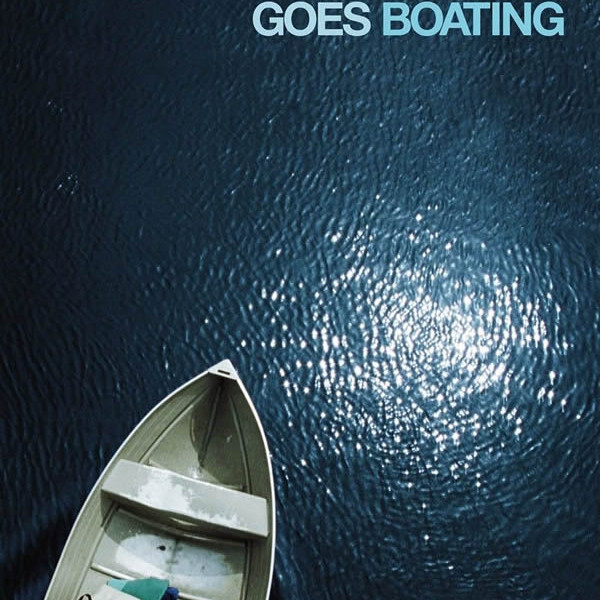Nell’ultimo spettacolo di Emma Dante ci sono sette donne, Gina, Cetty, Maria, Katia, Lia, Pinuccia e Antonella, che si riuniscono per un funerale. Di chi sia anche la morta lo ignora. Le sorelle avanzano in schiera portando una croce, ci sono scudi e spade di fronte al pubblico e una linea nera. Al di qua e al di là della linea nera sul fondo del palco il mondo dei vivi e quello dei morti si confondono. I morti si presentano al pubblico, evocati nei ricordi, incarnando le dinamiche che uniscono e dividono le superstiti della famiglia, e poi tornano sullo sfondo, in attesa di colei che tra le sorelle è la morta, ma che ancora non lo sa, e delle altre, dei vivi, che, come tutti, prima o poi si uniranno alla macabra danza che ci ricorda Ingmar Bergman e la lunga processione che chiude Il settimo sigillo.
In Le sorelle Macaluso ritroviamo tutto il teatro della Dante: c’è il ritmo del gruppo, delle filastrocche delle bambine e della danza verso l’aldilà; c’è il loop dei movimenti in cui le persone si impigliano e rimangono bloccate così come rimangono allamate alla vita; c’è il teatro sociale e non politico rappresentato da una famiglia avulsa da ogni contesto che non sia quello della miseria e della realtà quotidiana; c’è la lingua, il dialetto che permette all’attore di parlare e non di recitare, di dire le cose alla maniera in cui le pensa, senza mediazione, e di rendere il teatro verità.
La Dante, in questo Le sorelle Macaluso, cita anche se stessa: tornano alla mente Vita mia e Ballarini.
Vita mia e l’instancabile inseguimento che vi si svolge, sono in tutto lo spettacolo, ma non ci si deve far ingannare dalla somiglianza dei temi, le domande che vengono poste e le esigenze che vengono soddisfatte dai due spettacoli sono assolutamente diverse: in Vita mia l’atmosfera è cupa, il pubblico raccolto attorno al letto/bara è partecipe del lutto, la cerimonia funebre messa in scena attorno al cadavere riluttante del figlio morto non si risolve, il dolore stilla da ogni particella del corpo della madre e non è destinato a essere lenito.
Le sorelle Macaluso, al contrario, di lutti ne hanno risolti tanti e il dolore si fa lieve quando scorre, come acqua, nel senso della corrente. Le sorelle perdono la madre, il padre, una sorellina e ancora la maggiore di loro, quella che le ha accudite come un’altra madre, e un nipote, piccolo Maradona cardiopatico, la cui morte avviene quasi fuori dalla vicenda, quasi una morte di troppo.
In questo spettacolo, inoltre, il pubblico è invitato ad assistere al funerale, ma non è compreso nella cerimonia. Lo spettatore guarda, rispettosamente si commuove, riflette sulla caducità della propria esistenza, ma rimane cosciente di trovarsi fuori dalla vicenda, come chi, a un funerale di un lontano parente, soffre più per chi resta che per chi se n’è andato.
Ballarini e il commovente passeggiare lungo il viale dei ricordi da parte di due anziani amanti, lo si rivede nella danza in cui, una volta spirati, madre e padre si ritrovano. Due angeli in camicia da notte che sognano di ritrovarsi, leggeri, puliti, dimentichi della povertà e della miseria, in un mondo dove il tempo viene scandito dal crescere dell’intensità delle carezze.
«Ma allora il funerale è il mio?» domanda la maggiore delle sorelle Macaluso quando, alla fine, le viene finalmente dato il permesso di ballare e, dopo quella battuta, il buio completo avvolge gli attori e gli spettatori e un lungo silenzio precede l’applauso che premia gli interpreti di questo spettacolo intenso, commovente e perfettamente rispondente alle aspettative di chi acquista il biglietto.

Le sorelle Macaluso
testo e regia di Emma Dante
produzione Teatro Stabile di Napoli, Théâtre National (Bruxelles), Festival d’Avignon, Folkteatern (Göteborg), in collaborazione con Atto Unico/Compagnia Sud Costa Occidentale.
con Serena Barone, Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, Italia Carroccio, Davide Celona, Marcella Colaianni, Alessandra Fazzino, Daniela Macaluso, Leonarda Saffi, Stephanie Taillandier.
Prossime date
Palermo – Teatro Biondo dal 25 febbraio al 3 marzo
Torino – Fonderie Teatrali Limone Moncalieri dal 29 aprile al 4 maggio
Milano – Piccolo Teatro Grassi dal 6 maggio al 18 maggio