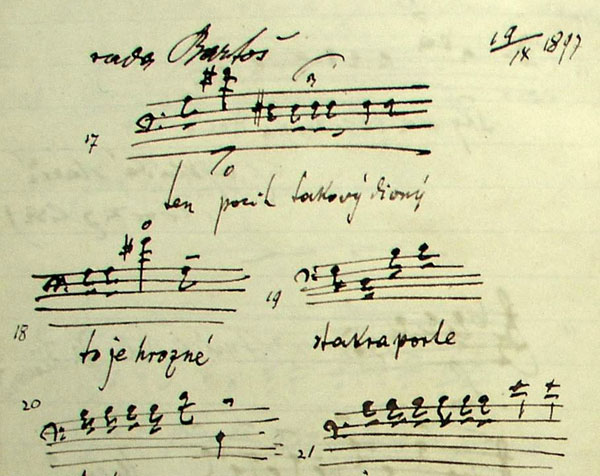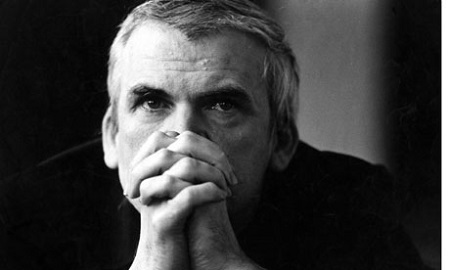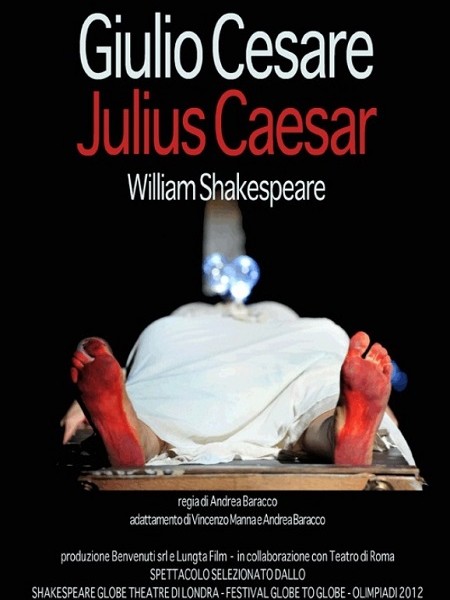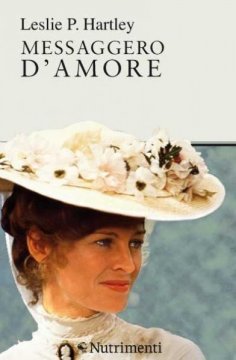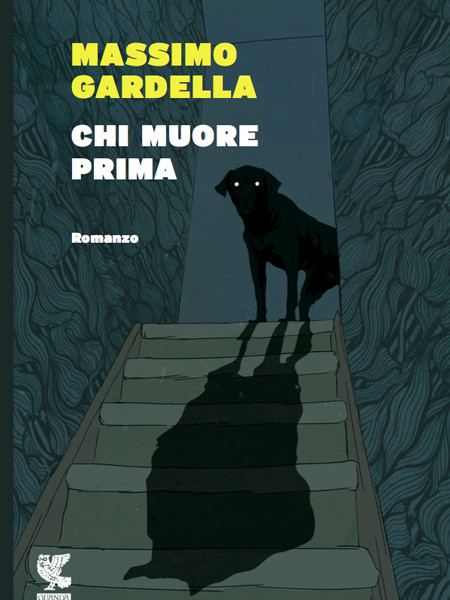Dopo gli approfondimenti sulla storia di Fazi Editore e sulla collana Le strade, Flanerí vi propone un’intervista a Cristina Marino, editor della narrativa straniera per la casa editrice di via Isonzo 42. Cristina, in casa editrice da otto anni, è stata l’editor di romanzi importantissimi come Olive Kitteridge di Elizabeth Strout e Stoner di John E. Williams.
Sei l’editor della narrativa straniera per Fazi Editore, una delle case editrici più prestigiose in Italia, che lavora da anni a un preciso progetto editoriale sia nell’ambito della narrativa italiana che in quella straniera. Ci spieghi che differenza passa tra fare l’editor per l’uno o per l’altro ambito?
Credo che si tratti di due lavori molto diversi tra loro, personalmente non mi sono mai occupata di narrativa italiana, dunque il mio punto di vista sarà necessariamente parziale. L’editor di narrativa straniera sceglie testi già valutati da altri, romanzi pubblicati o in via di pubblicazione in paesi stranieri; l’editor di narrativa italiana parte da una materia più grezza, da un testo sul quale verosimilmente verranno operate numerose modifiche prima di venire stampato. In linea generale in questo ultimo caso l’editor partecipa più da vicino al percorso creativo di un’opera, ne può essere in molti casi un co-autore, anche se il suo nome non comparirà mai in copertina. Diversamente, l’editor di narrativa straniera può essere definito banalmente come il primo lettore italiano di un romanzo inglese, americano, francese ecc. In Italia siamo molto abituati a tradurre, siamo tra i paesi che per tradizione importano moltissima letteratura straniera, tanto che nella vendita dei diritti esteri di un autore americano, per esempio, siamo ritenuti l’ago della bilancia: quando un editore italiano ne acquisisce i diritti il mercato internazionale accelera, spesso con un effetto domino. In questo senso una fase importante dell’editor di narrativa straniera è avere un quadro di cosa viene pubblicato con successo negli altri paesi, intercettare che tipo di storie vende di più, quali autori stanno emergendo. Gli esordienti americani non vendono più? La Scandinavia ha esaurito la sua forza commerciale con un’offerta ormai inflazionata di thriller? La narrativa cinese riuscirà a produrre uno nuovo scrittore che possa far breccia in Italia? Durante le fiere internazionali si parla anche di questo, anche se è chiaro che fermarsi a selezionare la narrativa per macro categorie lascia il tempo che trova: le mode nascono, si può scegliere di cavalcare un filone, ma la sfida più grande è sempre trovare la novità, quello che nessun altro ha ancora fatto.
L’editor di narrativa straniera ha il compito di presentare un autore nel modo più efficace per il gusto del lettore italiano, può sembrare semplicistico, ma la scelta della traduzione di un titolo o di una nuova copertina sono spesso momenti fondamentali per la nascita di un romanzo tradotto. Si tratta anche di parafrasare il gusto di un paese a quello di un altro.
L’editor di narrativa italiana è più a contatto con l’essere umano, mentre l’altro lo è di più con le storie e con tutto quello che gli viene costruito intorno, in termini di comunicazione e pubblicità. Ovvero, anche per il secondo è importante e gratificante il rapporto con l’autore (soprattutto nel tempo), ma senz’altro non costituisce una fase prioritaria del suo lavoro. Così, l’editor di Mario Rossi dovrà con pazienza convincerlo che certe modifiche sono necessarie perché migliorative, che un’intervista in televisione è meglio accettarla, che per il secondo romanzo sarebbe meglio non cambiasse editore. Insomma si crea un rapporto di intimità, nel quale la fiducia reciproca è fondamentale.
Le modalità della ricerca di nuovi autori è anch’essa molto differente nei due casi. Se per la narrativa straniera ci si affida quasi obbligatoriamente alla rete di agenzie letterarie e scout (anche se non esclusivamente), data la vastità dei terreni da esplorare, per gli autori italiani la ricerca è condotta più da vicino, non sempre attraverso agenzie, quanto invece nella lettura di manoscritti o attraverso l’incontro diretto. È anche per questo che l’editor di narrativa italiana lo immagino molto più impegnato in appuntamenti letterari, nella partecipazione a presentazioni e manifestazioni di settore, cosa cui l’editor di narrativa straniera può più liberamente sottrarsi.
Il tuo lavoro ha un aspetto molto particolare: scegliere quali libri vedranno la luce e quali sono destinati a non vederla mai. Come vivi questa responsabilità?
Doversi assumere la responsabilità di cassare o promuovere un titolo all’inizio può spaventare, proprio perché non si conosce cosa significhi esattamente fare una scelta editoriale. Quando ho cominciato avevo paura di sbagliare, di esprimere un giudizio libero e autentico. Con il tempo si diventa più pratici, si può imparare a rischiare, a convincere l’editore di una proposta apparentemente poco allettante e col tempo a valutare con più precisione in base alla natura della collana per cui si lavora. La responsabilità della scelta è fisiologica al mestiere dell’editor, e fisiologico credo sia non riuscire a possedere mai una modalità infallibile. A volte si pubblicano libri belli e di successo, altre volte rischiamo con titoli commerciali che non piaceranno quasi a nessuno. Quel che può salvare la coscienza è lavorare con onestà, porsi di fronte a un nuovo testo con la massima apertura, quindi evitare pregiudizi e dall’altra parte avere la coerenza di bocciare un testo anche se ci è molto piaciuto, perché in quella collana non riuscirebbe ad essere valorizzato.
Come ha cambiato il tuo lavoro di editor la crisi dell’editoria in atto da un po’ di anni? Ha limitato il tuo raggio d’azione e la tua indipendenza?
La crisi ha giovato alla mia indipendenza. Nel momento in cui siamo usciti dalla scia delle grandi fortune commerciali e i budget a disposizione sono stati sensibilmente ridotti, è stato quasi obbligatorio cominciare a esplorare terreni prima inesplorati, andare oltre certe dinamiche di mercato, avvicinarsi a proposte che venivano da realtà più piccole e indipendenti. È pur vero che la Fazi Editore ha sempre avuto come tratto caratteristico una buona dose di versatilità nelle scelte editoriali, abbiamo sempre pubblicato generi diversi, con un orecchio teso a quel che in un primo momento può suonare poco rassicurante.
Da editor ti aspettavi il grande successo di Stoner? Ci racconti le vicende editoriali del romanzo di Williams?
La pubblicazione di Stoner è stata molto seguita in redazione. Portare in libreria un romanzo che ha cinquant’anni non è cosa semplice. Soprattutto bisogna convincere i librai che quel titolo venderà, che è ancora attuale, che non devono immaginarlo come un testo polveroso. Dunque la nostra prima sfida è stata quella, credevamo nella forza del romanzo e dovevamo trasferire la nostra convinzione ai librai. Abbiamo inviato delle copie in anticipo a una lunga lista di librai e persone del mondo della cultura, esprimendo molto chiaramente perché quel libro meritava di essere letto. Le reazioni sono state positive fin dall’inizio, tutte. Ma quando sei all’inizio e hai appena qualche migliaio di copie distribuite in libreria, non puoi immaginare che si inneschi un passaparola di tale portata, puoi immaginare che il libro andrà bene, che se su dieci pareri dieci sono positivi, allora c’è davvero qualcosa che lo farà “partire”. La pubblicazione di Stoner è stata e continua a essere un’esperienza entusiasmante, da due anni ogni giorno riceviamo qualche parere entusiastico, persone commosse, con gli occhi pieni di sorpresa. Ci siamo augurati fin dall’inizio che diventasse un classico, ma il risultato è stato oltre le aspettative. Abbiamo scommesso nella modernità del romanzo, nella sua carica emotiva, in una trama che poteva fare breccia in questo tempo, nel nostro paese. E Stoner poi è diventato anche un successo internazionale, in Olanda e Inghilterra vende centinaia di migliaia di copie, occupa i primi posti delle classifiche, i più grandi intellettuali si sperticano in omaggi appassionati. E sorprendente è che un romanzo americano, profondamente americano, non abbia successo negli Stati Uniti. Lì da loro ha ricevuto alcune recensioni molto belle, ma il libro non vende, o meglio vende, ma sempre entro una certa sfera di lettori, rimanendo così un romanzo di nicchia. Mentre in Italia oggi viene segnalato anche da personaggi del mondo dello spettacolo, a testimonianza della vasta diffusione raggiunta.
Per finire, ci puoi dare qualche anticipazione sulle prossime pubblicazioni della collana Le strade di Fazi Editore?
Tre titoli. A fine febbraio pubblicheremo il romanzo d’esordio di John Williams, Nulla, solo la notte, opera giovanile scritta quando l’autore aveva appena vent’anni e l’ultima a dover essere tradotta. In età ancora acerba Williams dimostra di essere il profondo conoscitore delle fragilità umane che abbiamo conosciuto con i suoi romanzi maggiori. In primavera avremo due uscite importanti, due novità: la prima, Il corpo della vita di David Wagner, romanzo tedesco, fortemente ispirato a un’esperienza estrema che l’autore ha vissuto, raccontata con un tono e una grazia rari, una scrittura coraggiosa. L’altra uscita importante sarà un romanzo di Elizabeth Jane Howard (per il quale stiamo ancora scegliendo il titolo italiano), scrittrice inglese molto prolifica e recentemente deceduta, autrice di grande talento sottovalutata in vita, abile narratrice di storie familiari, un nome in cui crediamo moltissimo.