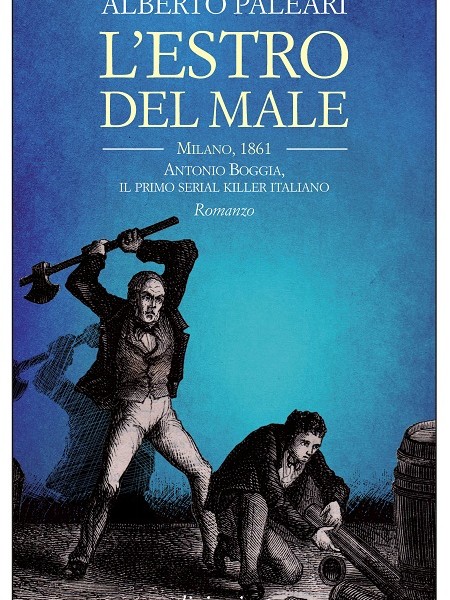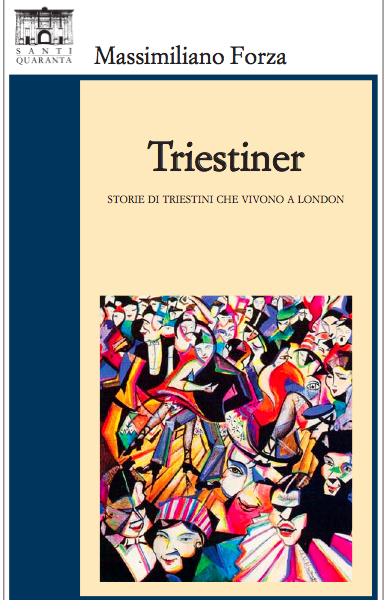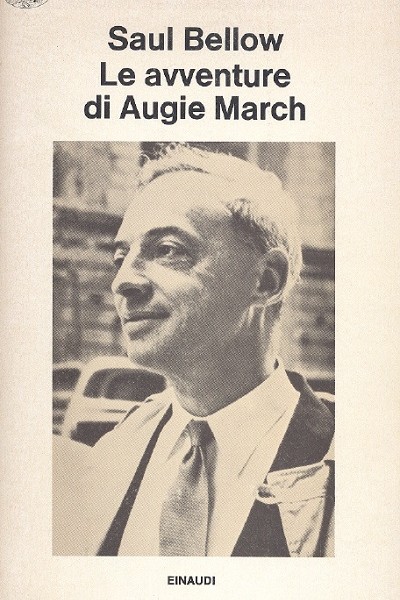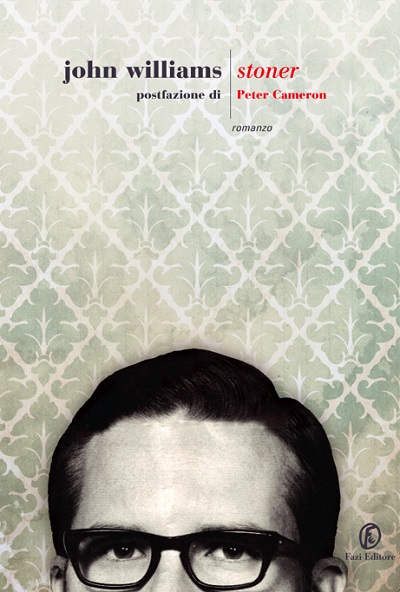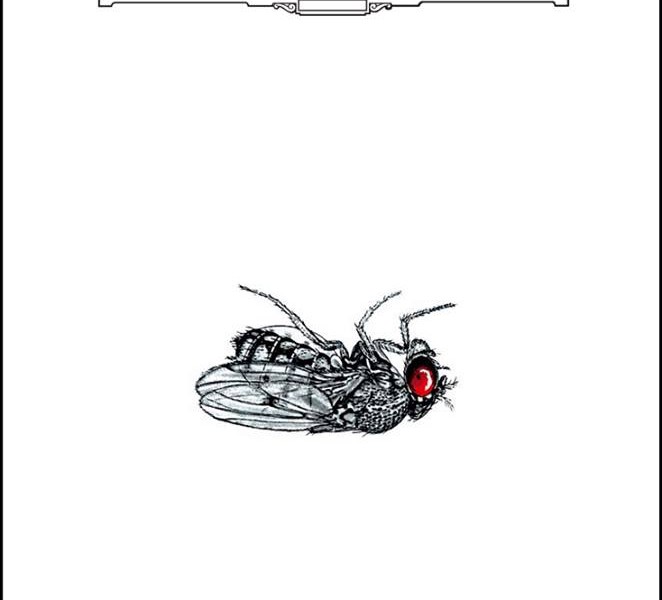Giovani. Vita e scrittura tra fascismo e dopoguerra di Daniela Brogi (:duepunti, 2013) si apre con una riflessione sulla giovinezza, che rischia di ridursi a combustione di energia senza un progetto di lunga durata, senza una precisa definizione. La centralità letteraria ed esistenziale della giovinezza come età di cambiamento e apertura alle possibilità della vita è il filo conduttore di un percorso originale di ricerca che ha caratterizzato la generazione di Pasolini, Calvino, Cassola: il voler abitare in un mondo all’altezza di questo slancio, dando corpo a ideali e visioni, con l’intenzione di formulare un dialogo fra l’età adulta e quella giovane.
Nel primo saggio, Daniela Brogi realizza un attento ritratto della gioventù di Romano Bilenchi, studiando la parabola umana di un autore che aderì attivamente al fascismo, soprattutto quando esso fu un movimento, definito dallo stesso Bilenchi, nel 1934 «più rivoluzionario di Mosca». L’insistenza con cui si è cercato di far passare il fascismo come un fenomeno culturale di superficie è confutata dalle accese parole di Bilenchi: «Il fascismo è un misticismo, ma è impossibile elencarlo in un sistema filosofico». Prima d’altre definizioni, il fascismo è movimento culturale per imporre un sentire naturalizzato, un movimento alla rifondazione della società. «Come tutti i buoni fascisti», l’io di Bilenchi scrive a nome di una totalità, non una vita collettiva, ma vita di gruppo connotata in senso battagliero e generazionale.
Il fascismo naturalizzato – «quel che più conta è il richiamo di Mussolini, e pronunciano questo nome tremando di fede» – diventa volontà di potenza individuale fra le frange della gioventù più consapevole della storia che rivendica il proprio potere decisionale nella società. Difatti, l’immagine del fascismo che si basa proprio sulla capacità di rappresentazioni molteplici conferma che Mussolini non fosse un’infatuazione, ma l’immagine di un capo rivoluzionario e liberatore che attecchisce in modo profondo nell’inconscio politico della gioventù, diventando per Bilenchi una tensione, più che un’illusione esaltata.
Il secondo saggio è incentrato sul dialogo serrato fra Il postino suona sempre due volte di James M. Cain e il filone narrativo di Ossessione e Paesi tuoi, mostrando il lavoro sulle interferenze e sullo scambio fra diverse forme e discipline. Incrociare significa pensare che gli scenari della narrativa pavesiana nascono nel medesimo territorio per cercare nuovi modi di sperimentare e raccontare il legame fra individui e paesaggio: la Brogi analizza le trame di Pavese alla luce dell’influenza dei narratori americani, Caldwell, Steibeck, Faulkner, nei quali lo scrittore cerca il ritmo del narrare, ammettendo che la critica non pensò subito a Cain. È un’analisi che si lascia apprezzare per la precisione dei percorsi: dopo aver spiegato le tre modalità in cui letteratura e cinema sono stati messi a confronto (il film come trasposizione, il film come testimonianza di un certo modo di intendere un tema, la letteratura come imitazione del cinema), Daniela Brogi ragiona sulle interferenze e gli incroci da cui nascono i film neorealisti italiani, sulla volontà di Pavese di trovare una fluidità fra il cinema e la letteratura ne La bella estate (1949).
Il terzo saggio, dedicato a Fausto e Anna di Cassola, riflette sulla figura del partigiano che emerge nel romanzo, quella del dubbio e della consapevolezza che l’appartenenza ideologica non soddisfi il senso umano di una vicenda. Cassola sa bene da che parte stare, eppure nell’universo fittizio del romanzo amplifica il senso di disagio di fronte a risonanze emotive e dubbi esistenziali, confidando con grande delicatezza il sentimento di amore per la vita semplice del partigiano, aprendo la possibilità di dare un senso a una vicenda umana a cui lo stesso è difficile trovarlo. Fausto è l’alter-ego di un giovane studente emulo di Joyce, che attacca i valori borghesi e decide di partire come partigiano, Anna lo ama ma è considerata ai suoi occhi troppo semplice. Nel libro, Cassola confessa il reale dissidio fra le aspettative e le reali condizioni e prefigura l’adesione all’antifascismo come scelta per colmare un vuoto, ma ancora, l’esperienza che si deposita nel personaggio lo porta a una continua ricerca personale, che approda alla scelta di scrivere.
È un modo di raccontare di sé e di un’epoca mettendo al centro l’esperienza della guerra, ma senza esaurire in essa il significato di una vita, grazie alla presa di distanza dalla retorica degli «eroi del nostro tempo» e all’uso di forme espressive più sperimentali sia nelle tematiche (l’assenza dell’amore per Anna, la cronistoria familiare della piccola borghesia) sia nell’imitazione controllata da parte di Cassola dei modi di Joyce. (È ingenuo Fausto, non l’autore). L’intenzione di «raccontare il moto della vita» va oltre il naturalismo ottocentesco e lo stile sperimentale per cui la trama è flusso sconnesso, la dialettica di durata si contrappone alla progressione, l’immobilità al movimento colgono l’impossibilità del dire il reale in modo fisso. Ovvero la coscienza dello scrittore elabora per strati la narrazione, dilatando, evocando, il tempo, vero protagonista della trama, espresso da immagini colte nell’«immobilità apparente piena di moto sostanziale».
Il quarto saggio indaga invece l’idea di patria di Pasolini, la poesia Alla mia nazione come una confessione in pubblico della propria passione, un investimento oggettuale verso l’idea di nazione, attraverso il mito del popolo italiano, a cui segue la lucida presa di posizione di fronte all’evidenza che quell’Italia non esiste più e il conseguente abbandono della poesia, a causa della perdita del destinatario che chieda poesia. Anche in questo caso, la Brogi considera seriamente il progetto di rinnovamento che la poesia di Pasolini ha rappresentato.
L’autrice è sensibile nel cogliere i tratti di confluenza fra cinema e letteratura, ampliando l’ambito degli studi, cercando nella giovinezza – contenitore organico di esperienze eterogenee – continui specchi sia di ricerca che umani.
(Daniela Brogi, Giovani. Vita e scrittura tra fascismo e dopoguerra, :duepunti, 2013, pp. 296, euro 15)