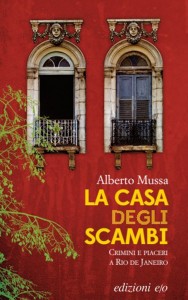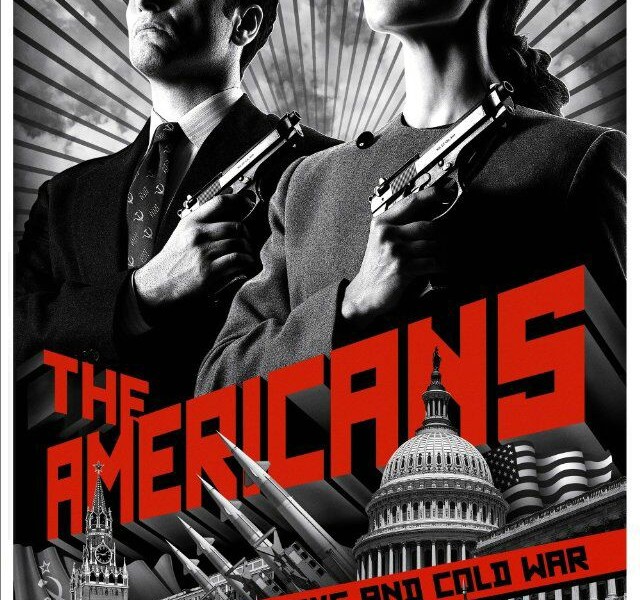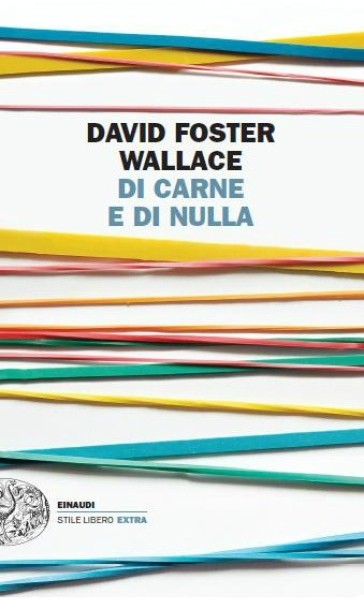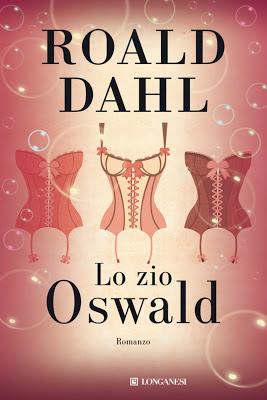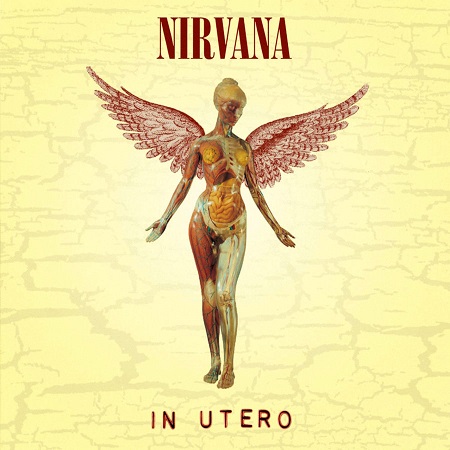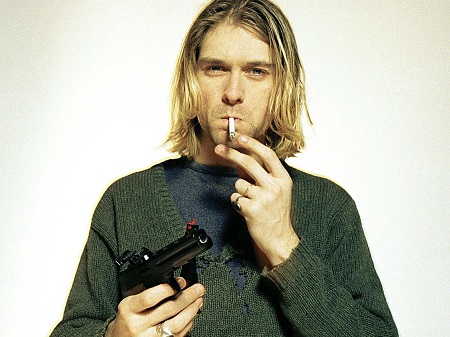«You better think! Think about what you’re tryin’ to do to me! Think! Let your mind go let yourself be free!»
Decine di paia di gambe pedalano su biciclette immaginarie, moltiplicandosi all’infinito nelle pareti a specchio. Una moretta alta non più di un metro e cinquanta, corpo scolpito nella tutina da fitness nera, urla battendo le mani a ritmo: «Forza, forzaaa! Su, su, su! Pedalare! Facciamolo vedere a quelle pance!»
Cerco un angolo in cui infilare il mio tappetino, il parquet è gremito oltre ogni possibile immaginazione, guardare questo caleidoscopio di zampette che arrancano ha il suo fascino, tanto che mi ci perdo e dimentico che avrei dovuto buttarmi nella mischia già da dieci minuti buoni.
«Freedom! Freedom! Freedom! Freedom!» urla Aretha dalle casse.
Guarda lì, quelle coscettine rotonde e biancastre quasi mi commuovono per come spuntano dagli shorts neri, sotto la magliettina La corsa del cuore, con il cuore disegnato rosa e gonfio. E i muscolacci pelosi del tipo stagionato sulla sinistra. C’è una storia dietro ognuna di quelle paia di gambe che avanzano verso il nulla.
Finalmente scorgo un angolo possibile per entrare a far parte della magnifica batteria di polli. A dodici minuti dall’inizio della lezione, io, Amelia, mi inserisco nella biciclettata virtuale con tutto il vigore che posso. Nemmeno a dirlo, dopo venti secondi ho già il cuore che esplode.
O forse è per quello che mi hai detto ieri, Mister G? Oh, G! Cos’è che mi hai detto? Vogliamo vivere questa vita pop-up?
«E ora giù i piedi! Mani dietro la nuca, fatemi un bel crunch! Forzaaa!»
Mi si infuoca il ventre tutt’altro che piatto, mentre coscette pallide sbuffa esalando l’ultimo respiro.
Oggi viene a cena la Fra, che fugge dal condominio e da casa di mamma dove la braccano fameliche zie e vicine attempate.
La signora Vanda: «È vero che ti sei divorziata da quel bel ragazzo, ma come mi dispiace!»
O Lucilla: «Non è che ti faceva le corna, il disgraziato?»
Francesca e Roberto si sono lasciati, ebbene sì: matrimonio bianco, lui ha non so bene quale problema della sfera psicosessuale, insomma non sono riusciti a risolvere e la cosa è finita. Su invito di mamma è andato persino don Patrizio della parrocchia: «Figliola, ma le promesse scambiate davanti al Signore, quelle vanno mantenute. La promessa di dare al mondo dei figli, forse dovreste provare, il Signore misericordioso ve ne manderà e vedrai che tutto andrà meglio». Così ha anche peggiorato le cose, che la Fra non era andata certo a dire al parroco delle disfunzioni erettili del marito, ostacolo non indifferente per ricevere queste benedette creature del Signore.
«E ora tutti in piediii! Prendere gli step!», urla la panterina ginnica guardando severa noi pecorelle smarrite.
Oggi viene a rifugiarsi da me, la Fra, se esco viva da questa palestra la proteggerò da ogni attacco nemico.
Io la mia dimensione l’ho trovata, con Andrea e la piccola Lu, davanti al focolare finché morte non ci separi.
Poi sul più bello arrivi tu, G caro, e mi mostri questo cielo stellato. Io che mi metto a guardarlo e poi ti mostro un ciliegio in fiore. Tu che annusi il ciliegio e poi mi prendi la mano e ci si tuffa in mare. Io che apro gli occhi nel blu in un banco di pesciolini e poi ti abbraccio e ti porto in volo sulla luna. G, zucchero del mio caffè, viviamo così: come in un libro per bambini. Stai andando tranquillo per la tua storia e come se niente fosse sollevi un lembo della pagina – pop! – ti compare un universo tintinnante di meraviglie. Questo è un campo di quadrifogli, oh mio G!
Il sudore mi riga la schiena.
«Dài ragazzi! Dàidàidài! Spingete con quelle braccia!»
Vorrei spingere la moretta giù da una rupe. Penso che morirò fra pochi secondi.
A Francesca dirò che l’amore è come un viaggio,e il compagno giusto deve essere adeguato alla meta. Per questo non è mai definitivo: dipende da dove vai, dalla fretta che hai, dal modo in cui ti piace viaggiare. Ci si associa con gioia per partire, ci si dissocia quando si arriva, o magari si decide di ripartire insieme, se le prossime mete coincidono ancora.
E guarda qui a sorpresa cosa succede, mio G? Che nel viaggio perfetto col compagno perfetto ci ritroviamo a passeggio in un libro pop-up. Che possiamo fare, se fra quelle pagine sentiamo il profumo delle caramelle e delle violette? Solo deliziarci di un momento, e continuare a camminare. Amelie (come mi chiami tu), viaggio e sorpresa sono il sale e lo zucchero della vita, mi dici. Non si scambia lo zucchero col sale: per esaltare il sapore dell’esistenza sono necessari entrambi! E io ti credo, mentre ascolto le tue parole di baci.
Ora sogno di bere tutta l’acqua dell’universo e lavare via queste tossine sotto i vapori della doccia. Il branco di bestiole sfiancate si riversa negli spogliatoi in un frusciare di microfibra multicolore, urtarsi di flaconi di plastica e ciabattare diffuso. E poi è solo schiuma.
Tra le panche e gli specchi è un avvicendarsi di carni sfatte e corpi tenuti su a suon di massaggi e liposculture, pelli tatuate, rasature improbabili, bucce d’arancia e capelli tinti.
Apro la parentesi dello spogliatoio per farmi raccontare da questa specie di girone dantesco cosa nascondono le Impeccabili Signore della porta accanto, le ragazze con le unghie laccate, le giovani donne in carriera.
Le vedi passeggiare per strada, sotto il tiro del gossip di quartiere, vestite a modo, con le borse chiuse, i foulard al collo, gli orecchini trendy, e non puoi immaginare che asciughino le intime umidità col getto d’aria calda del phon, ignorando che gli odori sono molecole sparse al vento e ce le ritroviamo incastonate nelle narici o nei bronchi. Siamo geneticamente modificati dagli umori altrui.
Ora sono pronta per Francesca, la salverò da zie e preti vampiri, per portarla su un prato fresco di fiori e ricordarle che nello specchio c’è sempre una sola immagine riflessa, ed è a quegli occhi che tocca rispondere, i suoi occhi nocciola belli e imperfetti, e a nessun altro.
Quanto a te G, mon choux, so che non mi porterai mai in nessun posto. Ci sarà un bacio azzurro solo sognato, un abbraccio stretto sfumato in arancione, tante parole intrecciate su fili luminosi, mentre la vita scorre allegra fra le pagine. Per un incantesimo, gli inserti pop-up potrebbero rimanere incollati chiusi, o esplodere tutti insieme in un boato, facendo perdere senso a ogni cosa. È di queste mirabolanti eventualità che abbiamo paura. Proviamo un testa o croce col coraggio?
Il branco s’è rimesso in ordine. Usciamo dal covo segreto per tornare negli appartamenti, dove stirando camicie e lucidando pavimenti si spazia coi pensieri sull’amore che non esiste, che è una vecchia coperta logora o sempre uguale a se stessa, convinte che questo sentimento che muove il mondo sia esclusivo, mentre è per sua natura inclusivo. Non si spende mai in amore, si guadagna e basta.
E invece siete lì, come su un girarrosto.
Se solo l’avessero saputo, poveri polli, che il loro destino era di finire nudi a graticolare in fila sotto gli occhi golosi e rapaci dei passanti.
Io ho scelto una vita leggera. La mia vita pop-up.