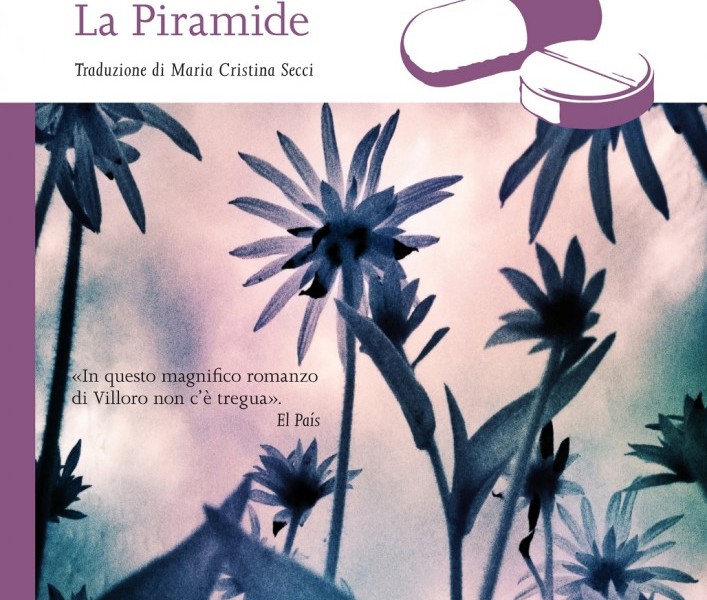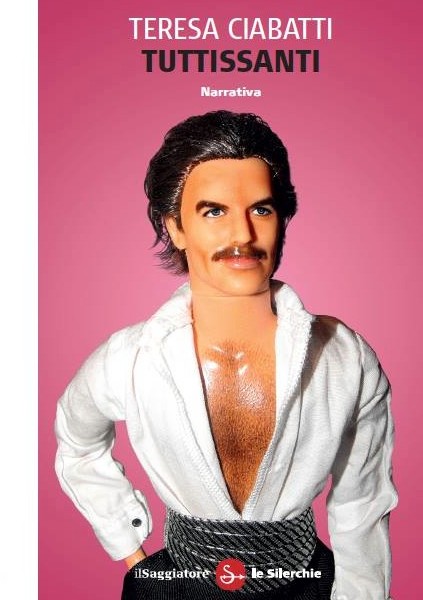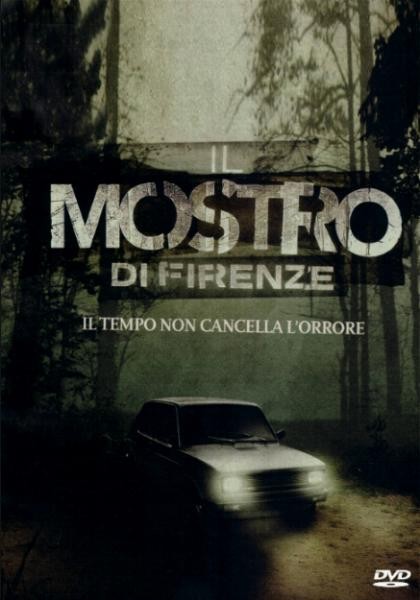Si chiama Televisione (Bollati Boringhieri, 2013) l’ultimo libro di Carlo Freccero, ma per il massmediologo ed ex dirigente televisivo parlare di tv è soltanto un punto di partenza per osservare il panorama sociale e politico del nostro paese.
Dagli esordi televisivi negli anni ’80 come direttore di palinsesto delle neonate Italia 1 e Canale 5 e Rete, all’esperienza francese a La Cinq con Fininvest, poi France 2 e France 3, fino a Rai 2 dei primi del 2000 con Michele Santoro e Daniele Luttazzi, ai tempi del cosiddetto «editto bulgaro» berlusconiano che bandì i due autori dalle reti Rai insieme a Biagi e, di fatto, lo stesso Freccero, che tornò a dirigere una rete solo nel 2008 con l’avvento del digitale terrestre e Rai 4, rete che ha lasciato soltanto lo scorso agosto per andare in pensione. Almeno dalla Rai, perché Freccero è attivo più che mai con i suoi libri, convegni, partecipazioni televisive e nel dibattito politico. Dalla “lite” con Brunetta sul servizio pubblico e la Rai, alla recente intervista su il manifesto in cui analizza il “fenomeno mediatico Renzi” definendolo «un gattopardo che invoca il cambiamento perché nulla deve cambiare».
Freccero partiamo dal suo libro, Televisione. Perché la tv costituisce un punto d’osservazione privilegiato per un’analisi sociale e politica del Paese?
Questo libro prende spunto dalla celebre frase del sociologo canadese Marshall McLuhan secondo cui il medium è il messaggio. Il contenuto della scrittura è il discorso, il contenuto della televisione è l’immagine. Se condividiamo le teorie di McLuhan dobbiamo ipotizzare che la televisione abbia imposto le sue regole anche alle altre sfere della società, come la politica, il mercato, la stessa organizzazione del pensiero, così come la stampa aveva creato l’uomo tipografico. La teoria è chiarificata da McLuhan nel suo testo più famoso La galassia Gutenberg, e la mette in qualche modo alla prova nei medium più disparati negli Strumenti per comunicare. Il motivo che rende attuale l’approfondimento di quest’ipotesi, relativamente alla televisione, è dato proprio dal contesto di forti rivoluzioni mediatiche che stiamo attraversando.
La televisione ha sostituito ai concetti di verità e qualità, i concetti di maggioranza e quantità.
È il “vero” prodotto di successo che raccoglie audience, consenso, e permette di scalare i sondaggi. Non conta più il contenuto, la politica con la “P” maiuscola. Conta la capacità di comunicazione! Ma la comunicazione è anche inganno, illusione, effetto speciale.
Quali elementi decretano l’efficacia di un messaggio comunicativo? A quale pubblico si rivolge?
La crisi economica ha contribuito a falsificare in senso pauperiano l’idea di un benessere raggiungibile da tutti. Improvvisamente la crisi ha smascherato l’idea che il capitale economico non comportasse, come risorsa culturale, differenze sostanziali. Con la crisi, ricchi e poveri sono risultati ancora una volta divisi, e chi si trovava ai due estremi della piramide sociale ha dovuto riconoscersi rispettivamente come casta e come rifiuto sociale. Da un lato manager, politici, grandi funzionari pubblici, dall’altro cassintegrati, disoccupati, esodati. Una nuova comunità si è allora andata sostituendo alla maggioranza costituita dalla televisione generalista commerciale. La separazione non è più come nell’universo gutenberghiano tra chi sa e chi non sa, o come ai tempi della tv generalista, tra chi è ricco e chi è povero. Nell’epoca della rete, insomma, nei social network non contano ideologie o differenze di classe. Non c’è opposizione tra imprenditore e lavoratore. L’unità della moltitudine si costruisce su una serie di valori nuovi, quale l’onestà, la moderazione, correttezza, rispetto della differenza, bene comune.
Quindi la rete, il web ha sostituito la televisione favorendo la democrazia? Che implicazioni comporta il rapporto tra rete e politica?
Siamo in una transizione da un contesto multimediale in cui la cosiddetta élite trae ancora la sua autorevolezza dalla consuetudine con la Galassia Gutenberg, dalla sua capacità di comprendere situazioni complesse, di conoscere leggi nella loro formula teorica, e di padroneggiare le capacità di esposizione e di scrittura elaborando teorie e programmi di oggi. Da tempo su questa intellighenzia legata alla pagina scritta ha preso il sopravvento una forma di populismo di matrice televisiva. I meccanismi di rilevazione dell’audience rivelando i gusti del pubblico in direzione di una media capace di catturare il pubblico più vasto possibile, ha finito per creare un modello di cittadino conformista e superficiale, interessato al successo materiale e ai consumi. Alle spalle di questa nuova ideologia c’è l’idea dell’intelligenza collettiva di Pierre Lévy, unita al concetto di decrescita felice di Latouche, e questo universo multimediale ha subito recentemente un grosso riaggiustamento con il web. Paragonabile alla rivoluzione vissuta ai tempi della tv commerciale.
Dunque se la rete sostituisce la televisione, cambiando il mezzo cambia il messaggio?
Il mio libro si chiede proprio cosa succede quando a un medium dominante se ne sostituisce un altro. Ho portato a termine il libro “profetizzando” in qualche modo quanto avvenuto alle ultime elezioni politiche, ma posso dire di avere avuto fortuna nella misura in cui c’è stato restituito uno scenario sino a pochi mesi prima imprevedibile: l’affermazione grazie, anche, alla rete di Beppe Grillo e del suo movimento. C’è stata una profonda frattura che è stata sorprendente, ma era già nell’ordine delle cose. Nello stesso tempo l’analisi dei media e della comunicazione in atto suggerivano ampiamente gli esiti successivi. La sorpresa sta piuttosto nell’improvvisa implosione delle logiche del passato. Sono abituati a pensare che tutto cambi ma lentamente e impercettibilmente invece i cambiamenti a volte arrivano tra fratture e crolli. Il crollo del muro di Berlino è simile a quello che nel mio libro definisco «il crollo della maggioranza» e quindi queste ultime elezioni politiche sono quanto di più didascalico possa esistere rispetto all’ipotesi di base che è il medium a generare il messaggio.
È in quest’ottica che va intesa la sua definizione del movimento di Grillo «Mediaset 5 Stelle»?
Grillo sta usando internet come Berlusconi ha usato la tv generalista in senso maggioritario. Grillo tende a ridurre internet a un mero “mi piace” e “non mi piace” e a tradurre internet come se fosse una qualsiasi rete commerciale.
Grillo e il Movimento 5 Stelle grazie al web raggiungono una sinistra bersaniana ancora obsoletamente legata alla Galassia Gutenberg e la destra berlusconiana legata alla tv commerciale. La causa è l’incapacità della sinistra di superare la Galassia Gutenberg. Il popolo della sinistra è rimasto legato ai concetti di onestà, verità, logica e non compromissione, che confliggono con l’universo ancora recentemente dominato dalla televisione generalista e commerciale.
L’incapacità della sinistra a comunicare attraverso la televisione non è solo un dato di fatto, ma anche una scelta programmatica. Per tutto il corso della campagna elettorale Bersani si è rifiutato di fare propaganda proprio per evitare l’effetto ingannevole. Il rifiuto della propaganda è stato un atto di “serietà” che non ha pagato elettoralmente. La sinistra ha sperperato per questo principio quel gruzzolo di voti che aveva accumulato.
Secondo le sue analisi, nel panorama politico attuale qual è l’esempio di efficacia comunicativa? Matteo Renzi sembra proporsi come personaggio politico che riesce ad accumunare un pubblico eterogeneo alimentando un immaginario comune.
Renzi è bravo, ha idee che non possono definirsi né di destra né di sinistra e come tali possono rivolgersi a un pubblico in qualche modo più ampio, ma nasce fuori tempo. Sarebbe stato un perfetto antagonista del Berlusconi “unto dal Signore”. Oggi che Berlusconi è superato, anche la comunicazione di Renzi mostra la corda. Renzi, nella sua sfida a Bersani, ha cercato di traghettare la sinistra dalla Galassia Gutenberg alla maggioranza della tv generalista commerciale, proprio quando questo modello di televisione era ormai superato.
Ma l’uso che Berlusconi ha saputo fare della televisione generalista, ne ha rivelato per certi versi la forza residua nei partiti. In queste elezioni la televisione generalista è stata ancora essenziale.
Lo stesso Grillo, che ha fatto della rete il suo simbolo, non ha giocato su un solo tavolo. Non è andato direttamente in tv ma l’ha sfruttata.
Grillo ha infatti utilizzato tre canali per la sua campagna elettorale: la piazza, il blog e la televisione. Non comparendo mai in quest’ultima ma essendo spesso oggetto di discussione nei talk show, nei programmi d’approfondimento.
Renzi come Berlusconi è un comunicatore senza contenuti. E proprio questa cosa allarga il suo potenziale bacino elettorale. Come per l’audience, l’insieme più ampio è quello meno definito, così Renzi è un comunicatore che con un linguaggio televisivo potremmo definire generalista, e per questo motivo è inclusivo e non esclusivo. Ha una buona parola per tutti, non demonizza l’attuale classe dirigente. Vuole solo rottamarla. Nel linguaggio di Renzi si sostituisce l’attuale classe politica con una nuova. C’è discontinuità solo nel testimonial, più che nei programmi e nei contenuti.
«La rottamazione di vecchi “testimonial”» mescola il linguaggio pubblicitario, la lapidarietà degli spot, al messaggio politico. È un’esemplificazione dello sconfinamento di campi che ci riporta al punto di osservazione privilegiato, la televisione?
La cosa è ancora peggiore e le spiego perché. Oggi con Renzi si fa evidente una cosa terribile, ovvero il ruolo limitato giocato oggi dalla politica nei confronti dell’economia. È in economia il luogo dove si prendono le decisioni vere, quelle che spesso sopravanzano i singoli stati.
Compito della politica non è tanto quello di guidare le cose sulla base di scelte e valori.
Oggi la politica è ridotta a “creare maggioranza” per vincere qualsiasi tipo di elezione ma senza contenuti. Mi chiedo: perché tutti quanti si sono accodati a Renzi nel Pd anche se lui viene visto come un corpo estraneo? Proprio perché anche gli avversari interni al partito hanno capito che Renzi è capace di fare due cose che il Pd non è mai riuscito a fare: comunicare e coagulare maggioranze.
Grazie Freccero per la sua disponibilità.

(Carlo Freccero, Televisione, Bollati Boringhieri, 2013, pp. 172, euro 9)