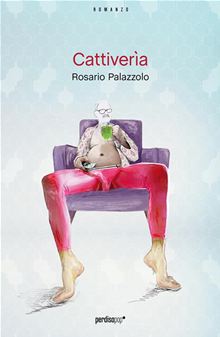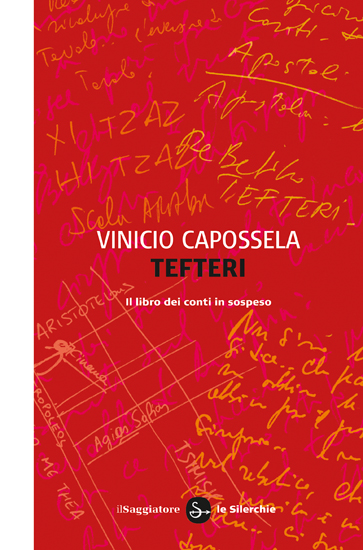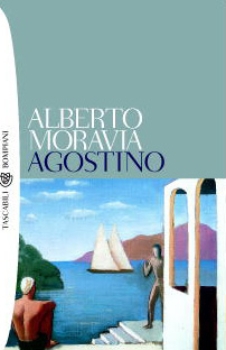Giancarlo De Cataldo è magistrato, scrittore, autore di testi teatrali e sceneggiatore. Dal suo celebre libro Romanzo criminale sono stati tratti prima un film diretto da Michele Placido, poi una serie diretta da Stefano Sollima. Da pochi giorni è in libreria la sua ultima fatica letteraria, Suburra (Einaudi, 2013). Si tratta di un noir scritto a quattro mani con il giornalista di La Repubblica Carlo Bonini.
Un romanzo certo. Ma anche un terribile e realistico affresco della Roma (e più in generale dell’Italia) contemporanea, sempre più schiava di clan criminali, speculazioni edilizie, politici corrotti, alti prelati intrallazzatori e forze dell’ordine conniventi.
Abbiamo dunque l’opportunità di farci raccontare la genesi di Suburra dall’autore stesso,ma anche l’occasione per poter parlare un po’ del nostro tempo, dell’Italia di oggi.
Innanzitutto una curiosità: Giancarlo, com’è nata l’idea di scrivere un libro insieme a Carlo Bonini? Immagino che in questa scelta abbia giocato un ruolo importante il fatto che quest’ultimo, in più occasioni, si sia occupato per conto di La Repubblica della malavita romana, in particolare del traffico di stupefacenti e delle speculazioni edilizie lungo il litorale di Ostia, temi centrali nel vostro romanzo. Da chi è partita, per esempio, l’idea della collaborazione?
Ci siamo incontrati un giorno per caso nella redazione romana della casa editrice Einaudi. Ci siamo accorti che stavamo lavorando sullo stesso soggetto, Roma oggi, e abbiamo deciso di unire le forze. È nata insieme, questa collaborazione.
Scrivere a quattro mani un romanzo è sicuramente molto diverso dal prendere parte alla stesura collettiva di un saggio, ovvero di un testo specialistico in cui ogni autore porta in dote le proprie conoscenze, come può fare anche in maniera individuale. In questo caso, invece, si è trattato di ideare personaggi, costruire dialoghi, ambientare delle scene. Che metodo di lavoro avete seguito?
Nella prima fase abbiamo ideato, attraverso lunghe riunioni, una “scaletta” degli eventi e, contestualmente, individuato i personaggi e poi identificato gli snodi narrativi e predeterminato l’esito di ciascun “surplot” cioé, in soldoni, ci siamo raccontati inizio, sviluppo e fine dei destini dei nostri eroi. Ci siamo divisi i capitoli e abbiamo cominciato a scriverli. Ce li scambiavamo, li leggevamo a voce alta, intervenivamo, integravamo, cambiavamo in corso d’opera ciò che non ci convinceva. Alla fine, autonomamente, abbiamo “riscritto” l’intero romanzo, adattando le varie parti che stridevano alla lingua comune che si stava costruendo. Infine, abbiamo letto ancora a voce alta ma con la presenza di Severino Cesari, l’editore/editor di Einaudi Stile Libero al quale, per il suo ruolo determinante, abbiamo dedicato il libro. Et voilà, ecco, nel bene e nel male, Suburra.
Leggendo una recente inchiesta riguardo alla malavita del litorale romano effettuata proprio da Bonini, ho trovato tantissime analogie con il vostro racconto. Dagli incendi agli stabilimenti, alla speculazione edilizia, agli omicidi fatti passare dalla stampa come episodi di piccola criminalità, magari legata all’immigrazione, perché si sa, a Roma non c’è la mafia… Ecco, a questo proposito, quanto c’è del “Bonini giornalista di inchiesta” e del “De Cataldo magistrato” in questa vostra opera? Sembra proprio in effetti che dietro ci sia un grosso lavoro di indagine e di documentazione.
Documentazione e indagine non mancano mai, nel nostro modus operandi. Però, attenzione: mentre Romanzo criminale, per esempio, era un’opera che pescava a piene mani nella Storia, una storia ormai consacrata da atti giudiziari, dichiarazioni dei protagonisti, ricostruzioni degli storici di mestiere, in Suburra c’è una notevole parte d’invenzione, visto che si prende spunto da fatti recenti, anzi, recentissimi. Non sapevamo, mentre scrivevamo, come sarebbe andata a finire, e non lo sappiamo neanche adesso. Quindi, abbiamo inventato molto.
La Suburra nell’antica Roma era un quartiere situato fra il Quirinale, il Viminale e l’Esquilino, perlopiù popolato da gente di malaffare, tant’è che oggigiorno il termine rimane in uso per indicare un luogo in cui regna la criminalità. Dunque, in pochi anni, siamo passati dalla “Gomorra” di Roberto Saviano alla “Suburra” di Bonini e De Cataldo. Prima Napoli e adesso Roma come metafora di un intero Paese sempre più sprofondato nel marcio? Nel libro, a un certo punto, un carabiniere afferma che Roma va salvata da sé stessa. Tuttavia, l’impressione che si ha è che stia pensando più all’Italia intera che a un’unica città. Gomorra non fece una bella fine (fu distrutta a causa della corruzione dei suoi abitanti). Riuscirà invece Suburra (riusciranno Roma e l’Italia) a salvarsi?
Il contenuto metaforico è indubitabile, e apertamente denunciato: nella scena degli scontri di San Giovanni, la Suburra come luogo storico romano è dichiaratamente evocata. Comunque, né Carlo né io siamo iscritti al partito dei pessimisti apocalittici (tutto è perduto) e nemmeno a quello di coloro che rimpiangono il tempo andato (è tutto sbagliato, è tutto da rifare, si stava meglio quando si stava peggio, ecc.). Abbiamo figli ragazzi (lui addirittura bambini) e se comunicassimo un senso di rassegnazione saremmo di pessimo esempio. Finché ci saranno leali servitori dello Stato e finché ci sarà la libertà di esprimere le proprie idee e di metterle in scena in forma narrativa, nulla sarà veramente perduto. È una fase dialettica, di cambiamento. Non si può dare niente per scontato. L’Italia ha passato periodi peggiori (il Fascismo, due guerre mondiali) e si è sempre ripresa. Ce la faremo anche questa volta.
È vero. In effetti l’Italia sembra sempre passare di crisi in crisi per poi uscirne, salvo poi ripiombiare nel baratro. A questo proposito i sociologi hanno spesso fatto notare come nel nostro Paese, in epoca moderna, non sia mai nata una “religione civile”, un ethos collettivo capace di tenere unito l’individuo alla società. Le persone dunque (non tutte ovviamente), si comportano come se non avessero la consapevolezza di vivere in una comunità, cercando esclusivamente il proprio tornaconto personale anche attraverso la prevaricazione. È la certezza di farla franca che, per esempio, nel vostro romanzo fa affermare con spavalderia a un politico corrotto: «L’Italia non cambierà mai. Noi staremo sempre sopra, e i miserabili sotto». Che ne pensa di questa chiave di lettura? Lo chiedo oltre che allo scrittore anche e soprattutto al magistrato. Del resto lei, per il ruolo che svolge, ha un osservatorio privilegiato. E l’Italia, cambierà mai?
L’Italia si confronta sin dalla sua fondazione con la convivenza di due opposte tendenze: una rapinosa, egoistica, gretta avida e meschina, l’altra solidale, aperta sul mondo, orgogliosa di una missione culturale che la nostra Storia ci assegna. L’Italia degli affaristi e dei gattopardi e quella nobile di Mazzini convivono da sempre. Di solito è la prima a prevalere, ma la seconda riesce a contenerne gli effetti devastanti. Quanto al magistrato, il rispetto della legge è soltanto uno degli aspetti del problema. Non si possono risolvere i problemi della collettività a botte di sentenze: quelle servono, ma a riparare un danno. Mentre noi dovremmo lavorare tutti per creare le condizioni perché i danni non si creino, o per limitarne la portata. Il che presuppone massicci investimenti in cultura, etica, educazione al senso collettivo. Guai a pensare che le manette rimettano le cose a posto!
Poco fa, ha fatto riferimento a servitori dello Stato leali e alla libertà di stampa. Fortunatamente, ve ne sono molti, così come molti sono i giornalisti liberi e amanti della verità. Tuttavia, credo che Suburra fotografi molto bene un aspetto emblematico dei nostri tempi: la contiguità. Nel libro succede sovente che nei medesimi luoghi (magari un noto ristorante oppure un “salotto buono”) si possano incontrare indistintamente faccendieri, giornalisti, alti prelati, escort, politici ed esponenti delle forze dell’ordine. Non necessariamente tutti questi individui si trovano lì per delinquere. Tutto ciò lascia però la sensazione che non ci sia più distinzione né di luoghi né di ruoli, che tutti siano amici di tutti e che tutti vadano ovunque. Questa situazione rispecchia, dal mio punto di vista, anche l’Italia di oggi, dove i controllori sono spesso amici dei controllati (se non nominati dagli stessi) e i giornalisti, magari, danno del tu ai politici che intervistano. In poche parole, si forma una casta in cui il delinquere diviene quasi fisiologico, lei che ne pensa?
Mah, sono due questioni diverse. La seconda, che potremmo definire “conflitto prolungato d’interessi”, si risolve sul piano legale e amministrativo con provvedimenti fatti bene. Esempio: che i gruppi industriali esercitino pressioni sulla politica è notorio. Infatti, la democrazia americana ha istituzionalizzato la prassi disegnando la figura del “lobbysta” e ponendolo sotto controllo di legge. Potremmo fare, nella trasparenza massima, qualcosa di analogo, piuttosto che inseguire un’astratta e utopistica purezza francescana in base alla quale il politico è povero, scaciato, viaggia in autostop e colleziona maniacalmente gli scontrini del caffè, comunica via web solo con i suoi elettori, altrettanto puri di cuore, e diviene sostanzialmente una figura innocua se non dannosa. La prima questione, invece, è irrisolvibile sul piano tecnico: ciascuno può andare dove gli pare e frequentare chi gli pare. Perciò, ancora una volta, dipende da come il cuore e la coscienza degli uomini si atteggiano: educazione, istruzione, cultura. Siamo sempre là, non ti pare?
Certo, mi riferivo proprio a questo quando parlavo di ethos collettivo; non so neanche più in effetti se nelle scuole italiane si insegni tuttora educazione civica. Per concludere, vorrei parlare un attimo dei suoi tre grandi romanzi che hanno affrontato, fra realtà e fantasia, la cronaca italiana. Con Romanzo criminale ha tracciato un affresco della malavita degli anni Settanta-Ottanta, con Nelle mani giuste ha descritto gli anni Novanta, il periodo delle stragi di mafia e di Tangentopoli. Ora, con Suburra, siamo al crepuscolo della cosiddetta Seconda Repubblica. Alcuni personaggi sono persino gli stessi (si pensi alla banda della Magliana o, comunque, a chi di essa rimane). Anche lei dunque come James Ellroy (autore con American Tabloid, Sei pezzi da mille e Il sangue è randagio della Trilogia Americana) ha saputo creare una trilogia, una fiction, riuscendo a immaginare trent’anni di storia non solo criminale ma anche sociale e politica italiana. È solo una mia impressione o c’è stata sin dall’inizio l’intenzione di narrare questa grande storia? Ha mai pensato all’opera di Ellroy come un esempio da cui trarre ispirazione?
Inizialmente Romanzo criminale doveva chiamarsi Italian Tabloid, tanto era vivo e recente l’esempio di American Tabloid. In realtà, i miei veri maestri sono altrove: Balzac, Dickens, Maupassant. Narratori di destini individuali che si intrecciano con la Storia e ne diventano metafora. Da questo punto di vista, Romanzo e Suburra sono narrazioni storiche e “classiche”, anche se pescano in vari generi letterari (c’è più satira che noir in Suburra, secondo me).
Quindi, non parlerebbe di una vera e propria trilogia. Peraltro, se lo fosse stata, vorrebbe dire che saremmo giunti ora alla fine di un percorso. Che l’idea di ricostruire quarant’anni di storia criminale sarebbe giunta al termine.
Non credo che Suburra si possa legare né a Romanzo criminale né a Nelle mani giuste. Quel mondo, vedi, si reggeva su un grande collante: l’anticomunismo. Eravamo tutti figli della guerra fredda, e pertanto persino una banda criminale poteva avere un suo valore specifico come strumento da usare nella lotta ai “rossi”. Oggi siamo in un mondo completamente diverso. La guerra fredda aveva un che di nobile, perché inscenava la contrapposizione fra ideologie forti, ciascuna delle quali espressiva di una visione del mondo sostanzialmente tesa al governo del reale (e al sogno del possibile). Oggi siamo preda di un’unica ideologia – il liberismo – che sembra avere in odio l’idea stessa di governo: l’anima, l’essenza, è nell’osservazione del libero dispiegarsi delle forze del mercato, Osservazione, e non governo. Questo, almeno, ci viene venduto. In realtà, siamo avvinti da un reticolato di controlli asfissianti, calati in una realtà tanto parcellizzata da rendere impossibile, quasi sempre, l’identificazione di un “responsabile”. Chi decide dove confluiranno i fondi d’investimento X e Y? E a chi interessa se la scelta determinerà l’arricchimento di qualcuno e la catastrofe di molti altri? Siamo in un altro mondo. E Suburra cerca, a suo modo, di raccontarne un pezzettino.
E ci riesce benissimo: grazie a Giancarlo De Cataldo.

(Carlo Bonini, Giancarlo De Cataldo, Suburra, Einaudi, 2013, pp. 481, euro 19,50)









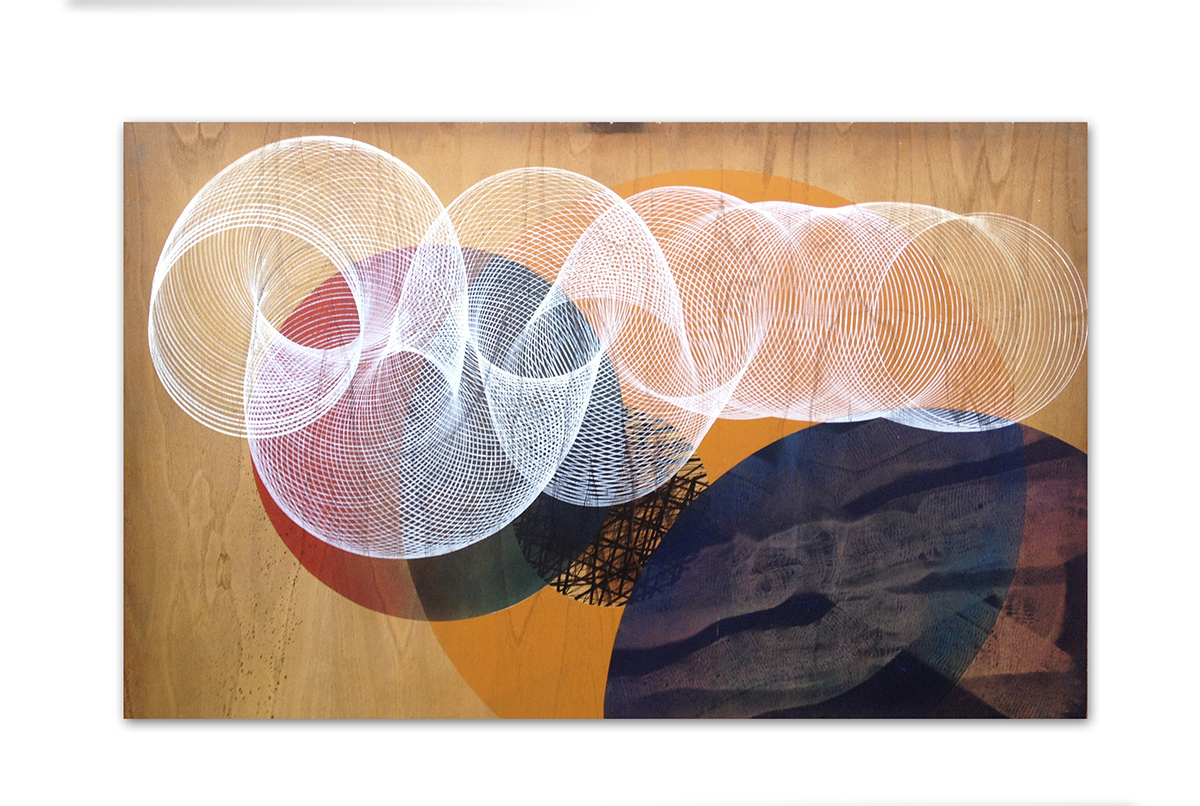
.jpg)