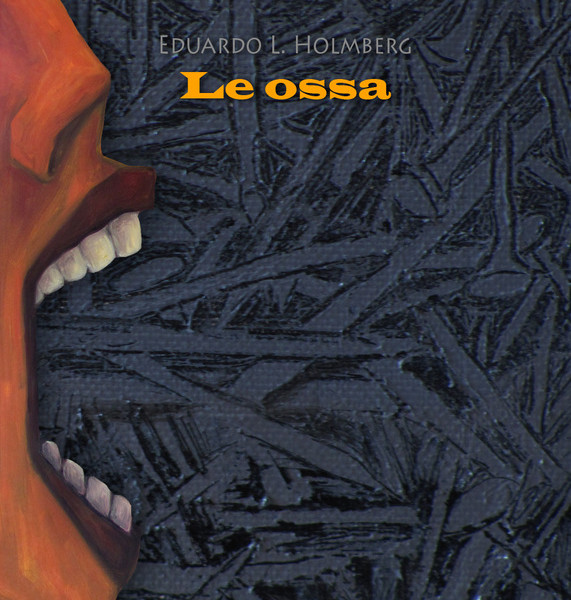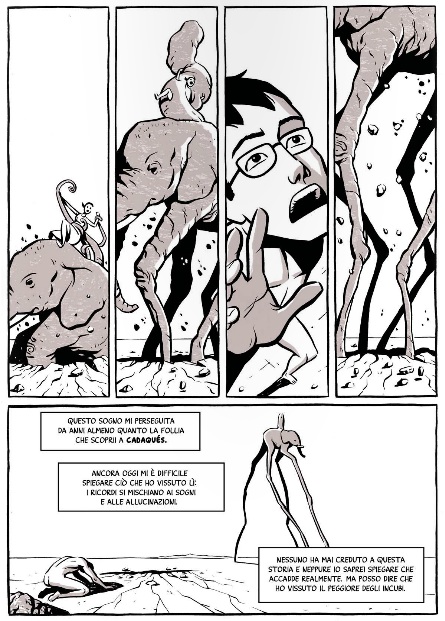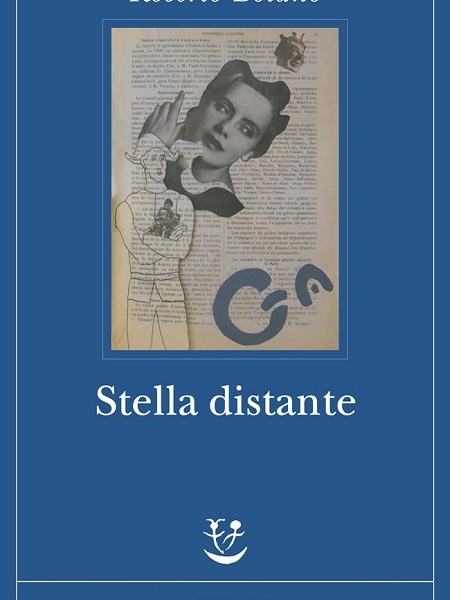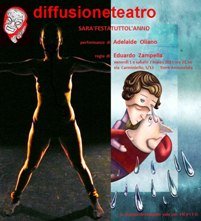A due giorni dalla Flanerí night #5 dell’11 aprile conosciamo meglio i Montag, Grannies Club e Downpour Swing Band, i tre gruppi che a partire dalle 22 animeranno per noi il palco del Contestaccio per oltre due ore di musica dal vivo.
Ricordiamo che durante la serata verranno proiettate inoltre le tavole dell’eBook illustrato Mr. Minimal 00 – Il piacere è tutto mio, di Gabriele Mannarino, pubblicato da Il Menocchio eBook e co.
Montag
Cos’è, oggi, il post-rock?
Siamo decisamente convinti che oggi, il termine post rock, con l’accezione classica che gli si dà, non significhi assolutamente più nulla. Un’etichetta come tante per definire in modo comodo una certa maniera di fare musica ma, in definitiva, una corrente i cui margini, ormai, sono talmente sottili da confondersi con tutto il resto. Quando anni fa si parlava di indie rock, la gente pensava a una certa chitarra o a una certa batteria, ma era solo uno modo di suonare in quella particolare epoca musicale, in maniera indipendente e fuori dal circuito mainstream, nel migliore dei casi. Indie rock non significa più i Franz Ferdinand, e allo stesso modo post rock non significa più i Sigur Rós e per i più sarebbe sconvolgente ragionare sul fatto che in realtà qualsiasi cosa possa essere indie rock almeno quanto possa essere post-rock. Quello che fanno i Montag, quando sono sul palco, è creare ambienti sonori che la gente possa sfruttare a suo piacimento, senza il vincolo e il limite di un testo o dell’interpretazione di una voce che per forza di cose guidi l’ascoltatore. Ci piace pensare che se un pezzo è triste, evocativo o esaltante, sia chi l’ascolta a deciderlo, noi semplicemente mettiamo a disposizione uno spazio all’interno del quale ognuno possa crearsi le immagini che preferisce. Ecco, se ci fosse l’assoluta necessità di una definizione del post-rock sarebbe questa, il più democratico dei modi possibile di fare musica.
In cosa può evolversi una corrente musicale che, forse, ha avuto la sua massima espressione negli anni ’00?
Fare musica nasce da un’esigenza, ci piace pensarla così. Si fa musica per bisogno di esprimersi, senza pensarla in maniera filologica. Pensare a sedicenti correnti musicali che abbiano esaurito o meno la propria potenzialità espressiva è roba da giornalisti, da critici o da filologi musicali appunto. Se proprio bisogna parlare di etichette per noi le paroline post e rock vogliono rappresentare un’attitudine più che un genere o una corrente. È come dire punk, o hardcore, soltanto con un impatto un po’ diverso e un senso più concettuale. È qualcosa che ha a che vedere con l’idea di utilizzo di attrezzi, utensili, strumenti (le chitarre, i bassi, gli effetti, una batteria) propri di un linguaggio (in questo caso il rock) ma per usarli in maniera diversa, alternativa, per composizioni libere che trascendono dai classici sviluppi del rock così come siamo abituati a intenderlo.
Quali sono i vostri modelli?
I nostri modelli guardano più alla cinematografia che al mondo musicale. Prendiamo i vecchi film giapponesi per esempio: sono molto lunghi, dilatati e non hanno praticamente nessun dialogo, se non alcune frasi scambiate sporadicamente dai protagonisti. Noi Montag abbiamo un simile approccio: pezzi strumentali dilatati, quasi rarefatti, come film con una fotografia perfetta, dove la trama è secondaria, ma le luci e i colori devono essere impeccabili. Questi sono i modelli ai quali ci ispiriamo. Musicalmente parlando poi ci sono sostanziali differenze tra i vari componenti della band, per cui in ogni nostro pezzo si sentono differenti influenze che si scontrano tra loro per creare un equilibrio stabile.

Facebook: https://www.facebook.com/montagtheband?fref=ts
Grannies Club
Cosa comporta scrivere testi in inglese per un gruppo italiano, da un punto di vista artistico e non commerciale?
È un fatto di ritmo, per lo più. L’inglese ha una musicalità diversa dall’italiano, che si sposa meglio e più velocemente con il rock’n’roll. Di sicuro conta anche molto la musica su cui io e gli altri del gruppo ci siamo formati. Se cresci con i classici degli anni cinquanta e sessanta nelle orecchie, hai imparato a canticchiare dall’infanzia in una lingua che non è la tua. Per noi è stato quasi automatico scrivere in inglese. Nel nord Europa è considerato normale. Mi sono sempre chiesto perché non poter essere come gli svedesi The Hives e Mando Diao dopo tutto.
È possibile che, da quando gli Afterhours (2009, con “Il paese è reale” e l’esibizione a Sanremo) hanno in qualche modo gettato luce sull’underground italiano, convenga, da un punto di vista commerciale, comporre canzoni in italiano?
Dipende da quello che si vuole fare. Se sei italiano, vivi in Italia e suoni in Italia prima o poi con la tua lingua madre ci devi venire a patti, perché questo Paese non è interessato prima di tutto a certi generi musicali, fra cui il rock’n’roll, e in secondo luogo non dimostra alcun interesse per il cantato in inglese. L’inglese è accettato solo ed esclusivamente dagli artisti stranieri. Quindi è ovvio che per ragioni commerciali l’italiano convenga. Il mercato discografico è un fossile un po’ ovunque, ma se in Italia devono scegliere se investire qualche soldo di certo non lo fanno su un artista che canta in inglese.
Cosa ha significato vedere i vostri brani finire in un programma Rai di grande successo?
Dare le nostre canzoni a una fiction in onda su Rai Uno è stato emozionante. Avevamo già provato quella sensazione quando il video di “Never” venne messo in rotazione su Mtv Brand New, ma capire che quello che hai scritto, suonato in giro, inciso a tue complete spese sia poi risultato utile al lavoro creativo di qualcun altro, e degno di essere infilato in un programma di prima fascia su Rai Uno, è una bella sensazione. Ti aiuta a pensare di non essere totalmente pazzo a fare la vita che fai con tanta fatica. Quando poi sulla pagina Facebook ufficiale della fiction le nostre canzoni sono state scambiate con quelle dei Rolling Stones e ci è toccato pure rettificare, abbiamo quasi pensato di poterci montare la testa. Giusto un minuto. Poi eccoci qua. Non è mica cambiato granché. Ci chiediamo oggi cosa sia necessario per essere considerati una band di belle speranze dagli addetti ai lavori. Colonna sonora? Fatta. Video su Mtv? Fatto. Adesso dovrebbe anche partire un programma di Sky con un nostro pezzo in sigla. Who Knows? Per il momento noi suoniamo, ci divertiamo e facciamo divertire.

Maggiori informazioni:www.granniesclub.com
Downpour Swing band
Che tipo di mercato è quello del jazz, oggi, in Italia?
Del mercato jazz italiano non sappiamo nulla. Non ci interessa tanto in realtà, siamo nati da poco e quello che vogliamo è suonare, crescere come musicisti e far stare bene le persone che ci ascoltano!
Avete mai pensato di lasciare l’Italia, magari di avere maggiori possibilità all’estero?
All’estero sarebbe fantastico, ma prima bisogna conoscere bene la realtà musicale dei live in Italia: vogliamo viverla come fosse una palestra.
Quali gruppi vorreste aprire in un concerto?
Ci piacerebbe aprire a tutti i gruppi che fossero disposti a sopportare sette matti come noi!
Non ci resta che attendere giovedì 11 aprile.