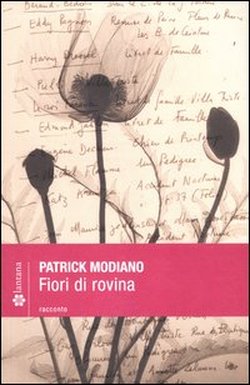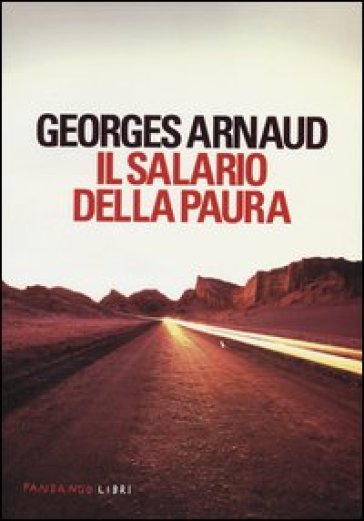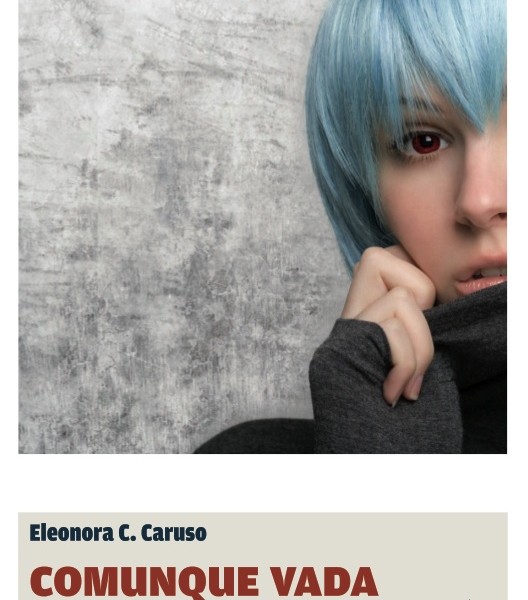«La notte è così profonda con i suoi odori di vino e di carbone e i ruggiti delle bestie feroci che un barbone può cadere dal ponte di una chiatta sulla Senna, annegare e nessuno ci fa caso».
Immaginiamo una notte buia e impenetrabile o nebbiosa e rarefatta, ebbene in questo scenario è ambientato l’ultimo romanzo di Patrick Modiano, Fiori di rovina, pubblicato in Italia da Lantana edizioni nel 2012.
Il punto di partenza della narrazione è un fatto di cronaca accaduto il 24 aprile 1933: due giovani sposi si suicidano in circostanze misteriose. Molti anni dopo un uomo andrà alla ricerca delle motivazioni profonde che hanno spinto al gesto estremo, cercando di raccogliere indizi e testimonianze per ricostruire i fatti.
Fiori di rovina è il titolo suggestivo ed evocativo insieme di un’opera fortemente autobiografica in cui si muove il narratore/protagonista flâneur in una Parigi notturna in decadenza. I quartieri della ville lumière avvolti nel mistero sono attraversati in silenzio dallo scrittore/detective nell’intento di ricostruire la drammatica vicenda dei coniugi T. «Quella domenica sera di novembre» l’uomo percorre vicoli e strade in cui ha giocato da bambino, si muove in luoghi divenuti familiari alla sua topografia affettiva: la Rive gauche, Saint-Germain-des-Prés e il Quartiere Latino.
La narrazione riflette sensazioni epidermiche, forme e colori vengono restituiti per mezzo di impercettibili stimoli che sfiorano la sensibilità dei lettori: «Avevo la sensazione», «sembra». La visione che ne risulta è offuscata, sfocata sia che si tratti di un ricordo («la luce cadeva da un vetro sporco e coperto di ragnatele»), di un sogno o della realtà: «invano spalanco gli occhi nel buio».
L’opera di Modiano può essere considerata un tentativo di strappare all’oblío i ricordi e far ritornare alla memoria gli eventi del passato. Man mano che il protagonista si addentra nel mistero, anche nella sua vita personale emergono dei vuoti; la figura del padre, presente anche in altre opere, è centrale ma qui si fa insistente nel rimpianto di una perdita definitiva: «Pensavo a mio padre (…) l’enigma di un uomo che non avevo nessuna possibilità di ritrovare, e tutte quelle domande che non avrebbero mai avuto risposta». La parola “enigma” torna per esprimere il vuoto incolmabile di un rapporto non vissuto cui il padre inafferrabile si è sottratto per sempre.
La spazialità parigina è descritta rendendo omaggio a un grande poeta che ha fatto innamorare intere generazioni, come non sentire l’eco di Prévert nel seguente passo: «Quando pioveva in rue d’Odessa…mi sentivo in un porto bretone sotto l’acquerugiola. Dalla stazione…sfuggivano folate di Brest.” Brest, città tanto cara al poeta, incanta nella poesia “Rappelle-toi Barbara» («Ricordati Barbara/pioveva senza tregua quel giorno su Brest»), la stessa pioggia che annebbia la vista, la stessa inguaribile malinconia che attanaglia il cuore. Il giardino del Parc Montsouris, in cui il protagonista passeggia, fa da décor al “bacio” Prévertiano tra innamorati: «Des milliers et des milliers d’années/ne pourraient suffire/pour dire/la petite seconde d’éternité/où tu m’as embrassé/où je t’ai embrassée…au Parc Montsouris à Paris/à Paris/sur la terre/la terre qui est un astre» (Mille anni e poi mille/non possono bastare/per dire/la microeternità/di quando m’hai baciato/di quando t’ho baciata…al Parc Montsouris a Parigi/a Parigi/sulla terra/la terra che è un astro).
Fiori di rovina spuntano «tra vasche e statue rotte, pietre e foglie secche» e proprio in un giardinetto frequentato con il fratello negli anni dell’infanzia «le lancette dell’orologio non camminavano. Indicavano eternamente le cinque e mezza. Quelle lancette ci avvolgevano in un silenzio profondo e rassicurante. Basta restare nel viale e niente cambierà mai». Il tempo si è fermato in un istante preciso nel passato e solo voltandosi indietro si può cullare ancora l’illusione di un sogno.
(Patrick Modiano, Fiori di rovina, trad. di Maruzza Loira, Lantana, 2012, pp.113, euro 13,50)