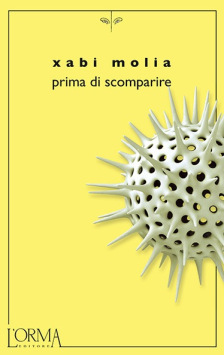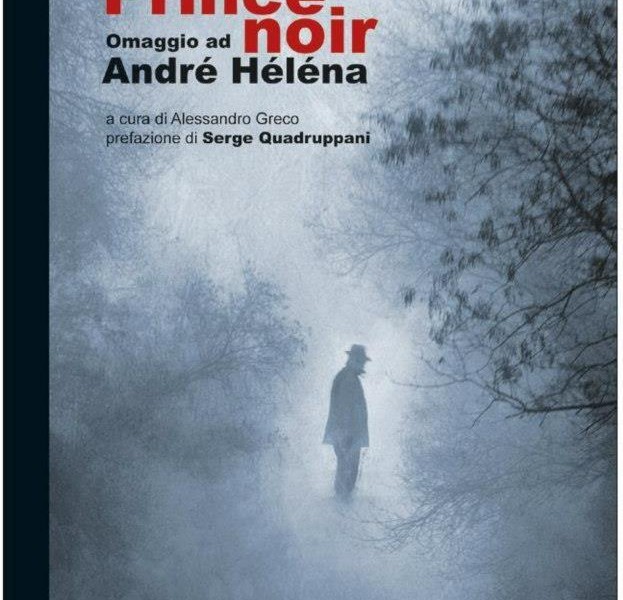Cinque libri pubblicati all’età di 35 anni: sei entrato molto presto nel mondo della letteratura (i primi premi arrivano nel 1997, il primo romanzo è del 2000), hai mai sentito su di te il peso e a volte i pregiudizi dell’essere un giovane autore di punta nella letteratura francese?
Sarebbe bello sentire della pressione, perché vorrebbe dire importare qualcosa nella letteratura francese! Quando ho iniziato mi sentivo molto solo perché ero molto giovane – ho pubblicato il mio primo libro quando avevo 22 anni – e nessuno della mia età stava pubblicando; il libro non è andato, non è successo niente e mi sono reso conto di quanto potesse esser difficile essere uno scrittore. Ai francesi non piace la letteratura francese, preferiscono la letteratura straniera, americana, credono che la letteratura francese sia noiosa, forse è per colpa del nouveau roman, che è visto come qualcosa di molto intellettuale. Io prendevo spunto dalla cultura pop, volevo scrivere qualcosa che fosse letterario e d’evasione al tempo stesso; penso che tutti gli scrittori della mia età provino questa voglia, forse ora qualcosa sta cambiando davvero, ma all’inizio è stato molto difficile.
Prima di scomparire è stato ben accolto in Francia; quella italiana è la prima traduzione? Pensi che con la traduzione si possa perdere “qualcosa” dei tuoi romanzi?
Quella italiana è la mia prima traduzione in generale. All’inizio non ci credevo davvero che un editore italiano volesse tradurre il mio libro, per noi gli italiani non sono molto seri [ride, ndr], non pensavo sarebbe mai successo! Comunque non è la mia prima esperienza fuori dalla Francia; come regista ho viaggiato molto. Con la letteratura però è diverso, perché mostri il tuo libro a persone che sono molto lontane dal tuo mondo.
Sinceramente, spero che qualcosa sia andato perso nella traduzione! Se c’è qualcosa di perso allora vuol dire che ho scritto qualcosa di difficile da tradurre, se è così vuol dire che il mio linguaggio è stato molto preciso in francese, molto originale.
Nel tuo libro mi è sembrato di leggere spesso dei rimandi alla realtà contemporanea: quello che ci sta intorno è stato per te fonte di ispirazione o collegamenti per il romanzo?
Volevo scrivere un libro sulla situazione francese prima della seconda guerra mondiale – il governo Vichy, quando i francesi collaborarono con i nazisti – ma non ero abbastanza storico per essere uno storico. Così mi sono chiesto: come scrivere di questa vergogna, di questo periodo? Ho preso la storia e l’ho spostata nella letteratura, nel mio libro. Ma è anche uno sguardo verso alla realtà dei sans papiers, che ora vivono in una posizione di stallo nella società francese: come in passato preferivamo non vedere cosa succedeva con i nazisti, oggi non vogliamo vedere cosa succede ai sans papiers, preferiamo essere un po’ ciechi forse.
Le narrazioni di spunto apocalittico e post-apocalittico sono molto numerose ultimamente; secondo te si può parlare di vera e propria corrente? Come potresti spiegarti questa “tendenza”?
La mia tesi di dottorato era sui film apocalittici; alle volte non bellissimi film, ma sempre interessanti. Ed è interessante che l’idea della fine del mondo ci spaventa e ci attrae allo stesso tempo. Amiamo l’idea della fine, del mondo che brucia. E nonostante un’intera tesi e la relativa ricerca, non ho ben chiaro il meccanismo per cui tutto ciò risulti così interessante.
È un tema frequente nei videogiochi, nei film, nella musica… e quando Prima di scomparire è stato pubblicato, in libreria c’erano altre due o tre novità che trattavano della fine del mondo. Mi son chiesto come avrei potuto parlare di qualcosa che fosse appunto così comune, con i suoi cliché, e renderlo qualcosa di mio, originale, nuovo per il lettore.
Sei uno scrittore, ma anche uno sceneggiatore e insegnante di cinema all’università di Poitiers; in che modo nei tuoi romanzi i due mondi si incontrano o si scontrano? O tieni sempre separate le due parti? Ho notato parecchie “inquadrature”, leggendo il libro, come quella veramente cinematografica della Tour Eiffel spezzata.
La mia speranza è che non abbiano niente in comune. Quando scrivo penso solo a quello che può dare la letteratura; un sacco di persone mi dicono che da questo libro potrei trarre un buon film, per l’atmosfera; ma buona parte del libro è fatta di pensieri del protagonista. Quando lavori su un film hai un limite che è anche una sfida, quello di mostrare solo l’apparenza delle cose. Nei libri questo limite non esiste. Per me ogni storia ha bisogno della sua piattaforma. Gli adattamenti non riescono mai alla perfezione. Un ottimo libro secondo me non si può trasporre in un film. Per quando riguarda la Tour Eiffel spezzata, be’, raccontarlo in un libro è molto più economico, non potrei romperla per un film, non credo di potermelo permettere! [ride, ndr.]
Nel romanzo, dopo le mutazioni e la semidistruzione dello stato, i cittadini diventano letterati, filosofi, artisti, attori: credi davvero che in presenza di una catastrofe simile l’uomo possa ritrovare sé stesso, anziché scordarsene del tutto e confondersi nel caos che lo circonda?
La mia idea è che quando accade qualcosa di terribile la gente cerca di essere estremamente normale; il governo farebbe propaganda dicendo: «Leggi! Vai al cinema!». Credo succederebbe una cosa del genere. Questo, almeno, è quello che sta succedendo in Giappone. In Prima di scomparire i personaggi attingono alla cultura ma lo fanno in modo molto superficiale, è una “tendenza” di normalità, è anche una parte satirica del romanzo.
In caso di apocalisse, comunque, non credo diventeremmo mostri anche noi.

(Xabi Molia, Prima di scomparire, trad. di Stefano Lazzarin, L’Orma editore, 2012, pp. 352, euro 14,50)