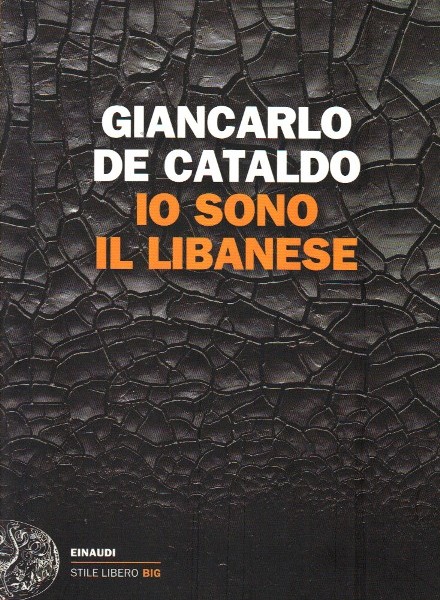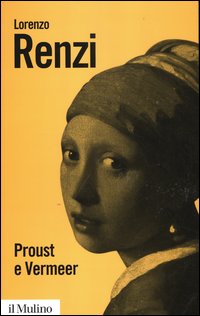Capita a tutti di incorrere in uno strafalcione, non c’è che dire. Non tutti lo fanno indossando la veste di giornalista e in questo caso lo strafalcione rischia di assurgere a etichetta negativa di un’intera categoria, soprattutto se il fenomeno si ripete tanto spesso. Forse è una simile considerazione che ha mosso il giornalista-scrittore Gianluigi Gasparri a mettere insieme in un unico testo, Strafalciopoli. Dove la cronaca si fa comica (La Lepre Edizioni, 2012), una serie di errori/orrori di colleghi di varia provenienza, che negli anni gli è capitato di osservare (dal punto di vista, lui sì, di affermato cronista). Certo fra i più giovani e inesperti il rischio di scrivere nefandezze è più elevato, ma nel regno di Strafalciopli trionfa la democrazia e la possibilità di accogliere nuovi adepti non viene negata a nessuno. La fucina è rappresentata da quel giornalismo di periferia caratterizzato sovente da una giustificabile frustrazione. A volte è l’ansia di ricercare la notizia a tutti i costi, altre ancora è una sorta di mania di grandezza da scoop che porta alla creazione di vere e proprie chicche (involontarie) di pura comicità. La reazione del lettore è anzitutto quella di una grassa, ricca risata, per poi lasciare spazio all’inevitabile stupore e alla domanda su come sia stato possibile giungere a tali nonsense.
Il livello (assai basso) raggiunto dagli strafalcioni emerge lampante dal testo. Come quando viene riportato da un reporter che un uomo «ha il vizio di spaventare le signore e le signorine mostrando le sue discutibili grazie. Quella di cui è vittima il giovane, è codificata fra le devianze sessuali come la necrofilia». Di terreni fertili per gli autori di strafalcioni se ne trovano in abbondanza, con una crescita continua di frutti che non sembra conoscere crisi. D’altronde, se raccontando le vicende di un Comune inoperoso (a dire del cronista), si può scrivere che l’amministrazione non «spiega il perché della cacalessi di fronte ai bisogni impellenti della popolazione», allora tutto è possibile. È possibile anche leggere «Dionigi l’areofagita» e che i fan di Albertazzi «pendevano dalle sue orecchie».
Il tutto sotto lo sguardo severo di Gasparri, che non si capacita degli errori, tranciando di netto l’operato degli sfortunati giornalisti con una verve satirica potente. I commenti dell’autore agli strafalcioni sono fendenti che non perdonano, pur mantenendo un angolo di visuale ironico sull’intera faccenda. Il libro suscita un innegabile interesse grazie all’aggiunta, di tassello in tassello, di “perle” giornalistiche davvero clamorose. Manca forse un più incisivo riferimento all’inadeguatezza di certe “penne” all’interno della questione del giornalismo odierno, pur non essendo questo lo spazio adatto a una trattazione saggistica approfondita sull’argomento.
Il tessuto del testo è in definitiva dato dalla giustapposizione dei vari strafalcioni, conferendo alla comicità la cifra distintiva del libro. E come potrebbe non essere altrimenti, se uno dei giornalisti protagonisti delle chicche evidenzia che «resta da stabilire se il medico poteva fare qualcosa per allungare la vita al defunto che era affetto da una patologia piuttosto gravissima e inesorabile». Capita a tutti di incorrere in uno strafalcione. A qualcuno più spesso e con maggiore originalità.
(Gianluigi Gasparri, Strafalciopoli. Dove la cronaca si fa comica, La Lepre Edizioni, 2012, pp. 166, euro 16)