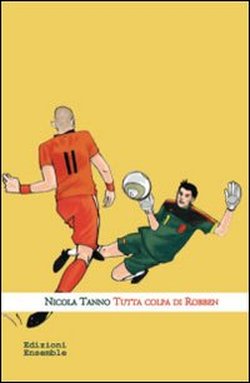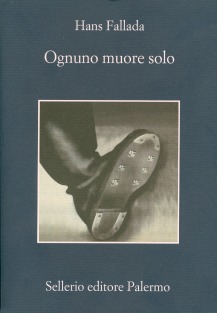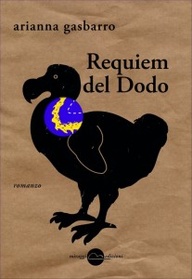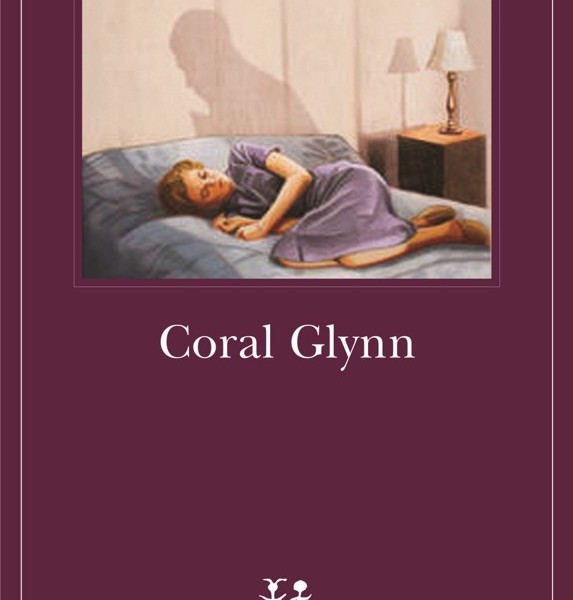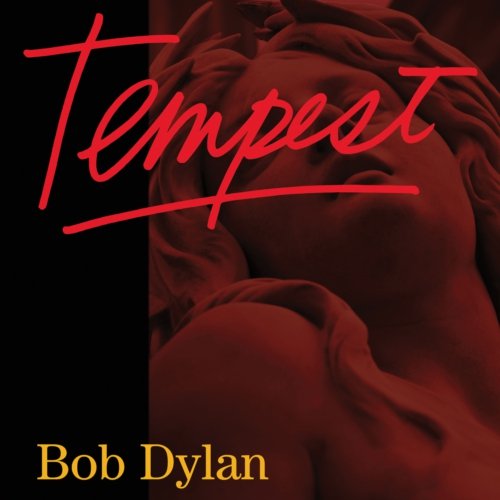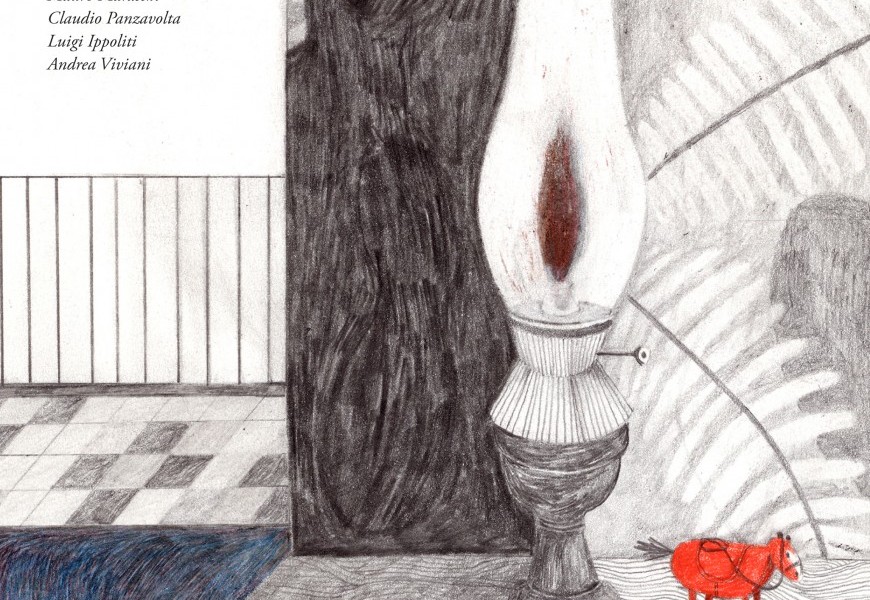La macchina televisiva americana è pronta. E noi con lei. Tra conferme ed esordi, il nuovo anno di serie tv può cominciare e con esso, la nuova sezione di Flanerí – “LaSerie” –, impegnata e appassionata ad accompagnarvi puntata dopo puntata.
C’è chi ha iniziato la preparazione in anticipo, e si è fatto trovare pronto già a luglio per la premiere: parliamo del canale via cavo TNT, che ha presentato in piena estate Perception, la nuova serie procedurale che vede Eric McCormack (noto al grande pubblico per aver interpretato Will in Will & Grace, ricevendo svariate nomination e due Emmy Awards) nel ruolo di Daniel Pierce, brillante neuropsichiatra contattato dall’agente speciale Kate Moretti per aiutare l’Fbi nei casi più complessi. Ma Kate non conosce il lato oscuro di Daniel: la sua schizofrenia, che spesso sfocia in allucinazioni, fobie e paranoie e in comportamenti eccentrici. In questo caso, cogliere gli spettatori di sorpresa è stata una mossa intelligente, e dopo aver ricevuto buone risposte da pubblico e critica, Perception (che ha chiuso con il decimo episodio andato in onda il 17 settembre) è stato già rinnovato per una seconda stagione con tredici episodi, lanciando nell’Olimpo delle series-star uno tra i personaggi più affascinanti e appassionanti.
Gli altri sono rimasti a guardare? Ovviamente no. E da agosto (e soprattutto settembre) il calendario si fa fittissimo: sarebbe difficile e davvero lungo soffermarsi su tutte le serie meritevoli, come Copper – trasmesso dalla BBC America e ambientato negli Stati Uniti nel 1860, in piena guerra civile, per seguire le vicende di Kevin Corcoran, un investigatore immigrato dall’Irlanda assegnato ai Five Points, un quartiere vicino Manhattan, che oltre a cercare di mantenere l’ordine indaga sulla scomparsa della moglie e sulla morte della figlia – o Vegas – Western drama ambientato nella Las Vegas degli anni ’60 con un cast d’eccezione di cui fanno parte Dennis Quaid e Michael Chiklis, meglio conosciuto come Vic Mackey in The Shield –, e quindi sarà il caso di concentrarsi sui favoriti della stagione 2012-2013.
Parliamo della ABC, che in autunno presenterà due novità: 666 Park Avenue e Last Resort. La prima è un mix di elementi horror e misteriosi basati sulle vicende dell’omonimo libro di Gabriella Pierce: una coppia si trasferisce in un appartamento di Manhattan e scopre solo successivamente che l’abitazione potrebbe essere posseduto da una misteriosa forza oscura. Da segnalare la presenza del grande Terry O’Quinn, il celeberrimo John Locke di Lost. Per la seconda, il registro cambia completamente. Last Resort è forse lo show che ha raccolto su di sé le maggiori attenzioni già prima della messa in onda, prevista per l’autunno. Lo scenario è ben diverso. Ci troviamo in un sottomarino nucleare americano, il cui equipaggio ha l’ordine di bombardare il Pakistan. Quando i marinai chiedeno il perché di una simile azione, rifiutandosi, di fatto, di eseguirla, vengono automaticamente dichiarati nemici della propria nazione e bombardati. Dopo aver realizzato di essere rimasti soli, gli uomini sbarcano sulla fittizia isola di Sainte Marina, proclamandosi nazione sovrana dotata di armi nucleari. Oltre a sopravvivere isolati dal resto del mondo, dovranno anche trovare un modo per dimostrare la loro innocenza e fare ritorno in patria. Le aspettative per questa serie sono altissime, anche oltre i confini americani.
Ancora molto ci sarebbe da dire e dispiace poter solo accennare a serie come Red Widow, Zero Hour, Hannibal, Thief of Thieves, Da Vinci’s Demons, The Following o Defiance, previste per la mid-season e quindi per l’inverno (di cui comunque ci occuperemo a tempo debito).
Bisogna però soffermarsi ancora su un paio di novità targate NBC, ossia Revolution e Crossbones. Nel primo caso, la serie racconta le vicende di un mondo sconvolto da un black-out che ha tagliato le gambe alla società colta impreparata. Per sopravvivere il mondo ha dovuto adattarsi ritornando all’agricoltura, aggregandosi in piccoli villaggi e il potere è stato preso dalle milizie e da chi con la forza ha saputo sbaragliare i propri nemici. In questo scenario si collegano i personaggi di Ben Matheson, che sembra avere più informazioni di quanto si possa pensare sul black-out, di suo fratello Miles inseguito dalla milizia, e di Sebastian Monroe, ex amico e compagno di Miles, ora leader della Repubblica di Monroe, temuto e rispettato da tutti. La serie, che ha fatto il suo esordio il 17 settembre, sembra avere le potenzialità per essere più che un fuoco di paglia, ma il rischio di bruciare un’idea simile con scelte sbagliate per quanto riguarda la direzione della trama è dietro l’angolo, e lo sanno bene Alcatraz, The River, Missing e Terra Nova,partite con grandi aspettative e cancellate dopo una sola stagione. Crossobones invece ci porta in uno scenario completamente diverso. Non ci sono informazioni dettagliate ancora sul progetto, ma sappiamo che la serie sarà ambientata durante il periodo d’oro della pirateria, nel diciottesimo secolo, e seguirà le vicende di Barbanera, impegnato a creare una società più civilizzata dell’Impero britannico.
Dopo aver scavato a fondo tra le novità della stagione siamo arrivati però solo a metà del percorso. Dobbiamo ancora addentrarci nei meandri delle grandi produzioni.
Iniziamo dalla FOX, che ha dovuto cancellare ben due delle sue serie più ambiziose della scorsa stagione a causa dei loro flop (ossia Alcatraz e Terra Nova). La serie di investigazione che ha portato in tv la scienza oltre tutti i suoi limiti, ovvero Fringe, è stata confermata per la quinta e ultima stagione.
ABC, altro canale con chiusure eccellenti – The River e Missing – ha rinnovato gli episodi della quinta di Castle, in cui l’irriverente scrittore-detective segue l’agente Kate Beckett per trovare l’ispirazione per i suoi libri gialli.
Chi ha avuto più fortuna è stata sicuramente la CBS, che oltre ad aver presentato le nuove stagioni di comedy-cult come The Big Bang Theory e How I Met Your Mother, ha confermato per il secondo anno Person of Interest, la fortunata serie “crime” con Michael Emerson, il leggendario Benjamin Linus di Lost.
Anche HBO ha rinnovato un paio di serie che hanno saputo appassionare critica e spettatori: Boardwalk Empire e Game of Thrones (in Italia Il Trono Di Spade), due nomi che da un po’ di tempo non necessitano di ulteriori spiegazioni.
A far parlare bene di sé è pure il canale Showtime con il suo punto di forza Dexter, il tecnico della polizia scientifica di Miami che si scopre anche serial killer, giunto ormai alla sua settima stagione, e Homeland, una delle top-series dell’ultimo anno, che affronta un tema simile a quello di Last Resort, con i problemi passati dal sergente Nicholas Brody, prigioniero di guerra liberato dalla minaccia di Al-Qaida, ma sospettato di essere diventato una spia.
Per ultimo è rimasto forse il piatto forte di questi ultimi anni, ossia il palinsesto di AMC. Che siano gli ambiziosi pubblicitari di Mad Men o il professor Walter White, diviso tra il cancro e il mondo dello spaccio, di Breaking Bad (giunto alla quinta stagione, la cui prima metà è andata in onda in estate), o il confederato Cullen Bohannon, protagonista di Hell on Wheels (una delle serie più interessanti, con la sua ambientazione da Far West molto più cupa e matura di quanto si possa pensare, di cui sta per terminare la seconda stagione), o l’oramai celebre gruppo di sopravvissuti in fuga dal mondo infestato dagli zombie di The Walking Dead (giunto al terzo anno), l’emittente ha portato sugli schermi serie per tutti i gusti e per tutto il pubblico, non sbagliando mai un appuntamento e sorprendendo positivamente gli spettatori con sempre nuove serie che col tempo si rivelano appuntamenti imperdibile per la stagione televisiva successiva.
Aspettando una vagonata di series premiere tra l’autunno e l’inverno, è ancora presto per cercare promossi o bocciati o per dare giudizi; l’unica certezza è che gli Stati Uniti ci regaleranno un’altra grande e lunga annata televisiva da seguire attaccati allo schermo. Stay tuned.