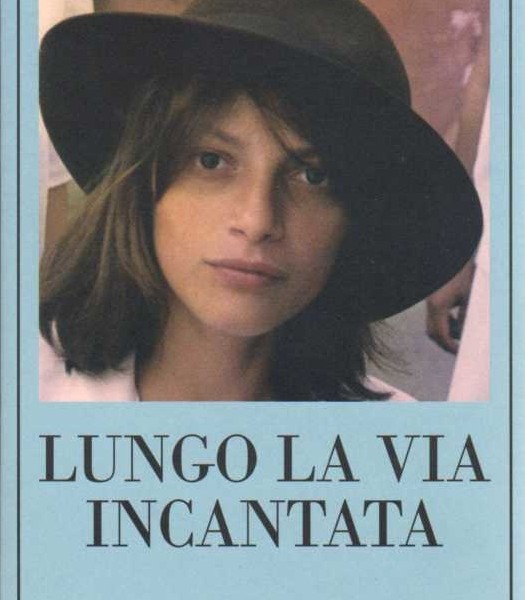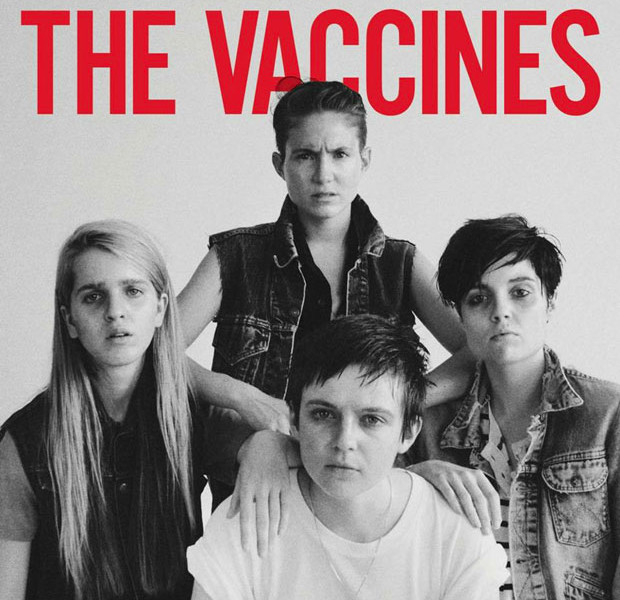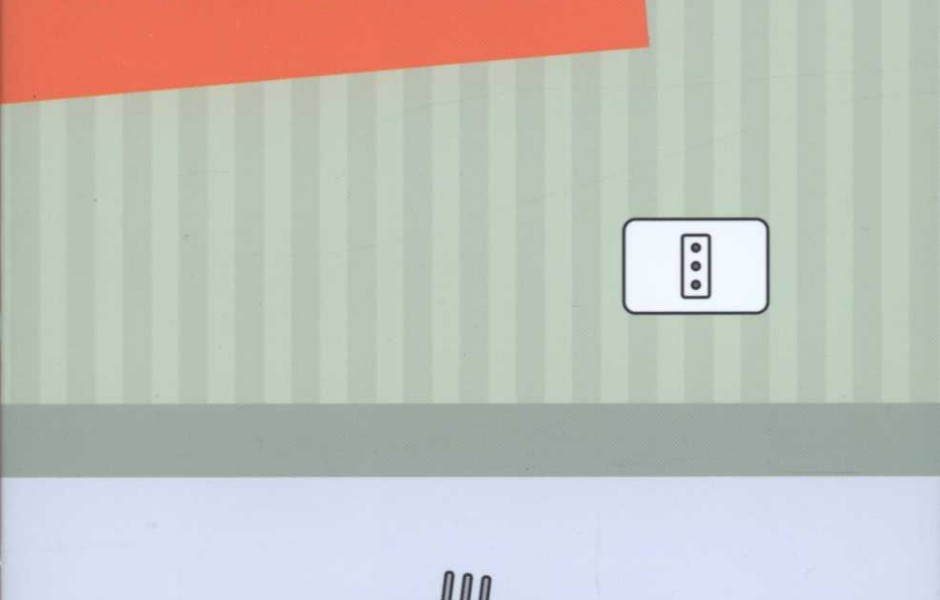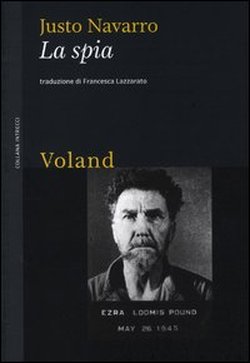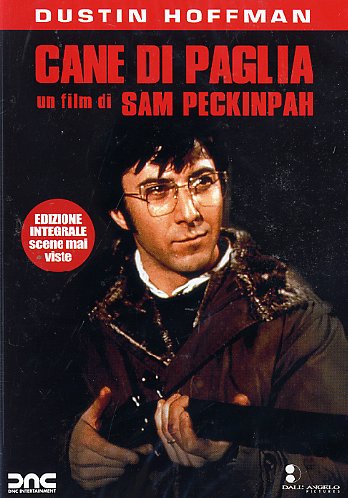Nel bel paese per un bel po’ c’è stato un giochino, a tratti ben poco innocuo a dire il vero: ogni cosa o persona, ivi inclusi artisti e opere annesse, dovevano per forza essere o di destra o di sinistra – all’epoca si usava dire fascista o comunista. Oggi sono solo una manciata di personaggi a usare ancora questi termini, così come sono sempre meno quelli che si pongono il problema di cui sopra. Problema poi, diciamo appunto giochino, sterile e irritante. Ogni tanto il giochino si reinnesca e approfitta degli eventi mediaticamente più rilevanti. In America, per l’uscita del capitolo conclusivo della trilogia del Batman di Christopher Nolan, l’attesissimo Il cavaliere oscuro – Il ritorno, hanno avuto la tragedia di Denver con decine di morti. Da parlare e polemizzare sull’influenza negativa del cinema sulla società ne hanno avuto molto, senza giungere per altro a nessuna conclusione, come è ovvio che sia del resto: Cosa mai si dovrebbe concludere? Che la gente spara e ammazza perché vede film e videogioca?
Qui da noi il film arriva con un po’ di ritardo, i morti non sono i nostri e allora via a puntualizzare se questo Batman di Nolan non sia in fondo un po’ fascista, poco importa se proto o vetero o se piuttosto la storia sullo sfondo sia al contrario ammantata di anarchia e tendenze sovversive.
A noi delle polemiche importa il giusto, cioè praticamente niente. Importa del film che, è bene dirlo subito, vale pochino. Sul cinema di Nolan ci sarebbe da discutere molto, in particolare su come egli sia riuscito a convincere una bella fetta di critica e pubblico dell’essere portatore di un cinema al tempo stesso adatto alla richiesta di consumo vorace dei multisala e intimamente altro e culturalmente più alto, quasi Nolan possedesse la ricetta magica smarrita ad Hollywood dai tempi degli horror anni ’80. Troppo sarebbe lo spazio necessario per tentare di dimostrare come tutto ciò non sia affatto vero. Ci viene però in aiuto la mediocrità di questo suo ultimo film.
Il cavaliere oscuro – Il ritorno parte benissimo con una sequenza action di grande originalità e impeccabile tecnica realizzativa, di quelle che J.J. Abrams sogna la notte e Joel Silver non ha più i dollari per realizzare. Scena che fa ben sperare sull’ adrenalinicità di un film che vede contrapposto al nostro eroe il muscoloso ed energico Bane, tra i tanti villain dell’universo DC Comics, uno di quelli con meno cervello e più muscoli. Siamo già lì a sperare in energiche scazzottate con il redivivo Batman ed invece… di pugni all’interno del film ce ne sono, ben inteso, anche se filmati in sequenze di una rozzezza e pochezza rare; quel che importa però raccontare a Nolan è altro, purtroppo. Qualcuno direbbe per fortuna e invece tocca proprio dire purtroppo. Qui sta il principale difetto dell’ultima fatica di Nolan, sebbene ve ne siano anche altri.
Il cinema dei fratelli inglesi è sempre stato un cinema di scrittura, “narrare” ha sempre avuto un ruolo preponderante, l’immagine e la sua azione e distruzione sono sempre state uno strumento, una funzionale spettacolarizzazione per veicolare una riflessione che spesso donava un tono alto a contenuti superficiali se non grossolani. Qui il tutto viene portato alle estreme conseguenze laddove Nolan e fratello si accartocciano su se stessi reiterando concetti espressi nei precedenti episodi e dando al racconto diversi momenti di estrema ridondanza, accompagnati da un continuo spezzarsi del ritmo senza che poi vi siano le dovute ripartenze e accellerazioni ma anzi dilatando all’inverosimile intere sequenze infarcite di dialoghi fuori luogo quando non ridicoli. La noia è spesso dietro l’angolo nell’intera sezione centrale, dedicata alla rinascita e la resurrezione di Batman, momento che dovrebbe essere catartico, sofferto ed epico e che invece è quanto di più patetico visto negli ultimi anni, tutto ciò che paradossalmente non fu la parte iniziale del primo capitolo, quel Batman Begins che invece aveva dei notevoli meriti in tal senso e a conti fatti resta un ottimo film, non il capolavoro di cui si favoleggiò ma un ottimo film e migliore dell’elefantiaco seguito. A peggiorare il tutto ci si mette la frenesia di introdurre e dare il giusto spazio ai molti ma mal caratterizzati personaggi, con la sola eccezione di Cat Woman, rendendo il fluire cervellotico, con una tendenza all’accumulo che ha dell’incredibile. Montato come peggio difficilmente si sarebbe potuto il tutto prosegue un po’ quasi a caso e si lascia vedere più che altro per la curiosità del capire dove si voglia andare a parare con l’anarcoinsurrezionalismo del Bane interpretato da un Tom Hardy purtroppo limitato enormemente nella mimica dalla maschera del suo personaggio.
Qui forse poteva stare il pregio del film, nel coraggio accennato dei Nolan di non fare affatto del cinema politico, da qui l’assurdità di certe riflessioni italiote a cui si accennava in apertura. Già, perché sebbene il tutto ben presto assuma dei contorni da rivoluzione totale e anarchica, contrapposta a una reazione che fa tanto America post 11 settembre, solo un po’ più scema e cialtrona di quella di Bush e compagni, (e diciamocela tutta non se ne può davvero più della reiterazione di questi temi nel cinema americano), in realtà a Nolan interessa il contorno, allo stesso modo di come a Bane interessa solo il mero annientamento totale. L’autore sembra interessarsi al singolo individuo inserito nel contesto critico, la crisi interna all’interno della crisi globale: tra le pieghe di una sceneggiatura pessima ciò si riesce a leggere con chiarezza nonostante tutto ed è esplicato tra le altre cose nel personaggio di Cat Woman, unico realmente ben caratterizzato. Purtroppo, come già stancamente ripetuto, il tutto viene affogato in pessimi e strabordanti dialoghi, lentezze inutili e personaggi resi ridicoli se non bidimensionali. Ci sarebbe anche da citare una serie di aberrazioni tecniche ma davvero è infierire su di un cinema che quasi smette di essere tale nel suo pretendere di essere più di quel che è, collassando su se stesso. Tanto però vi diranno che il film è stato rovinato in fase di montaggio ed è stata tutta colpa della major.
(Il cavaliere oscuro – Il ritorno, regia di Christopher Nolan, 2012, azione/drammatico, 165’)