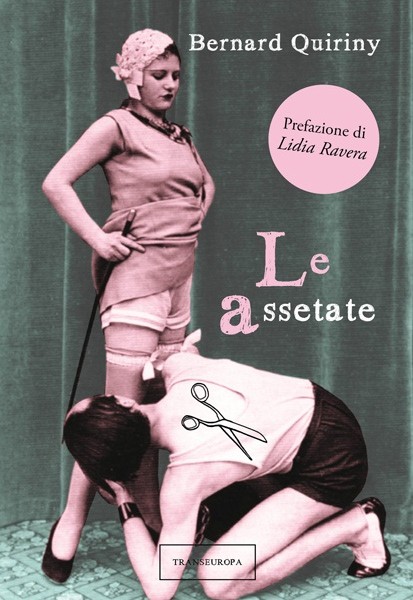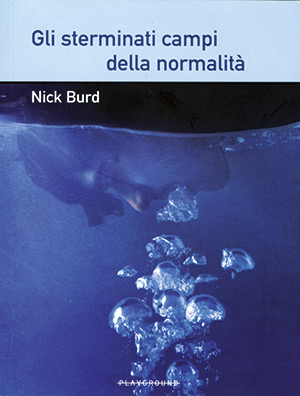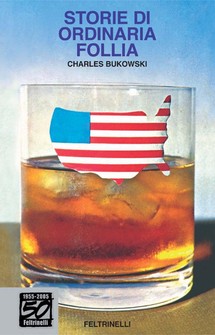Incontrare Carola Susani è come trovarsi catapultati a tre passi da un Babbo Natale con tanto di borsetta rossa e pashmina in tinta, che dispensa libri al posto di giocattoli e bastoncini di zucchero. La saluto e mi siedo su uno di quei grossi scalini di travertino che spiano piazza della Repubblica a Roma, scommettendo sulla nazionalità del turista che li sceglierà per riposare le sue esauste membra. Questa volta però non gli sono capitati due turisti, ma un paio di viaggiatori, fra le parole, s’intende. Mi accomodo vicino a Carola in una giornata di giugno non ancora rovente, mentre si trascina una pesante borsa ricolma di volumi che lei, davanti alla mia curiosità, subito mi offre, chiedendomi di approfittarne se in mezzo a quel piccolo agglomerato di idee impresse su carta ci fosse qualcosa di mio interesse. Non c’è che dire il Babbo Natale che ho sempre sognato. Chi ti offre un libro, ti sta offrendo un viaggio e una sfida. E io sono affezionato a entrambi. Mentre scorro i volumi, vedo una copertina che mi ricorda proprio l’ultimo libro di Carola Susani Eravamo bambini abbastanza (minimum fax, 2012). Si tratta di un viaggio molto particolare, un viaggio nelle viscere del lettore alla ricerca delle sue paure. E proprio dalla paura, protagonista onnipresente del romanzo, mi piacerebbe partire per il dialogo con Carola.
La paura di perdere chi si ama da un momento all’altro, sottratto, rapito, rubato. La paura di non ritrovarlo più. La paura che questa perdita non sia vissuta con altrettanto dolore dallo “scomparso” e per finire, e qui forse la più dolorosa, la paura che la persona in questione possa stare meglio con chi di questo rapimento è il responsabile che con noi che non abbiamo fatto altro che amarlo e guidarlo. Con Eravamo bambini abbastanza rimesti nel pentolone emozionale del lettore senza sosta, tanto che a volte è necessario interrompere la lettura del romanzo per non esserne inghiottiti. Erano queste le sensazioni che volevi scatenare nel lettore?
La paura di perdere da un momento all’altro un bambino o una bambina, che si ama con infinita apprensione e tenerezza. Certo, sono partita anche da qui, dalla paura delle madri e dei padri. Dal terrore dell’ignoto. Quello terribile prodotto da un rapimento, ma anche quello più consueto, l’ignoto che è la vita di quelli che amiamo quando noi non ci siamo. La scoperta dolorosa ma confortante che possono fare a meno di noi. Ecco, questo libro è anche consolazione e conforto. L’autonomia dei bambini, la loro capacità di “fare il pane con la farina che trovano” (“il pane lo fai con la farina che hai”, è una specie di proverbio popolare siciliano per nulla antico, credo novecentesco) mi conforta e mi alleggerisce dall’angoscia nel momento in cui mi turba. È la libertà – assoluta – che abita ciascuno di noi. Ogni lettore ricorderà certi risvegli, frequenti soprattutto nell’infanzia, i risvegli in cui non si ricorda chi è, in cui non ricorda la propria casa, il nome e il volto dei propri genitori. Credo che veniamo da lì, da un esistere che non ha ancora un contenuto, ma solo una coscienza, in cui nessun legame è ancora dato, e questo ci restituisce la libertà di giocarci a modo nostro la presente incarnazione sulla terra.
Come hai scelto il tema del libro? Da dove è nata l’ispirazione e la storia di Manuel (il protagonista dodicenne del romanzo)?
Come capita spesso, è un libro, una questione, un tema che ti scelgono. Per primo, è stato il Raptor, si appostava agli angoli delle vie, dentro i mercati, nella sua consueta posa di animale secco e cercava di dirmi qualcosa. Poi è stata una vecchietta. Era una vecchietta che aveva costruito sul terrazzo condominale di una casa occupata un rifugio, un eden per i bambini tristi. Tristi di ogni tristezza, per la distrazione dei genitori o la miseria. Li portava via alle famiglie e li restituiva all’infanzia. La vecchietta, che, come il Raptor, è quasi una creazione della mia mente, ha avuto il suo momento di gloria su Repubblica-cronaca di Roma, un raccontino. Ma sono rimasti i bambini che ancora mi chiedevano attenzione. Bambini con la loro questione, ognuno la sua, ma tutti con la necessità di decostruire il mondo, per provare a trovare il proprio posto. L’infanzia è l’età filosofica. Dalla cronaca ho mutuato la paura che attraversa una società intera, ma ho voluto farla specchiare con la paura dell’orco, del babau, dell’uomo nero, che attraversa la cultura contadina, così risalente, tanto capace di perdurare che è sufficiente scavare appena la superficie del nostro tempo – come la crisi economica e le risposte politiche alla crisi economica vanno facendo – per ritrovarcela di fronte, con le sue strutture narrative, le sue forme di elaborazione dell’angoscia. C’è quindi una ragione meditata nell’uso del fiabesco. Manuel è un ragazzino normalissimo nell’età delle domande, un passo prima dell’ingresso nell’adolescenza, ha dodici anni: sono gli anni della coscienza piena del mondo e dei rapporti di potere, gli anni in cui nulla è più attraente della conoscenza.
Il libro appare come un’abile combinazione di racconti e punti di vista, in cui l’immaginifico si fonde e si sovrappone al reale, rendendo indispensabili tutte le meravigliose diversità dei sette compagni di viaggio di Manuel, che comunque subiscono il fascino dell’uomo che li ha strappati alla loro vita “normale”. Come sei riuscita a disegnare questo ambiguo rapporto?
Fino all’ultimo, non mi sentivo all’altezza dell’intuizione di questo libro. Fino all’ultimo non sapevo se sarei riuscita a dare agli otto ragazzini vita e aria per esprimersi. Ho azzardato, mi sono data la libertà di tentare. Per me, reale e immaginifico non sono alternativi, sono compresenti, ed è soltanto attraverso l’immaginazione che si può arrischiare una conoscenza. Penso il mondo come un posto pieno di porte e finestre, che ci attraversano. Voglio dire: a otto anni ho interpretato Babbo Natale a una festa e sono stata pienamente Babbo Natale. Non l’ho interpretato, l’ho incarnato. Lui è stato qui. Babbo Natale allude a qualcosa di cui non possiamo fare a meno. Il fascino del Raptor io credo che nasca lì. Il Raptor non è buono, non è cattivo. È molto più cattivo che buono. È tutte e due le cose insieme. Ma è soprattutto assetato, arso dal bisogno. È un cercatore. Cerca l’acqua. Per i bambini un cercatore, uno che si muove tirato da qualcosa di più forte di lui, che è una mancanza, è potente, perché ogni bambino è pure un cercatore. Questo suo vuoto interno, questa sete, io credo, gli dà il fascino e l’autorità di cui gode. I bambini, allontana dosi e avvicinandosi a lui e tra di loro, sperimentano il proprio rapporto con il potere. Cioè vivono la loro formazione.
Alex, compagno di viaggio di Manuel, spesso suo antagonista, è uno dei comprimari più interessanti, probabilmente perché a lui spetta il compito di memoria del gruppo. È lui che quasi ogni sera inizia a raccontare una storia che riguarda uno dei suoi compagni, in una sorta di Decameron per bambini, in cui alle malizie degli adulti si sostituisce l’immaginazione dei “quasi adulti”, che pur avendo provato sulla loro pelle e sui loro desideri molto più di quanto un lettore potrà provare in una vita, resistono, incredibilmente continuano ad aver bisogno delle storie di Alex, piene di invenzioni, sì, eppure più vere per loro della ineccepibile realtà. Da dove viene Alex e cosa sarebbe stato il romanzo senza di lui?
Alex è un tardo figlio del Novecento. Che testimonia l’impotente potere di cui ci siamo fatti carico noi che ci ostiniamo a raccontare le storie, a scrivere, a fare arte. Noi che ci ostiniamo a restituire un senso sapendo e dichiarando che la realtà scivola, si nasconde, non si fa cogliere. Ma chi racconta, Alex, sdrucciolevole, intimamente non aderente alla comunità, sempre dentro, sempre fuori, con le sue storie riesca a fare qualcosa di diverso: fonda ogni giorno la comunità, mescolando come non può non fare, cose che sa e cose che inventa, restituendo a ciascuno e a tutti il suo mito individuale, e accordando il coro. In Alex ritraggo tutta la mia passione per l’arte, tutta la mia fiducia che va sempre insieme alla coscienza di un eterno inevitabile fallimento di fronte alla realtà. Bene, con Alex accetto di farmene carico con disinvoltura.
«Raccontare cose estreme come se fossero normali, ti inizierà all’arte della narrativa.» Condividi l’affermazione di Francis Scott Fitzgerald? Leggendo Eravamo bambini abbastanza sembrerebbe proprio di sì. Quanto è importante l’immaginifico e il fantastico nei tuoi romanzi e in questo in particolare?
Sono perfettamente d’accordo con Fitzgerald. Ma dico di più: per chi le vive, per chi ne fa esperienza, le cose estreme molto spesso sono normali. E l’unico modo per mettersi dal punto di vista di chi le vive è coglierle nella loro normalità. L’alternativa, l’estremo raccontato con l’estremo, con l’insistenza, con il compiacimento, non fa che trasformare gli esseri umani in mostri incomprensibili, sia che siano vittime, sia che siano carnefici. Quanto al fantastico: non so concepire il mondo se non aperto, come ti dicevo, pieno di porte e finestre, attraverso le quali, dalle più risibili alle più autorevoli, da Babbo Natale a Dio, si rivela la nostra non autosufficienza, l’impotenza di un’idea totalitaria dell’immanenza. Si rivela la sete degli esseri umani di una libertà che non si esaurisce nella propria. Penso al fantastico insomma in chiave religiosa. In Eravamo bambini abbastanza non c’è proprio il fantastico, ma una continua allusione al fantastico. D’altra parte, è un libro sulla sete, sull’arsura.
E ora una domanda alla Carola Susani lettrice. Ti sbilanci e ci dici quale libro hai amato nell’ultimo anno e quale invece non sei proprio riuscita a finire?
Ho amato Stranieri alla terra di Filippo Tuena edito da Nutrimenti. Con i libri brutti è più difficile, o non li comincio o li dimentico.
Passiamo ora alle manie scrittorie. Ne hai? Bevi succo di cicuta prima di metterti a lavorare con tre sorsi lunghi e uno breve o disegni circoli viola intorno alla tua scrivania? Di cosa non puoi proprio fare a meno quando scrivi?
Ormai, quasi niente. Nessun rito, nessuna mania. Mi sono fatta concreta e terrestre. Non posso fare a meno di solitudine e silenzio. Mi piace la fine della notte e l’alba. Ma è fare di necessità virtù.
Ora che il libro è uscito e si è attivato il tumulto promozionale, sei pronta alla battaglia? Sei stata soddisfatta dell’accoglienza da parte dei lettori e della critica? C’è stato un commento che proprio non ti aspettavi sul romanzo?
Sono molto contenta. Anche stupita dell’accoglienza. Si è scatenata una grande euforia attorno al libro. È una passione che meritano gli otto più il Raptor e rispetto alla quale è bene che io mi faccia da parte. Parlo fin troppo, forse non è più il mio momento per parlare. I lettori e le lettrici a volte ho l’impressione che capiscano questo libro meglio di me.
Una cosa sorprendente l’ha detta Piero Sorrentino presentando il libro a Napoli: ha detto che finalmente sapeva che fine aveva fatto Kate, la bimba rapita di Bambini nel tempo. Non ci avevo pensato, ma era vero. Il mio libro, in qualche modo, è anche una risposta, un controcanto, di quel libro.
Ti ringrazio per la tua disponibilità e ovviamente per i libri che spesso porti in dono. Ora in molti cercheranno una donna con la borsa e la sciarpa rossa, sperando in un volume in regalo. Lo so, concedere interviste è sempre un errore. A presto.
(Carola Susani, Eravamo bambini abbastanza, minimum fax, 2012, pp. 211, euro 13,50)