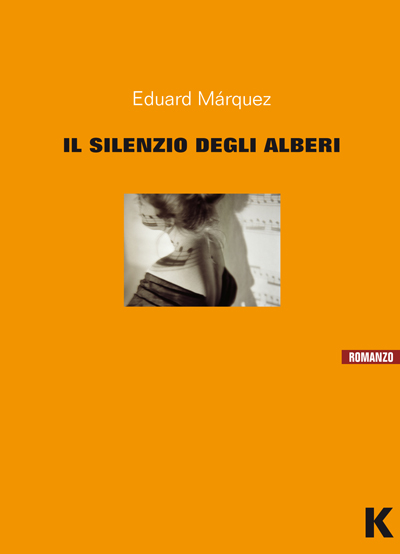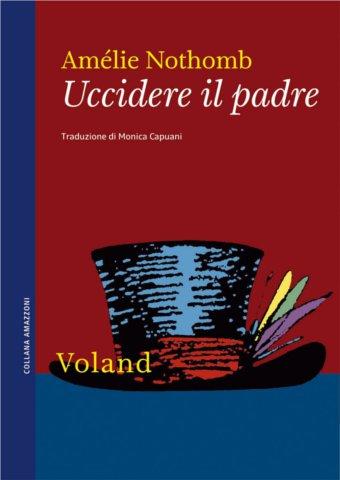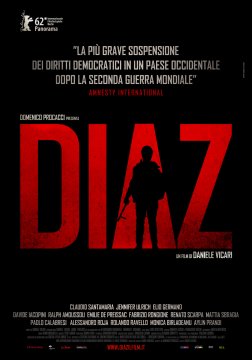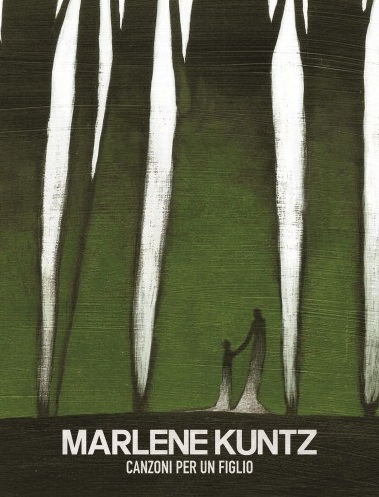Un’altra pagina che sa di parete. Ti risucchia il suo intonaco fresco, con le braccia distese e il naso all’insù e per sopravvivere vuoi vederla arredata. Il bianco, si sa, può sconfiggerti. Cerchi tende, cassetti, scaffali pieni di parole, perché quella diventerà la tua stanza. E vuoi abitarla sorridendo. Qualcosa mancherà sempre, avresti potuto scegliere un tavolo più grande, per annotare le notti in cui non hai dormito, fiori così forti da abbattere anche i muri, quadri enormi per strapparti dal gorgo della tua poltrona. Ma insomma, quello spazio ti racconta. E in questo deserto chiarissimo da riempire con cura, ho scelto di piazzare i miei steccati intorno a un libro, per l’immagine e l’effetto che riesce a evocare.
Si tratta de Il silenzio degli alberi (Keller editore) del catalano Eduard Márquez, che sarà in Italia il 16 maggio, ospite della Feltrinelli International di Roma.
Un romanzo breve, perché il peso dei passi non dipende soltanto dalla lunghezza del cammino. Un romanzo di case, di strade conosciute, di porte socchiuse verso il mattino, dove, anziché il temporale, cade la guerra. Piove tanto, piove veloce, rallenta un istante e ricomincia a tuonare, giusto il tempo di tirare il fiato, per contrarlo di nuovo fino a farlo sparire.
Nella città assediata scorrono in molti. C’è Andreas Hymer, violinista sbarcato per un concerto e per una missione ancora più artistica: recuperare l’amore. C’è Ernest Bolsi, liutaio che dentro quei corpi di legno scopre un’anima e un segreto. Ernest che nonostante le bombe, continua a fare la guida nel Museo della Musica, per accogliere chi abbia ancora voglia di ascoltare la sua voce, i suoi aneddoti. Per chiunque insieme alle leggende voglia ingoiare una boccata di speranza. Una finestra aperta. Perché narrare vuol dire esistere, vivere e far vivere, eternare nelle corde della gola i sussurri degli altri, così simili ai nostri. Perché narrare serve a uccidere il buio. Soprattutto quando scoppia all’improvviso.
C’è Amela, la stessa Amela cercata da Andreas, che galoppava il suo piano per ore e ore, per «scacciare il frastuono e costruire un riparo di quiete». E che dopo una bomba si ritrova addosso solo delle mani inutili, incapaci anche di accarezzare i tasti, di toccare il suo risveglio.
E poi ci sono tutti i visitatori del museo, persone comuni stracciate troppo in fretta, che per una granata hanno perso tutto, tranne un palmo strozzato di briciole, che ricomposte non faranno mai un intero. Individui che decidono di attraversare quel cielo, di rifugiarsi nel solo abbraccio possibile: quello della memoria. Così tutta la storia, quella singola e infinitesima riversata a occhi chiusi nella madre maiuscola, assume il volto di un edificio, malta e mattoni da sovrapporre ogni giorno per darsi una forma, per specchiarsi in qualche linea pulita e poi chiamarla “abitudine”.
Un libro che disegna un condominio spezzato, l’architettura sconvolta di un Paese qualunque, con gente che chiede soltanto di crescere i figli e invecchiare sotto un graffio di sole. Mentre altri stabiliscono che è meglio combattere, frantumare molti perché pochi restino intatti. E più ricchi di prima. Un libro che immortala l’urto del conflitto, il rumore assordato dei palazzi che crollano, come il futuro. E allora gli alberi tacciono, perché nessuno capirebbe il loro grido, perché nessuno sente più le foglie quando grandina anche il cemento. Le esplosioni disgregano ogni cosa, anche i respiri, anche i pensieri e quindi i ricordi s’intrecciano al presente, i sogni alle paure, in una vertigine di incontri che mescolano i tempi.
Perché nel cuore gli appuntamenti fluiscono insieme, non s’infilano nei numeri così facilmente.
E l’autore ci restituisce questa voragine, il cratere sempre acceso e sempre vuoto di chi è stato ferito, dall’alto, dal basso, da ogni punto umanamente designabile. Dalla violenza che ci conferma piccoli, invisibili sotto il vento di un ordigno. E allora forse, l’unica fonte di ossigeno, l’unica bombola in quest’apnea, rimane la bellezza. La forza dell’arte che ci rammenta quanto possiamo essere migliori.
Al di là del sangue, su quello stesso sangue, si può riscrivere un’altra storia, come ha fatto Márquez, come fa chiunque in questi anni di guerra glaciale, dove i civili cadono perché non hanno abbastanza gambe, riesca a tracciare una via, riesca a dire anche solo una volta: «Ascoltatemi, ascoltiamoci, per non morire».
(Eduard Márquez, Il silenzio degli alberi, trad. di Beatrice Parisi, Keller, 2012, pp. 160, euro 13)