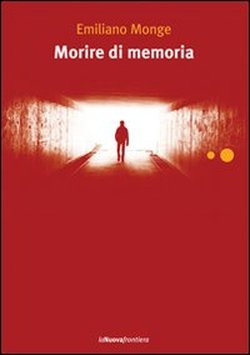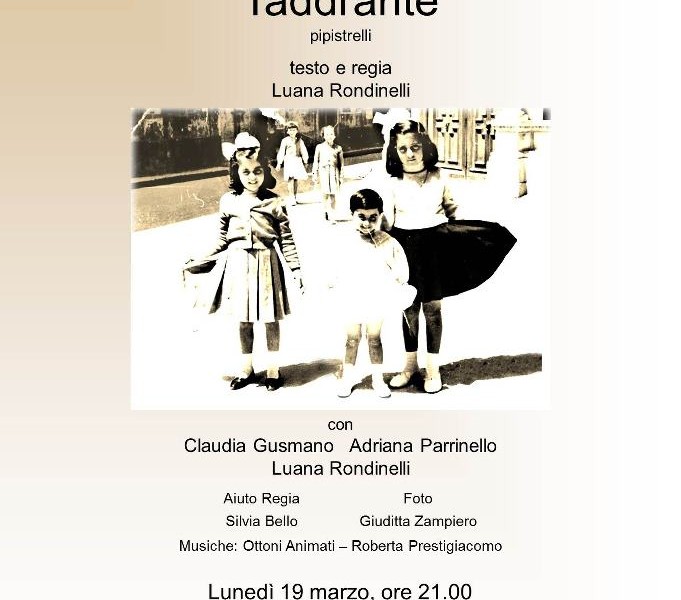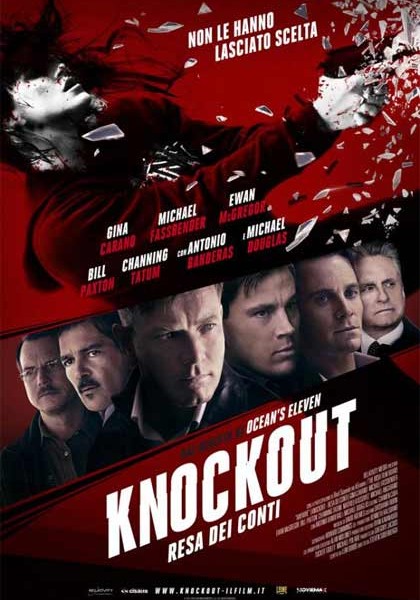Difficile capire come si possa buttare al vento l’occasione di fare un film su un tema ricco di spunti come la possessione diabolica, che certo non può lasciare indifferente pubblico e critica. Ma L’altra faccia del diavolo – titolo originale The Devil inside, distribuito in Italia da Universal Pictures – è riuscito nell’impresa di coniugare i difetti del classico dejà vù (vedi L’esorcista) con un’incomprensibile mancanza di idee nello sviluppo dell’esile trama, per non parlare di un finale rischioso che dovrebbe scioccare lo spettatore e invece lo priva del piacere di vedere come andava a svilupparsi una certa situazione di crisi ormai giunta al climax.
Innanzi tutto va detto che l’idea di presentare il film in forma di finto documentario non funziona, perché lo svilisce, fino a renderlo una sorta di involontario “Grande Fratello” che non fa tremare i polsi come ci si aspetterebbe da un horror degno di questo nome.
Pur non brillando, gli attori (i vari Evan Helmuth, Simon Quarterman, Ionut Grama, Bonnie Morgan) se la cavano, ma tirando le somme svolgono il loro onesto compitino senza superare la sufficienza, restano insomma troppo piatti, come si suol dire, perché il talento è quello che è – cioè poco – e i dialoghi non brillano di originalità nel caratterizzarne il loro temperamento.
Giunta a Roma per studiare gli esorcismi e realizzare un documentario in materia, Isabella Rossi (Fernanda Andrade, più bella che brava) incontra due giovani preti che praticano queste particolari attività con l’aiuto di strumenti tecnico-medici.
Su queste premesse la vicenda scorre sulle comode rotaie dell’ampiamente prevedibile o del banale fin dai nomi scelti (si poteva fare di meglio di un comunissimo Maria Rossi, interpretata da Suzan Crawley) fino alla presa di coscienza che quest’opera fa cilecca perché anche quando si propone di spaventare non fa altro che seguire un copione che anche un ragazzino può agevolmente intuire, anche se lo sviluppo della storia si sofferma troppo su alcuni aspetti e poco su altri forse più interessanti (ad esempio la suora che compare nel manifesto è presente in una sola scena: poteva essere un bel jolly).
Tutto ciò premesso, possiamo concludere che il film di William Brent Bell rimane così tutta intenzione e poca realizzazione a cominciare dalle deboli musiche.
La location romana è inoltre sfruttata poco e male: questo priva l’opera della poesia necessaria a stemperare le scene più dure. Ben vengano scantinati polverosi e corridoi bui, ma avremmo voluto vedere anche la città, i quartieri dove la vicenda si svolgeva, per contestualizzarla meglio. Non basta passare in macchina davanti al Colosseo o a Piazza San Pietro per dire: «Siamo a Roma».
Il film, in sostanza, si configura come una locomotiva che procede spedita da una stazione all’altra, senza quelle sane fermate intermedie di ristoro che possono rendere il percorso complessivo meno faticoso e più interessante.