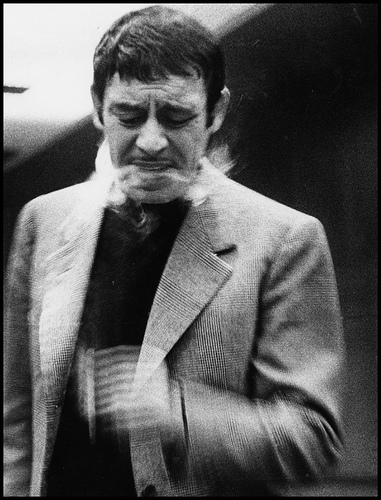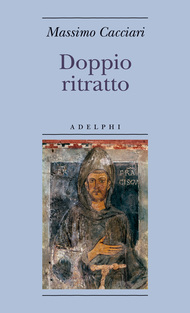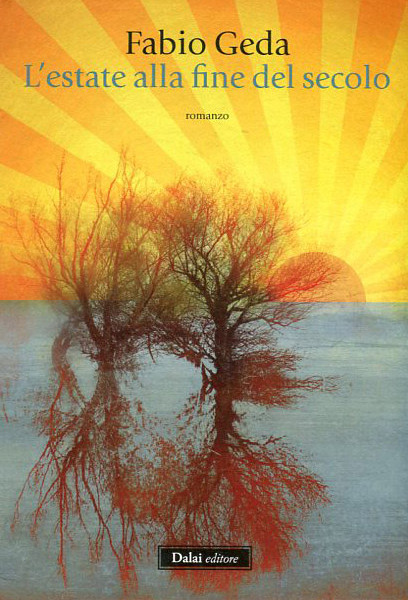Abbiamo intervistato il giovane attore Andrea Galatà, fresco vincitore, al Catania Film Festival, del premio come “miglior attore protagonista” con il film Un uomo nuovo. Inoltre, da venerdì 4 marzo, è uscito al cinema Native, thriller psicologico in cui Galatà interpreta il ruolo del protagonista maschile.
«Nemo profeta in patria» è un detto latino che è stato veritiero fino allo scorso 19 febbraio. Poi sei arrivato tu, miglior attore protagonista al Catania Film Festival con il film Un uomo nuovo, proprio lì, nella città che ti ha dato le origini. Raccontaci qualcosa di quella giornata, che cosa significa per te questo riconoscimento?
È stato davvero molto più emozionante di quanto immaginassi.
Vivo a Roma da tanti anni, ma lasciare la mia terra non è stato facile. Il “richiamo” di cui è capace una terra come la Sicilia può comprenderlo solo chi in Sicilia ha vissuto, anche solo per un breve periodo, chi ne ha sentito gli odori, osservato la natura e spiato le tradizioni.
I film in concorso al Festival di Catania erano di altissimo livello, così gli altri attori in lizza e la giuria, di indiscusso valore artistico. Nessuno aveva lasciato scappare anticipazioni, così quando sono stato chiamato a ritirare il premio ho avuto davvero un sussulto. Poi ho capito che l’emozione più forte è stata riceverlo nella mia città natale.
Nel film Un uomo nuovo, tratto dal romanzo di Adriano Nicosia Cogli la rosa, evita le spine(A&B, 2010), interpreti il ruolo di Rosario Roccese, personaggio contraddittorio che nel finale trova un proprio riscatto. Quanto il protagonista del film rispecchia l’anima del nostro paese? Che cosa condividi e che cosa condanni di Rosario Roccese?
Credo che Rosario non sia contraddittorio, anzi. Rosario è un puro, un estremista. La sua estrema coerenza, virtù in via d’estinzione in questa italietta borghese di banderuole e opportunisti, ci invita a una riflessione sulle possibili conseguenze estreme delle dinamiche politiche e sociali dei nostri tempi. Sono queste a essere contraddittorie. Condividere o condannare lui significa fare altrettanto con tali dinamiche. Una sceneggiatura coraggiosa che mi ha davvero entusiasmato.
La Chiesa con le mani in pasta ovunque, l’alleanza tra politica e imprenditoria, il potere oscuro dei banchieri, sono le principali dinamiche con cui Rosario deve rapportarsi. E deve allo stesso tempo affrontare una volta per tutte il lutto, mai superato, della perdita della sorella. Rosario si trova a un bivio e dovrà scegliere se continuare a cercare ossessivamente di riaggiustare qualcosa che ormai si è rotto irrimediabilmente, oppure fare il salto nel buio e abbandonarsi a un viaggio nuovo verso l’ignoto, che gli consentirà di diventare appunto “un uomo nuovo”.
Venerdì 9 marzo è uscito nelle sale Native, thriller psicologico diretto da John Real, incentrato sulla leggenda siciliana di cui parla anche Luigi Pirandello nella sua Favola del figlio cambiato. Stessa ambientazione di Un uomo nuovo, la Sicilia, diversa la parte che ti trovi a dover recitare. Qual è il ruolo di Andrea, il personaggio che interpreti in questo film?
La mia splendida terra è un luogo ricchissimo di location straordinarie e di leggende affascinanti. È riduttivo pensare alla Sicilia solo come ambientazione di storie di mafia. Abbiamo tante storie da raccontare. Ero bambino quando mia nonna mi raccontava le nostre leggende popolari, tra cui quella delle “donne di notte”, a cui accennano anche il Pitré e Pirandello, e io me la facevo sotto dalla paura!
Il mio personaggio, al contrario, non perde mai il controllo, ha il compito di rappresentare il sostegno, la stabilità. Preparandolo ho cercato, pertanto, di concentrarmi sulla misura. La difficoltà nell’interpretare questo ruolo è stata quella di ricreare un mondo interiore ricco di passioni da tenere però celate. Perché Andrea riesce sempre a non perdere l’equilibrio. È il punto di riferimento che fa da contraltare a una storia tutta al femminile.
Tra il mio personaggio e quello della protagonista c’è una storia d’amore che mi è piaciuta molto, perché ha un elemento di originalità: Andrea e Michela hanno un problema di comunicazione, non si capiscono, ma malgrado ciò, siccome il loro amore è forte, non solo la loro relazione resiste, ma riescono a sostenersi a vicenda e ad affrontare quelle prove terribili che la storia impone loro.
Il loro rapporto ci insegna insomma che chi ci ama è fondamentale per avere la forza di affrontare i nostri “mostri”, ma che alla fine questi mostri possiamo sconfiggerli solo se li affrontiamo da soli. Nessun altro può farlo per noi.
Andrea e Rosario, due diversi volti dello stesso attore: quanto è importante, secondo te, per chi recita sapersi reinventare in ruoli diversi tra loro? Hai qualche modello di attore a cui ti ispiri?
Denis Diderot, nel suo Paradosso sull’attore, suddivideva nel ’700, gli interpreti teatrali in due categorie: il comédien, personalità forte che adatterà qualsiasi ruolo a tale personalità (pensiamo ad esempio al nostro Alberto Sordi) e il vero e proprio acteur, colui che preferisce abbandonarsi interamente a ruoli sempre diversi (pensiamo a Robert De Niro). Io preferisco quest’ultima modalità e sono più felice quando ho l’occasione di affrontare sfide diverse. Il mio attore preferito è Al Pacino!
Il tuo impegno artistico va di pari passo con l’impegno “politico”: dal 14 giugno scorso sei tra gli occupanti del Teatro Valle, storico simbolo culturale romano e nazionale. Che cosa puoi dirci dalla tua prospettiva di occupante? Che sviluppi pensi possa avere questo autogoverno del teatro?
L’occupazione del teatro Valle è in continua evoluzione. Questo significa che è reale e viva. Siamo in piena fase costituente, dal 14 gennaio chiunque può diventare socio fondatore della Fondazione Teatro Valle Bene Comune e, visto che la sinistra non ha trovato niente di meglio che rubarci lo slogan, è indubbio che l’alternativa che stiamo immaginando, sognando, progettando, reinventando è ormai punto di riferimento trainante non solo per il mondo della cultura. Purtroppo o per fortuna al momento non ne vedo altre…