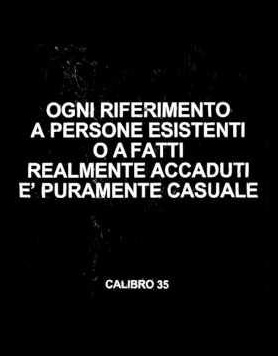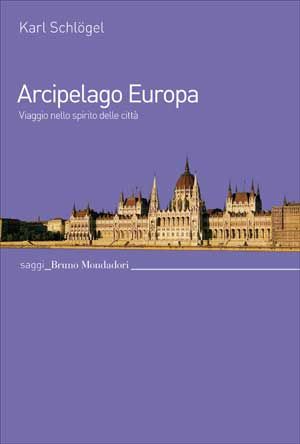Abbiamo intervistato Paolo Sortino, autore del fortunato Elisabeth che ha ricevuto grande attenzione critica e suscitato una interessante riflessione sulle potenzialità (e i limiti) del romanzo ispirato a fatti di cronaca.
Il tuo libro narra la drammatica vicenda di Elisabeth Fritzl, sequestrata e violentata dal padre-mostro per gran parte della sua vita. Che cosa ti ha spinto ad analizzare un caso tanto orribile? Hai mai provato repulsione per l’oggetto della tua narrazione? Hai mai pensato di dare una svolta diversa alla tua storia?
Il caso Fritzl, in quanto notizia di cronaca, mi ha sconvolto subito per complessità di fatti e risvolti nel tempo. Mi ha costretto a uno sforzo di immaginazione fin dal primo momento perché era particolarmente difficile individuare e figurarmi il gesto criminoso in sé – l’atto, l’azione-chiave: sta nel rapimento? Nel substrato psicologico di sottomissione al quale l’ha sottoposta per anni, fin da bambina, ben prima di rinchiuderla nel bunker? Sta nella costruzione del bunker? Nella privazione della libertà fisica e intellettuale della ragazza? Nelle violenze sessuali ripetute? O piuttosto nell’incesto e nei figli che ne sono nati? Forse nella privazione della libertà di questi ultimi? Nella riduzione in schiavitù o nell’omicidio del piccolo Michael? Oppure nell’estinzione del cadavere nella caldaia di casa? Certamente il crimine di Josef si compone di tutte queste cose, e complice da non sottovalutare è stata la cultura di una certa società che fa non solo da cornice a questa dolorosa vicenda, ma è parte integrante di un motore antropologicamente devastante. Posso dire di averne analizzato alcuni aspetti sotto lo studio appunto dell’antropologia, della psicologia cognitiva, con un approccio filosofico-estetico. Poi ho elaborato il risultato di quell’analisi in volontà di esprimere altro dal fatto di cronaca, limitandomi quindi a utilizzare questo come “schema” al quale agganciare un discorso tutto mio, che fin dalla prima riga si staccasse dalla realtà col fine di doppiarla, neutralizzarla, secondo la mia visione delle cose che pensa la realtà e l’arte come un’equazione a somma zero.
Non ho mai pensato di “rappresentare” la realtà, ma appunto di annichilirla. Togliere lo stesso allo stesso, creare un’immagine dell’uomo e della donna – e del loro ambiente vitale – che fosse una sottrazione alla realtà del mondo. Credo che Josef Fritzl aspirasse a tanto, e sebbene in forma negativa (non intendo moralmente, ma in quanto vero e proprio negativo fotografico del mondo reale) tale desiderio è lo stesso di cui si nutre la letteratura. La capacità di cambiare la realtà creandone altra; aggiungere a essa una quantità numerabile di realtà nuova. Il mondo costruito da Josef è un molto simile al nostro, vale a dire privo di referenza. La domanda che mi sono posto a suo tempo è stata: può sopravvivere l’essere umano in un mondo così? La risposta, credo sincera, è stata affermativa. L’uomo riesce a vivere anche in questo mondo depredato di ogni significato, purché riesca a trasformare il vuoto in un’esperienza transestetica.
Non ho mai pensato di dare una svolta diversa alla storia per il semplice fatto che non ho mai pensato di darne una specifica. Il mio lavoro è teso al sollevamento di un masso per vedere cosa c’è sotto, senza pretendere di capire come sia arrivato fin lì né che fine farà dopo.
La protagonista del tuo romanzo è una donna. Peggio: è una donna che esiste davvero. Peggio ancora: è una donna che ha vissuto la condizione della propria femminilità nel più animalesco e traumatico dei modi. Come hai lavorato all’immedesimazione in una personalità tanto complessa? Ritieni di aver compreso a fondo il caso umano di questa persona o di averne voluto dare una possibile interpretazione (la tua)?
Per quanto detto, il lavoro che ho portato avanti non è espressione di una mia interpretazione di quanto accaduto nella vicenda storica. Certamente non ho vissuto la vita di Elisabeth, ma mi ha dato modo di immaginare la stessa felicità minima di cui avverto il compimento nella mia condotta di vita, qualcosa di infinitesimale che annida nel dolore. Una felicità fatta di poco, pochissimo, quasi niente, in contrasto con la violenza che l’idea di felicità oggi più diffusa porta in seno, perché si pensa che sia qualcosa da conquistare a ogni costo, con la forza piuttosto che con il sacrificio. Occorre pensare invece che la felicità si possa ottenere con ciò che si possiede, non con altro. Josef, nel romanzo, sa benissimo che amare qualcuno vuol dire comprendere i suoi desideri, non lo nega di certo, anzi questa convinzione sta alla base di molti suoi ragionamenti. Ciò che non sa – ma che comprende a sue spese – è che desideri determinati nascono in un mondo determinato, e quindi amare una persona significa amare il mondo in cui vive. A dire la verità lo capisce anche Elisabeth, la quale allora arriva a comprendere ragioni del bunker che la cronaca non concepisce nemmeno.
Elisabeth scoraggia una banalizzazione del male, ma allo stesso tempo la sua fortuna sembra strizzare l’occhio a un certo manicheismo di facile impatto. Qual è la tua posizione a riguardo?
Manicheismo? Direi proprio di no. Una cosa è il dualismo, su cui si regge ogni forma di potere, anche quello di Josef (destra/sinistra, sopra/sotto, dentro/fuori, maschio/femmina) e che Elisabeth combatte e riesce a distruggere, altra cosa sono le dicotomie. Quando si ha a che fare con queste, ogni cosa diventa difficile quanto se stessa.
Qualcuno ha criticato la scelta di analizzare una vicenda così sconvolgente e mostruosa senza il permesso della famiglia che ne è stata colpita. Che cosa ti senti di rispondere a questa obiezione? Hai mai pensato di entrare in contatto diretto con Elisabeth Fritzl o con la sua famiglia?
Credo le critiche alle quali ti riferisci non siano che espressioni di ottuso moralismo.
La pietà che certi critici mi rimproverano di non avere, io la nutro come individuo, vale a dire che sono abbastanza pietoso verso Elisabeth Fritzl da non andare a chiederle nulla. In quanto scrittore, invece, me ne frego altamente della realtà (sempre che non sia pensata in quanto “leggi al lavoro”, siano fisiche o comportamentali, ecc, allora mi incuriosiscono e le riconosco come materia di studio). Come ho detto, la mia volontà è di neutralizzare la realtà, non di rappresentarla. Credo che si esprima benissimo da sola e non abbia bisogno dell’appoggio degli scrittori. Anzi il fatto che la realtà sia in grado di esprimersi (per altro molto male) ne fa il mostro che secondo me ogni scrittore sano di mente intende sconfiggere. E comunque è quello che voglio io, e tanto basta. Ce lo insegna la storia dell’arte: se traccio su un foglio il ritratto di un cagnolino che ho di fronte, altro non faccio che creare un altro cane. Entrambi saranno reali, ma se il secondo somiglia al primo, vuol dire che questo non è nel disegno. Si trova altrove, in una dimensione che anche volendo io non riuscirò a estinguere o a disturbare, se non con la forza che hanno le dimensioni parallele, qualcosa di sempre meno fantascientifico e che rilancia tutto nel mondo delle possibilità, le quali non vanno più pensate come il contrario del più sano determinismo, quanto “variabili nascoste” dello stesso.
Qual è il tuo rapporto con la pratica della scrittura? E che cosa pensi della condizione dell’esordiente?
Si parla tanto di moda degli esordienti, ma tutti gli scrittori lo sono stati per un giorno nella vita. Purtroppo però oggi le farfalle hanno la pretesa di tornare nel bozzolo a ogni cambio di stagione: sarebbe interessante capire cosa sperano di ottenere quegli scrittori che a cinquant’anni promuovono ogni nuovo libro come fosse il primo.
Il mio rapporto con la scrittura è piuttosto banale. Mi metto al computer, scrivo tre pagine e ne cancello quattro.
Quanto ha contato l’editing per il tuo lavoro e che rapporto hai avuto col tuo editor?
Ho imparato tantissimo. Sensibilità e comprensione sono state riservate al mio lavoro in ugual misura dal mio editor, Marco Peano. Marco indica, non dice. Ti fa sentire senza toccare.
Per concludere, ti va di dirci tre libri verso cui pensi di avere un debito come scrittore?
Dovrei elencarne troppi. Sono gli stessi coi quali mi sento in debito come lettore grato. Gli autori sono i più diversi: da Stephen King a Proust, da Duns Scoto a Duglas Adams.
Grazie Paolo e in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri.
Leggi la recensione di Elisabeth su Flanerí.