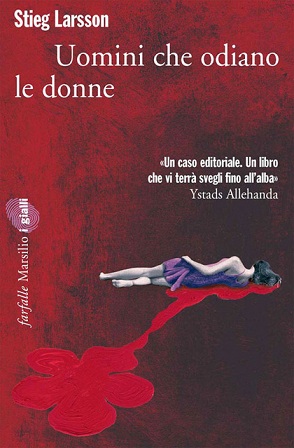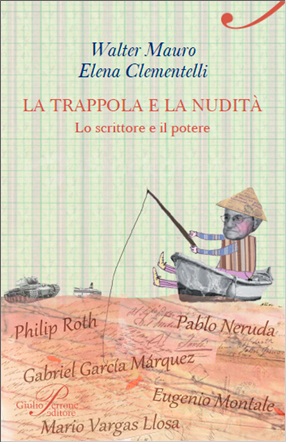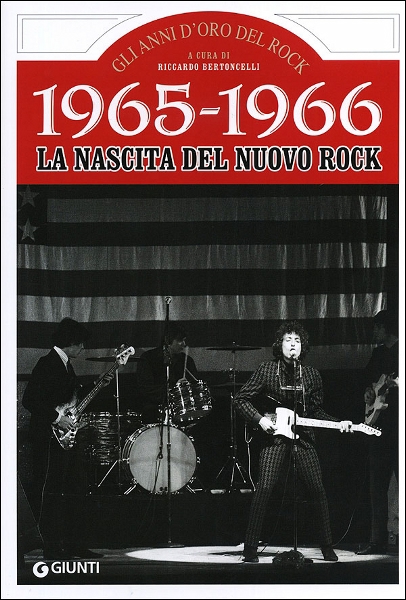A fumare, fumava molto. E quel giorno l’ascensore non funzionava; i sette piani di scale della sede della rivista Expo se li è dovuti fare a piedi. Aggiungeteci una mole notevole di lavoro. Stress. Metteteci pure l’aver appena concluso il terzo capitolo della saga – e già la mente guardava al seguito. Infarto. Era il 9 novembre 2004 e lo scrittore svedese Stieg Larsson moriva così, in redazione, quasi a voler autocitare una scena dell’ultimo romanzo. Se ne va improvvisamente, lasciando compiuti solo i primi tre atti del suo decalogo Millennium: Uomini che odiano le donne, La ragazza che giocava con il fuoco e La regina dei castelli di carta.
Caso editoriale da trenta milioni di copie vendute per il mondo, giusto per dare qualche cifra. Più la degna rappresentazione cinematografica. Proprio qualche giorno fa è uscita nelle sale la trasposizione americana del primo capitolo, ad opera di David Fincher. Ne approfittiamo per vedere meglio cosa ha lasciato al mondo della narrativa contemporanea lo scrittore più freddo e implacabile del terzo millennio, parlando proprio della sua opera prima.
«Era diventato un rito che si ripeteva ogni anno».
Uomini che odiano le donne è il thriller nero più sconcertante, indelebile e mozzafiato scritto negli anni 2000. I motivi del caso editoriale sono tanti, in primis la personalità dell’autore. Infatti Larsson non è un semplice romanziere con la vocazione palese e straripante per la narrazione; è qualcosa di più. A differenza degli altri colleghi di penna, lo svedese è un giornalista con una missione. Sente la vocazione del suo ruolo e ne fa una ragione di vita.
Nel 1995 a Stoccolma, cinque ragazzi muoiono sotto i colpi dell’estremismo di destra. Lui, per risposta e denuncia, contrattacca fondando la rivista Expo, con il dichiarato intento di combattere il razzismo e le altre piaghe che infestano la Svezia: antisemitismo, violenza sulle donne, criminalità e corruzione. Il dipartimento di Giustizia svedese e Scotland Yard gli chiedevano consulenze per i crimini d’estrema destra. Il parallelo tra la sua figura e quella di Mikael Blomkvist – il protagonista della trilogia – inizia a prendere forma. Nella realtà c’è Stieg con le sue crociate, nel romanzo c’è Blomkvist e la sua di rivista: Millennium, appunto.
Fondete insieme la vocazione e lo spirito di denuncia al ritmo serrato di una prosa ferrea e implacabile. Unite la trama noir al pretesto per poter raccontare gli aspetti più terribili e nefasti dalla società e dell’essere umano moderno. Avrete il caso Larsson.
Prima la Francia, poi Germania e Italia cadono sotto le pagine del romanzo. Un po’ d’attesa e avrete la successiva – e per altro gradita – invasione postuma degli altri “figli” scrittori dell’autore provenienti dalla medesima terra.
Già, perché la Svezia, fino ad allora ai margini della letteratura, è parte intrinseca e imprescindibile di questi libri. Non c’è goccia di sangue che possa macchiare le terre bianche e glaciali. Non c’è scena di violenza insostenibile che ceda e si compiaccia di se stessa, sfociando nel “già visto” e nello scontato. Da come vengono raccontati e descritti, gli eventi del romanzo sono perfettamente reali e plausibili.
Emblematici sono i dati spietati che correlano l’incipit delle parti del romanzo.
Parte prima: «In Svezia il 18% delle donne al di sopra dei quindici anni è stato minacciato almeno una volta da un uomo».
Parte seconda: «In Svezia il 46% delle donne al di sopra dei quindici anni è stato oggetto di violenza da parte di un uomo».
Parte terza: «In Svezia il 13% delle donne è vittima di violenze sessuali al di fuori di relazioni sessuali».
Pochi dati, capaci, però, di calare come ghigliottine sul lettore che si addentra nell’abisso del romanzo. Esatto, perché non va trascurato un particolare: Uomini che odiano le donne è un innanzitutto un libro che non ti lascia. Inizi e, pagina dopo pagina, senti quell’irrefrenabile piacere ad andare avanti sempre di più. È questo un particolare capace di fare la differenza tra il bel libro e il capolavoro, tra il fenomeno da classifica stagionale e il caposaldo assoluto, copiato, imitato, in grado di aprire strade romanzesche impensabili.
Fra i tratti innovativi di Larsson, oltre alle già citate qualità e capacità dello stile inedito e unico, ci sono delle scelte narrative di spessore, tra le quali, senza dubbio, la scelta dei protagonisti: il giornalista d’inchiesta Blomkvist, che all’inizio del libro troviamo oppresso e rovinato dal processo Wennerstrom, e soprattutto lei, Lisbeth Salander, «the girl with the dragon tatoo», come la chiamano in America.
Se Blomkvist è l’eroe con qualche macchia e tante paure, ma pur sempre ligio, Lisbeth è un personaggio immenso e complesso, contrastante e ambiguo, a cui è impossibile rimanere indifferenti. Giovanissima hacker di caratura planetaria, assoldata dall’agenzia d’investigazione di Dragan Armanskij, Lisbeth ha un passato drammatico («Tutto il Male», lo chiama) e un presente tutt’altro che facile. È un’ex-adolescente turbolenta e problematica. È un’asociale volontaria: lei non piace al mondo – sarà a causa del suo look punk estremo? – e il mondo non piace a lei. Un comune accordo. Nel lavoro è un prodigio; tutti hanno dei segreti e per quanto nascosti, Lisbeth ci può arrivare tranquillamente. Le cose però si mettono davvero male quando le commissionano di indagare su Blokmvist e le viene assegnato come nuovo tutore Nils Erik Bjurman: è lui il primo uomo che odia le donne del romanzo. Sarà con lui che si inizierà a sprofondare nel baratro.
L’altro nome femminile alla base del libro è Harriet Vanger. Pupilla dello zio Henrik Vagner, sono quarant’anni che della sua sparizione non si sa nulla. A ossessionare lo zio, oltre al ricordo e al rimorso, c’è un regalo che ogni anno gli fa rivivere il dramma; via posta, sempre con timbro postale diverso: un fiore incorniciato. Proprio come faceva la sua nipotina. Saranno Blomkvist e Salander a fare luce sulla scomparsa, entrando nelle spesse tenebre dei segreti dei Vanger, camminando sulle orme bibliche di un serial killer di donne. Tra citazioni del Levitico, foto sfocate e una famiglia piena di ex nazisti e oscure personalità. Fino alla fine. Una fine che è solo l’inizio, soprattutto per chi adesso le gesta dei suoi eroi se le gode dall’alto. Magari rimpiangendo il bianco gelido della sua cara e spietata Svezia.
(Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne, trad. di Carmen Giorgetti Cima, Marsilio, 2007, pp. 676, euro 21,50)