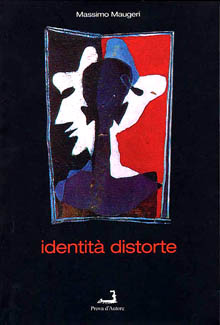Malaparte e la guerra. Un rapporto nato da un qualcosa che ribolliva nel suo animo, un istinto “animale” o “primordiale” che, senza mediazioni, ha lasciato in lui una sensazione amara ma al tempo stesso vitalistica, riversata in opere che esibiscono, senza veli, una visione del mondo disincantata ma niente affatto fatalistica.
Da sempre considerato “scrittore maledetto” se leggiamo con rigore, senza pregiudizi, le molte pagine che ci ha lasciato ci accorgiamo, a mio avviso, di quanto questo scrittore si presenti come protagonista e come testimone privilegiato degli avvenimenti del suo tempo, in quel terribile passaggio della nostra storia in cui dall’inizio della prima guerra mondiale alla fine della seconda si è assistito ad una irragionevole strage e alla rottura di molti schemi (politici e sociali) precostituiti.
Malaparte si muove tra l’orrore e i “fatti di sangue” come un cronista disincantato e consapevole, perso in riflessioni che trovano, non nel singolo avvenimento ma in una catena di conseguenze, la propria ragione d’esistere. Oscillando tra sogni e utopie, speranze vane di riparare l’irrimediabile o di riprendere un cammino interrotto da una brusca “rottura”, tenta di farsi interprete fedele di una realtà complessa e ricca di contraddizioni.
Lo sguardo di Malaparte si sposta come una telecamera in continuo movimento che ferma l’immagine ora su un evento, ora su un altro. Prima la guerra combattuta e raccontata, la logorante vita di trincea, l’allucinante stillicidio del primo conflitto che con Caporetto vede il clamoroso rovesciamento della morale borghese, l’elevazione da “sconfitta storica” al nuovo significato di vendetta del popolo umiliato e offeso. Poi l’appassionato racconto di un incubo, l’eloquente resoconto del marciume della società moderna, l’isterismo estremo e il tormento al tempo stesso attrattivo e ripulsivo con cui ha descritto l’Europa alle prese con una guerra, la seconda, generata dal un germe comune: la follia.
Anche la prosa malapartiana è mossa da una carica istintuale, è ricca di espressività e di “espressionismo”, si sfuma in una resa verbale al tempo stesso realistica e immaginifica. Il linguaggio si presenta nella sua sontuosità, nella ricerca costante ed esasperata di ogni possibile apporto descrittivo. Si va avanti per metafore, per similitudini e creando microcosmi pregni di un’aurea poetica e di prospettive nuove, inedite, sorprendenti.
Le sue opere maggiori sono proprio quelle che parlano di guerra, non importa il palcoscenico da cui sono tratte ma gli uomini che vi partecipano. E cambia la sensibilità con cui sono osservate: da una parte l’esperienza carsica e il successivo ritorno alla “normalità”, nella quale la classe politica cercava di nascondere la disfatta del 24 ottobre 1917 e in cui Malaparte intravede non un ammutinamento militare ma il perturbamento sociale di una vera e propria rivoluzione; dall’altra la delusione fortissima di una Europa sconfitta e priva di ogni ideale di purezza che coincide in una coscienza comune vergognosa, umiliata e disfatta. Una Europa che nel 1945 si risveglia dal peggiore degli incubi, da una sconfitta totale: lo scrittore diventa “portavoce” di uno scenario di orrori continui e implacabili, si immerge in un abisso di dolore, di disperazione, di disgusto e riemerge in una luce fioca e labile di speranza.
L’ostracismo che la cultura italiana ha espresso nei confronti dello scrittore (almeno fino agli ultimi anni, in cui sembra ci sia un rinnovato interesse) è, a mio avviso, sinonimo di cecità. Una critica troppo legata al “personaggio” Malaparte, all’uomo che non riesce a stare lontano dal proscenio, dalle luci della ribalta; alla visione semplicistica dell’autore come un giovane intellettuale certamente intelligente, ma superficiale.
Come spesso accade a chi si trova a dover contrastare degli stereotipi, si può incorrere a volte in qualche eccesso nella direzione opposta: cioè attribuire allo scrittore toscano qualità “morali” superiori a quelle realmente possedute. Ma non per questo, anche perché lo considero il punto di partenza del mio lavoro, non posso non accettare l’idea che alla base del pensiero malapartiano ci sia, al contrario di quanto si pensi, una quanto mai coerente ideologia politica. L’eventuale contraddittorietà che si può riscontrare in questo o in quel passaggio trova la sua radice non nel camaleontismo (o nel trasformismo) dell’uomo ma nella facilità di interpretazione che viene data, troppo spesso, ad alcune vicende storiche.
Dai lavori di Guerri e di Pardini, che per il suo studio ha potuto per la prima volta utilizzare integralmente l’archivio Malaparte, emerge infatti come la biografia dello scrittore, e soprattutto la sua biografia politica, abbia attraversato momenti decisivi della nostra storia.
Gli anni giovanili di Malaparte inducono lo scrittore ad avvicinarsi ad aree politiche lontane dal moderatismo: affascinato da Mazzini, garibaldino, si accosta al pensiero di Sorel e al sindacalismo rivoluzionario e anarchico. Giovane e imbevuto di ideali sovversivi riversa il suo impegno politico nelle schiere interventiste, sperando, con l’entrata in guerra dell’Italia, di riprendere il percorso bruscamente interrotto nel 1870, con la fine delle spinte risorgimentali. Il percorso di Malaparte richiama quello analogo di personaggi di primo piano del futuro regime fascista. Penso ad esempio ad Italo Balbo, o di intellettuali come Delio Cantimori che, come ricorderà lui stesso, aderì al fascismo sperando che il movimento delle camicie nere avesse messo in pratica la rivoluzione repubblicana, sindacale e nazionale di Corridoni e di Mazzini.
Non si può dimenticare che Malaparte fu poi un esponente di punta dell’ala intransigente del fascismo, diventando teorico di una “rivoluzione” basata sul richiamo allo squadrismo delle province contro le manovre e i compromessi di Roma, cioè contro il governo di Mussolini. Nel 1924, sulla sua rivista «La conquista dello Stato», giunse a minacciare apertamente il duce, invitandolo ad ubbidire alla base, cioè a quei fascisti intransigenti e rivoluzionari che erano poi, per Malaparte, gli unici fascisti “veri”.
La «rivoluzione d’ottobre italiana»(come viene chiamata, dallo scrittore, la marcia su Roma) non si contrappone, o almeno non frontalmente, all’altra rivoluzione d’ottobre, quella russa, poiché entrambe si scontrano irreversibilmente con degli avversari comuni e irriducibili: il mondo borghese, il liberalismo, la democrazia.
Dalla metà degli anni venti con l’inizio vero e proprio della dittatura, la normalizzazione tanto temuta dagli squadristi, segnano anche in un certo senso l’emarginazione di Malaparte, il quale ripiega su attività esclusivamente culturali, sia pure con accenti di “fronda”, all’interno dell’ambiente “strapaesano”, del quale è, con Maccari, il principale animatore.
Disilluso del fascismo, Malaparte si trova anche a dover subire un breve periodo di confino per certi suoi violenti attacchi a Italo Balbo (che forse si aspettava che Mussolini avrebbe avallato), fuoriesce dall’elite di regime fino a staccarsene completamente.
In questi lo scrittore azzarda la stesura di alcuni saggi come tentativi di teorizzare alcune idee che aveva partorito a partire dalla presa di potere di Mussolini. Il più interessante di questi è sicuramente Tecnica del colpo di stato, che, scritto sul finire degli anni venti, venne pubblicato in Francia (e in francese) nel 1931, e conferì all’autore fama europea, cosa che, come si può immaginare, gli comportò onori e glorie ma anche numerose seccature in patria, specialmente in fasi storiche turbolente come la sua.
La tesi del libro si articola in tre punti fondamentali: la conquista del potere con la violenza non è un problema politico, ma tecnico; i principi che permettono la conquista dello Stato sono gli stessi che permettono di difenderlo; le condizioni che permettono il colpo di Stato non sono di natura politica o sociale, ma appunto tecnica e materiale. Secondo Malaparte, in particolare, i veri protagonisti dei colpi di Stato non sono le masse, ma gruppi ristretti di uomini, risoluti e determinati a prendere il potere, nella Russia zarista così come nell'Inghilterra liberale.
Per dimostrare la sua tesi Malaparte racconta con un taglio decisamente giornalistico alcune vicende esemplari della storia recente, tra cui spiccano la «Rivoluzione d'Ottobre» in Russia nel 1917, e la presa del potere del Fascismo in Italia. Vengono intrecciati intensi ritratti dei protagonisti, ricordi di esperienze personali, fatti di cronaca e valutazioni politiche in unsquisita mistura che fa di questo libro qualcosa di non chiaramente classificabile, a metà strada tra il trattato politico e la narrazione romanzesca.
L’autore specifica, nell’introduzione all’edizione italiana uscita solo nel 1948, che il suo testo può essere di monito ai governanti di Europa per la difesa dei loro Stati; anche se la sensazione non è tanto quella di ascoltare un suggerimento spinto da uno sincero slancio democratico, quanto piuttosto una osservazione “tecnica” e distaccata, una dissertazione filosofica su una argomento a lui caro. Alcune sue intuizioni storiche sono giuste (Hitler prenderà il potere per via parlamentare e si dovrà sbarazzare di parte del suo seguito), altre analisi probabilmente errate (l’antisemitismo di Stalin non è soltanto un’arma evocata allo scopo di eliminare Trotzky ma una prerogativa intrinseca della sua politica, basti pensare al famoso “complotto dei medici” degli anni cinquanta) ma nel complesso la dimensione storica e politica, per quanto è vivissima quella squisitamente narrativa, è attenta e accurata.
Finita l’esperienza francese, è lontano dalla politica e nei burrascosi anni del dopoguerra che Malaparte raggiunge, con Kaputt e con La pelle, il massimo successo letterario. Difficile dire quanto, nel tratteggiare il quadro senza speranza di una Europa divenuta, con la guerra, un «mucchio di rottami», Malaparte fosse sincero e quanto intervenisse anche il suo bisogno di stupire e scandalizzare: ma in quell’affresco “gigantografico” di una Europa in decomposizione si trova la traccia di idee radicate in lui da tempo, sin dallo stato d’animo del giovane sovversivo che aveva combattuto nella Grande guerra tornandone con la convinzione che la vecchia Europa fosse già da ricostruire.
L’eccezionalità tragica della materia, della guerra «perfezionata come arte del massacro», è resa da una gelida e astratta violenza del linguaggio e delle immagini. Il gioco insistito di dialoghi brillanti si fa abile manipolazione di idiomi europei, alternando momenti di “civile raffinatezza” con cinici colpi di teatro che riducono tutto ad una farsa ridicola e inguardabile. Alcune immagini oggi classificherebbero Kaputt nel genere splatter, in quanto basato sull’estremo realismo degli effetti speciali, dal continuo richiamo al sangue al “racconto” minuzioso della lacerazione dei corpo o di ogni altro particolare scabroso. Il realismo che porta all’esagerazione, allo scopo di far disgustare i lettori o semplicemente di mettergli in mostra il lato peggiore di un qualcosa che non si deve ripetere. In questo “gioco al massacro” in realtà c’è anche molta ironia, quella derivante da una «commozione razionale, arida e fredda sempre, anche quando giunge al riso come a un modo superficiale di sofferenza». Un’ironia metafisica che resta a un livello di sense of humour, non sempre riscontrabile ma comunque presente nell’atmosfera volutamente malinconica e infernale della descrizione.
Quando gli occhi di Malaparte si insinuano su Napoli, in una sorta di Gomorra ante tempore in cui la metropoli partenopea è al centro, come nel romanzo-inchiesta di Saviano, di un processo di corrosione e depravazione dell’intero sistema occidentale, lo scrittore sembra quasi perdere il controllo di sé. La città colpita a morte dalla guerra e rimasta a marcire e a corrompersi nelle retrovie è raccontata in un modo che nasconde forse il desiderio di mostrare, al di fuori di ogni ragionamento, il dolore che lo invade, la disperazione e, perché no, lo schifo. Attraverso le pagine de La pelle, Malaparte si annovera, a buon diritto, tra gli scrittori “pestigrafi”, per i quali la peste è un contagio morboso di violenza, schiavitù, oppressione. Una peste che sfalda i tessuti profondi della coscienza. Non è un caso che il romanzo termina con una frase detta a voce bassa («è una vergogna vincere la guerra»), perché la disperazione, quella più profonda, non ha bisogno di essere urlata.