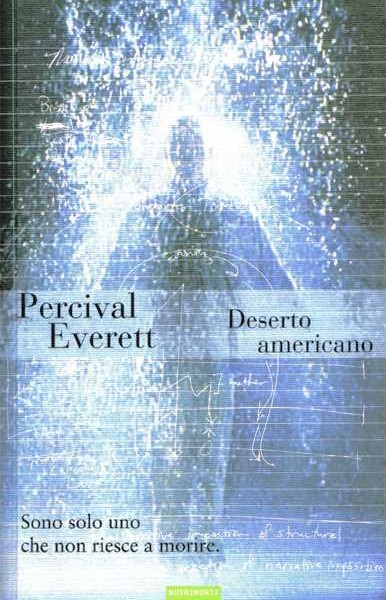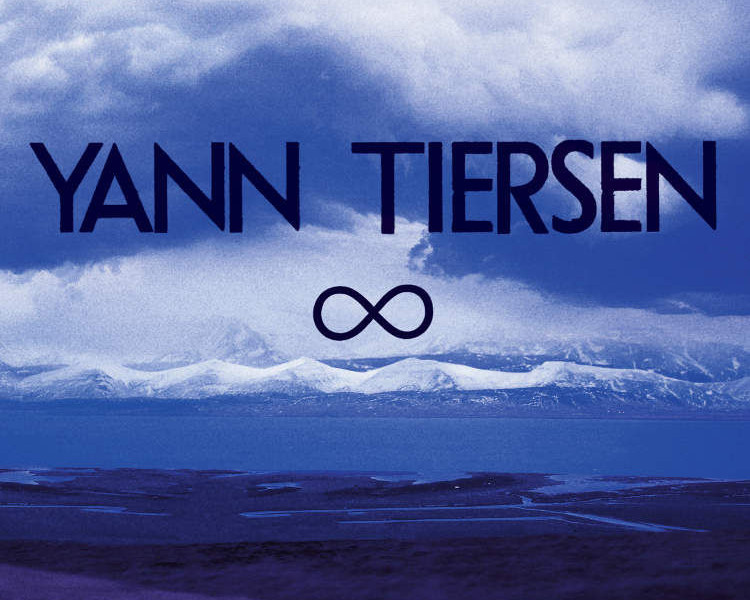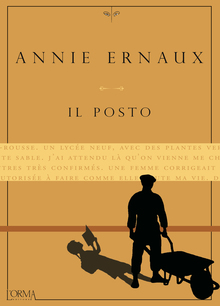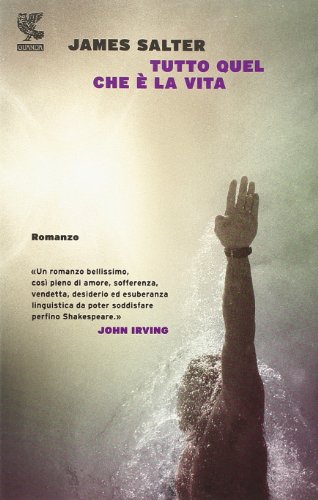Cosa si prova a essere morti e rendersene perfettamente conto? Ce lo racconta Percival Everett attraverso lo sguardo di Theodore Street, il protagonista di Deserto americano (Nutrimenti, 2009).
Professore universitario con una carriera in declino, padre mediocre e marito assente, Ted decide di porre fine alla sua collezione di fallimenti, sale in macchina e guida verso il luogo che sarà teatro del suo suicidio. Ma anche allora i suoi piani vanno per il verso sbagliato: un camion lo centra in pieno e Ted muore sul colpo, decapitato. O almeno così sembra, fino a quando al suo funerale non apre gli occhi, si alza dalla bara e se ne va, dopo aver scrutato i presenti «ad uno ad uno ricordandone la voce e ciò che di buono o di cattivo avevano detto o fatto nei suoi confronti».
È l’inizio di un incubo: il rifiuto da parte dei figli, lo straniamento della moglie e naturalmente lo spietato assalto dei media. Ma un uomo resuscitato (per di più dopo tre giorni dalla sua morte) fa gola a molti, e Ted diventa il centro dell’attenzione di fanatici religiosi, fondamentalisti e scienziati al servizio dell’esercito, che nelle basi segrete tentano di dare vita a un plotone di soldati invincibili. E Ted è proprio questo: un uomo morto eppure immortale, invulnerabile nella sua totale assenza di funzioni vitali, ma non solo.
La morte gli ha regalato una nuova vita, una nuova consapevolezza di sé, un coraggio e una sensibilità che gli permettono finalmente di guardare in un’ottica totalmente nuova e inaspettata ciò che lo circonda. Il tempismo con cui si manifesta questa empatia è amaramente ironico, e rivela una sovrastruttura fatta di interrogativi ai quali Everett non prova nemmeno a rispondere. D’altronde, la scrittura non è fatta solo per dare risposte; anzi, come racconta lo stesso autore, «come tutti i miei libri l’ho lasciato libero: deve imparare a cavarsela da solo».
Sotto l’esilarante scrittura di Everett non è difficile intravedere una riflessione sul significato della morte, che altro non è che «un punto senza dimensioni nel tempo», ma anche sull’importanza della vita e sul modo in cui troppo spesso sprechiamo il nostro tempo, consacrandolo al disperato raggiungimento di una posizione all’interno di una società ormai alla deriva. Se con questi presupposti Everett mira, apparentemente in maniera quasi inconsapevole, a smuovere qualcosa nell’animo del lettore, la forma che assume la scrittura alleggerisce notevolmente la lettura con la sua ironica e amara comicità.
In Deserto americano lo scrittore prende le distanze dalla sperimentazione e i giochi linguistici che caratterizzano le sue opere: qui non troviamo le digressioni e il divertissement del precedente romanzo Glifo, ma la sua narrazione fitta e rocambolesca è altrettanto piacevole.
Deserto americano è un romanzo che nasconde un po’ del suo autore nelle sfaccettature di ognuno dei suoi personaggi, in particolare Ted, che racconta la sua storia in terza persona perché «di fatto, è fuori di sé, morto. Come è possibile che possa scrivere?». Un libro che avrebbe dovuto avere, in origine, il coraggioso titolo di Making Jesus, prima di essere censurato dall’editore. Un titolo che forse avrebbe posto l’attenzione solamente su alcuni aspetti della storia, ma che sicuramente avrebbe ritratto alla perfezione il romanzo e il suo protagonista.
«Non sono un angelo. Non esiste un dio nel nome del quale io agisco da emissario. Non sono un salvatore. Non sono un messia. Finalmente, in questa vita, sono soltanto una persona rispettabile».
(Percival Everett, Deserto americano, trad. di Marco Rossari, Nutrimenti, 2009, pp. 263, euro 16)