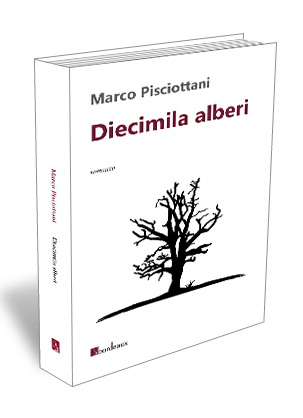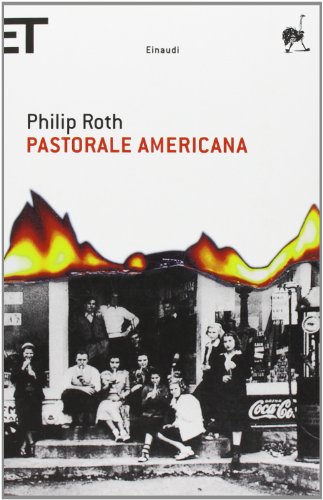Oltre la pioggia sul porto di Taranto, navi ancorate sul Mediterraneo, oltre le nostre risate amare.
«Quante volte l’hai letto Montale?»
Un vortice d’odio, opulenza, superbia ha battuto il suo ventre sulla gru meccanica, quella più alta, sulle colline di acqua cadute sulla spiaggia.
«La Puglia è meravigliosa d’estate».
L’ecosistema infranto, le percentuali sul cancro date a casaccio.
«È morto un altro operaio. Le ali, hanno detto, non portava le ali!»
Mangiano insieme fuori i cancelli tanti operai, la gente di Taranto è indecisa tra la bella morte e la brutta vita, il fumo cola dalle bocche più alte dell’acciaieria, le bandiere rosso salmone sventolano taciturne, i carabinieri tristi, fermi, pieni di lividi, sul confine tracciato dalla miseria, indecisi se picchiare o ritirarsi per cena.
Lo Stato prende tempo, firma, resiste, indietreggia, accusa gli altri, i palati fini degli anni trascorsi, i ricorsi della magistratura, la chiusura forzata, la riapertura dinamica, il conflitto tra i poteri.
«Francesco è morto, aveva trent’anni, aveva tanti diritti e pochi poteri».
Ieri però hanno proferito parola gli addetti ai lavori, tutti sui posti di comando, negli uffici, sui tetti, con dinanzi i nuovi progetti: riniziamo a produrre, nuove norme, nuovi impegni.
«Salviamo anche gli stabilimenti di Genova…»
Una madre intanto non parla ma scrive dei figli ammalati che non potrà mai vedere diventare grandi.
Lavoro o salute? Lo Stato sociale demolito dagli economisti a vita, dagli esattori delle tasse, in televisione gridano allo scandalo, lo sciacallo con la cravatta blu non aderisce allo sciopero, la verità esaurisce il suo tempo, avanti il prossimo. Tra Roma e il mar Ionio c’è un cavo del telefono rotto. «Pronto? Dove scappare?»
Montale era un poeta ma piove, piove ancora in italiano.
L’acciaio è un tessuto più forte, non scalda come la lana, ma tiene lontana la fragilità, la disoccupazione, la fame, l’appiattimento sociale di un migliaio di persone, con le mani sporche e le ginocchia stanche. «Lei è mai stato davanti una catena di montaggio? Dico, soltanto davanti, ce l’ha mai avuto il coraggio?» Il cervello offuscato del Ministero e dei giornalisti, andremo tutti in pensione come si va in paradiso, senza ascensore, con la fatica, magari con un tumore al polmone destro, il mutuo pagato a metà e l’ilarità dei nuovi presentatori televisivi. Le pubblicità: «Papà me lo compri?»
I vecchi marinai che dimenticano tutti i porti tranne il primo da cui son partiti. Abbiamo due, tre figli anche noi, qui a Taranto e non sono d’acciaio, ma hanno un diario e la sera scrivono quattro righe tutte in corsivo: «Sulla mia vita, decido io»
Il progresso, le concessioni valide per il duemilatredici, i giudici con cui solidarizzare, perché c’è un verdetto oltre il mare, oltre i buoni costumi, oltre i fumi da cui ricavare la tredicesima.
«Quest’anno farò la cresima, padre Ignazio dice che siamo cresciute e forse siamo già donne. E così potremmo guidare, votare, vivere da sole, fare la comunione e confessare i peccati di carne. Sposarsi e piangere davanti a un letto d’ospedale o al cantiere davanti al cadavere precipitato del nostro amore. Oppure viaggiare, andarsene da Taranto e vivere in un altro posto dove le leggi, quelle sì, che sono d’acciaio…»
Il dolore è un caffè con l’acqua sporca, sotto l’albero c’è una classe politica corrotta, Francesco non aveva la scorta, ha battuto la testa contro il vortice dell’irresponsabilità, della moderatezza, della pacatezza, del risolveremo tutto senza spargimento di sangue.
Langue il tuo ricordo, un morto ancora sulle coscienze dei governati, dei mestieranti della cosa pubblica, dei servi del più magnanimo dei liberali.
Rileggo Montale ogni volta che sali le scale, non è facile né pregare né contestare, vorrei soltanto farti indossare le ali e un’armatura d’acciaio contro tutte le smorfie malate che girano troppo su Taranto.
«Francesco» gridano forte gli operai, ma ormai non li può sentire, è lì nel vuoto che precipita, è lì che scende forte risalendo piano tutti i suoi pensieri più belli, quelli che ti vengono a cercare quando te ne vai via per sempre, ma ormai…
«Francesco» non serve a niente sparare parole, quel nome non è più il suo, è lì nel nulla in cui ti chiamano solo gli angeli che volano senza l’elmetto e le lacrime che scendono senza le corde.
Francesco sta giù sull’asfalto, immobile, con la barba non fatta, con la testa schiacciata nel cemento, dentro una pozzanghera di sangue come se avesse piovuto dolore. Con i suoi occhi chiari che piacevano tanto alla moglie, quegli occhi chiari con cui è nata la sua ultima figlia, Beatrice, un mese fa, quella bambina che toccherà suo padre poggiando le dita su una vecchia fotografia, quella bambina che crescerà senza imparare a chiamare: «Papà».
Ebbene sì! Francesco è scivolato dal ponteggio più alto di Taranto, c’era anche la televisione a riprendere il fatto, i giornalisti di oggi non sanno però che il verbo riprendere significa anche correggere e non filmare.
Dicono che non aveva il copricapo protettivo, le scarpe antinfortunistiche: «È salito lassù, senza la corda stretta in vita, senza la cintura sui fianchi».
La vita però lui se la stringeva sempre a sé, senza una corda, ogni sera a cena quando guardava, con le attenzioni e i sogni, con le preoccupazioni e i sacrifici, la sua famiglia. Se la guardava come un pittore guarda i suoi pennelli, come un mago guarda dentro il suo cilindro, come un muratore fissa le sue mani spaccate.
Una famiglia come tante altre, dove lei è a casa, i figli a scuola e il papà a lavorare e a perdere sempre al Superenalotto. «Una famiglia dove ci si sveglia alle cinque e cinque, si mangia qualcosa, si ride appena, si taglia il pane, si vede una telenovela… e alle tre e un quarto del pomeriggio, di un fottuto venerdì, vieni a sapere che tuo marito è morto, tuo marito che non voleva lavorare a quelle condizioni però doveva lavorare».
Francesco non c’è più. Dicono che era una brava persona, che non parlava poi molto, preferiva accarezzarsi la barba, preferiva pensare con quelle mani sporche di grasso e d’amore, sporcate da quell’Italia inutile che prende appalti illegali costringendoti a lavorare.
«Me l’aspettavo», dice ancora sua moglie, ma questo non l’aiuta per niente a non piangere, disperarsi a volte è come spegnersi. Morti bianche, bianche come un foglio su cui non riesci a scrivere nulla, bianche come il volto sconosciuto di un assassino.