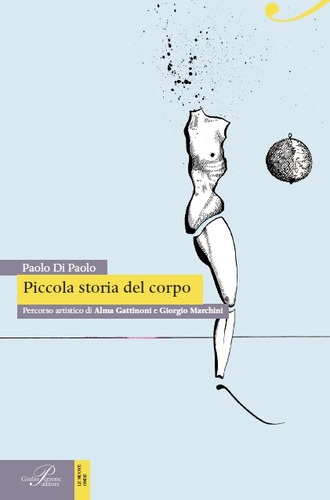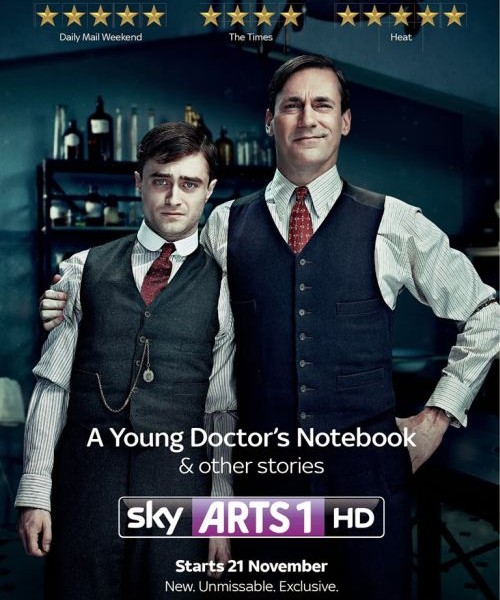Una di quelle sere che fa freddo e il parabrezza si appanna subito. Per riuscire a vedere qualcosa devi spalmare diligentemente con la mano e creare una sorta di oblò da cui scrutare la strada in attesa che l’aria entri in circolo.
Una di quelle sere che neanche la radio ti aiuta. Smanetti nervosamente sullo stereo cercando una frequenza che trasmetta il pezzo adatto a placare il turbamento interiore. Allungando le dita dell’altra mano setacci come un irriducibile segugio tutto l’Fm. Piuttosto che abbandonare la ricerca, lasci il volante e manovri delicatamente con un abile gioco di ginocchia.
Una di quelle sere in cui una paletta e un giubbotto catarifrangente squarciano il buio attorno alla carreggiata e impongono lo stop al posto di blocco. Le mani, prima impegnate in tutt’altro, tornano istintivamente nella consueta posizione 10-10 sullo sterzo. Mentre la macchina si arresta un groppo di saliva scende giù dalla bocca creando all’altezza delle corde vocali una contrazione fastidiosa ma utile a riportare la mente sulla stringente realtà. Davanti ai tutori dell’ordine è sempre importante mostrarsi ben attenti alla guida e, soprattutto, pensare positivo. D’altronde, si sa, colorare i pensieri d’arcobaleno quando ci si trova di fronte a un posto di blocco è indispensabile per evitare che i controlli evidenzino un tasso di negatività superiore a quello previsto dalla Legge.
In un passato non così lontano, infatti, numerose ricerche, acclarate da rinomati studiosi e edotti scienziati, avevano mostrato come il malumore fosse divenuto la fondamentale causa di incidenti stradali nel nostro Paese. Il disagio e il malcontento, ormai diffusi in modo capillare, ci avevano resi scontrosi, aggressivi e costantemente arrabbiati. L’irreversibile crisi economica, i tassi di disoccupazione crescenti, l’instabilità politica e il monopolio juventino sul campionato di serie A avevano generato un malessere che non sfociava più nelle piazze, nei bar, negli stadi o dal barbiere, ma direttamente nel traffico.
Il pensiero frenetico e ossessivo incessantemente rivolto ai mali del Paese turbava la guida e generava una catastrofica serie di incidenti. La rabbia impediva agli automobilisti di stare fermi: semafori rossi, code, lavori in corso, ogni rallentamento era un pretesto per arrivare allo scontro.
Migliorare la viabilità? Impossibile. Incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici? Fantascientifico.
Per questo lo Stato, non essendo in grado di educare al pensiero positivo, decise direttamente di imporlo. Era facile, bastava seguire la stessa procedura seguita con le cinture di sicurezza: una volta reso obbligatorio il loro utilizzo tutti iniziarono ad indossarle e pazienza se nessuno comprese a fondo la loro utilità.
Anzitutto si stabilì l’Imu, Indice Malessere Unico (nome ironicamente preso da una vecchia, odiata, tassa), che vietava di mettersi al volante con un tasso d’ira superiore al 40%. Una volta fermato, il conducente veniva accompagnato all’interno di un furgoncino dove un assistente della pattuglia gli avrebbe applicato uno strumento chiamato Cogitometro, una sorta di cardiofrequenzimetro che, cinto attorno al torace, avrebbe misurato in base ai batti cardiaci la percentuale di Imu. Una volta attivato lo strumento, un altro addetto avrebbe fatto passare davanti agli occhi dell’automobilista le prime pagine di quotidiani e periodici accuratamente selezionati in base ai criteri di tiratura, faziosità e irritabilità. A seguito di scrupolose analisi si scelsero la Repubblica, il Fatto Quotidiano, il Giornale, Libero e una rivista scandalistica a rotazione.
L’obiettivo era chiaro: colpire tutti, nessuno escluso. Il disagio di un automobilista di destra sarebbe esploso alla visione dei titoli dei primi due quotidiani, i nervi del dirimpettaio di sinistra sarebbero crollati di fronte alle colonne degli altri mentre gli sperperi e le frivolezze dei vip avrebbero mietuto vittime tra tutti gli altri irritabili d’Italia. Al termine del test il display del Cogitometro avrebbe emesso il verdetto: se l’Imu era inferiore al 40% si poteva riprendere la marcia, altrimenti sarebbe scattata la sanzione amministrativa e il fermo del veicolo.
Iniziò da quel momento un’ondata di controlli severi, durissimi, che tranquillizzarono in modo coatto un popolo irrequieto. Quella percentuale divenne un incubo che impose agli automobilisti di vivere ogni giorno come fosse un bel sogno. Costretti ai sorrisi forzati, si ammassarono sulle strade macchine guidate da soggetti cortesi e gentili, lobotomizzati da una Legge che li aveva obbligati ad appendere il grugno al chiodo. Per addolcire il passaggio della norma il governo approvò anche un alleggerimento delle sanzioni previste per l’assunzione di sostanze alcoliche alla guida: venne innalzato il limite di tolleranza e una campagna promossa dal Ministero della Salute ripeteva: «Alza il gomito, alza un sorriso!». Quello dell’automobilista infuriato divenne in breve tempo uno stereotipo superato: bastava un cicchettino prima di uscire e i rallentamenti in tangenziale divennero spensierati momenti di aggregazione.
Eppure, questa, è una di quelle sere in cui non si può stare sereni. L’ennesima lite aveva da poco sancito la definitiva rottura con Lei. C’era un altro di mezzo, è sicuro. Non si sa chi sia o cosa faccia, si sa solo che c’è, e tanto basta per averla portata a dire: «Giulio vai via. Io e te non abbiamo più niente da dirci».
E con una simile predisposizione mentale un posto di blocco è l’incontro meno piacevole che si possa fare.
«Buonasera. Favorisca la patente, scenda dal veicolo, entri nel nostro furgoncino e si tolga la maglietta in ordine da predisporre il controllo».
Le parole del tutore dell’ordine, fredde e distaccate come quelle di un boia che deve accompagnare il condannato al patibolo, spingono alla disperata ricerca nei meandri della memoria di qualche ricordo rivitalizzante che possa allontanare lo spettro del 40% e evitare così una condanna apparentemente già scritta.
Niente da fare. Il pensiero è sempre fisso su di Lei. Il rapporto era in crisi ormai da mesi, i discorsi erano fermi sul «come va?» o «giornata dura a lavoro?», mentre il sesso, oltre che sporadico, era anche freddo e insoddisfacente.
«Giulio Balca, si tolga la maglietta». La voce dell’assistente interrompe un pensiero che pur tormentandolo lo aveva quantomeno distolto dal disgusto che la visione di quelle pagine di giornale gli avrebbe provocato.
Inizia il test. Davanti agli occhi scorrono i titoli di la Repubblica, il Giornale, il Fatto Quotidiano e Libero. Fogli contraddittori, ogni facciata una verità diversa, tanti colpevoli, troppe contraddizioni, nessuna verità. La rabbia monta, le pulsazioni vorrebbero salire ma la mente si è ormai completamente abbandonata a Lei e la malinconia, quantomeno, allenta il battito.
Il controllo volge al termine, manca solo la rivista scandalistica. È fatta, pericolo scampato.
Davanti la copertina l’occhio cade su una foto nel taglio basso. La didascalia, ammiccante e pettegola, recita: «E lei chi è? Chi sarà la misteriosa ragazza abbracciata a Rocco di Amici?».
Un sussulto. Il cuore batte all’impazzata.
Quella «lei» è Lei!
Nelle vene il sangue bolle di stupore e sconcerto. Sul volto un’espressione inebetita e pietrificata nasconde il devastante scoramento interiore.
Il test finisce e, nell’attesa che il Cogitometro emetta la sentenza, l’assistente sfila il macchinario dal torace. Cornuto e multato: l’animo, svilito e distrutto, si rassegna a subire due letali pugnalate.
38.8%: il verdetto visualizzato sul display regala un sospiro di sollievo. Con l’ultimo residuo di forze la mano si solleva a riprendere quella patente così strenuamente difesa.
Mentre l’anta del furgoncino si chiude alle spalle, lo zelante tutore dell’ordine non dimentica di proferire il suo monito: «Signor Balca, oggi le è andata bene, ma la prossima volta, mi raccomando, pensi di meno».