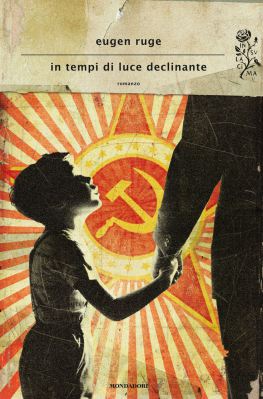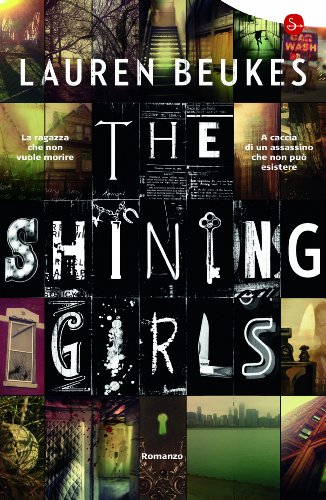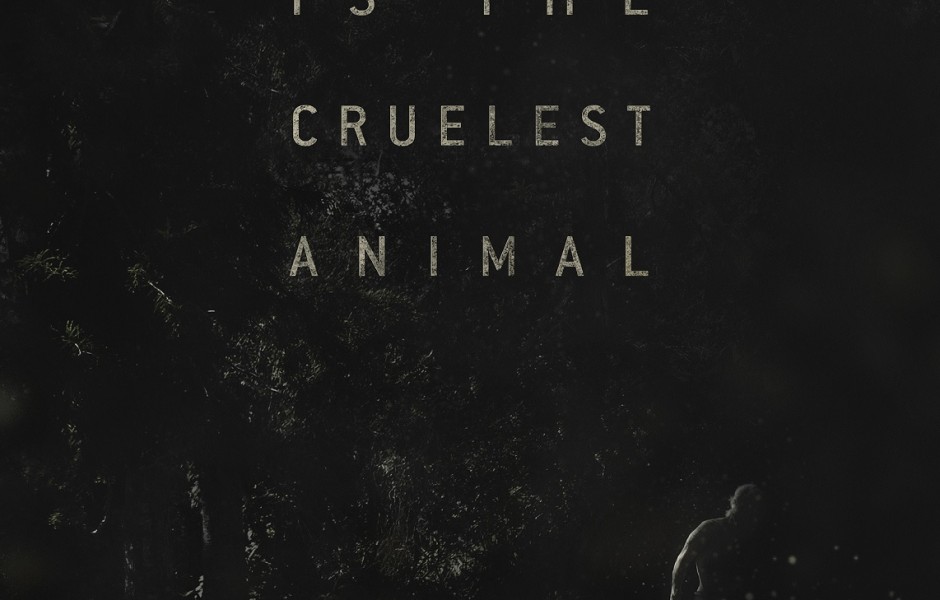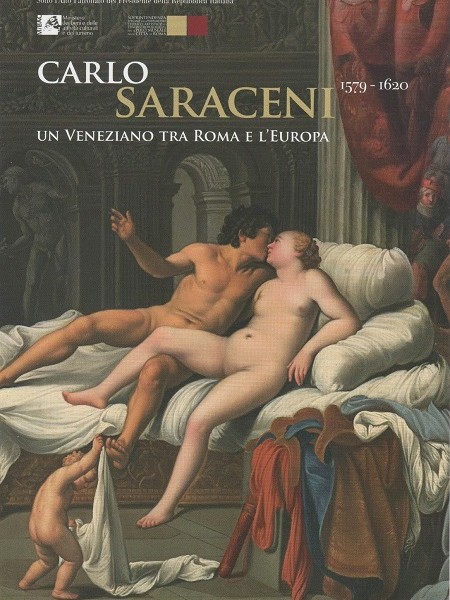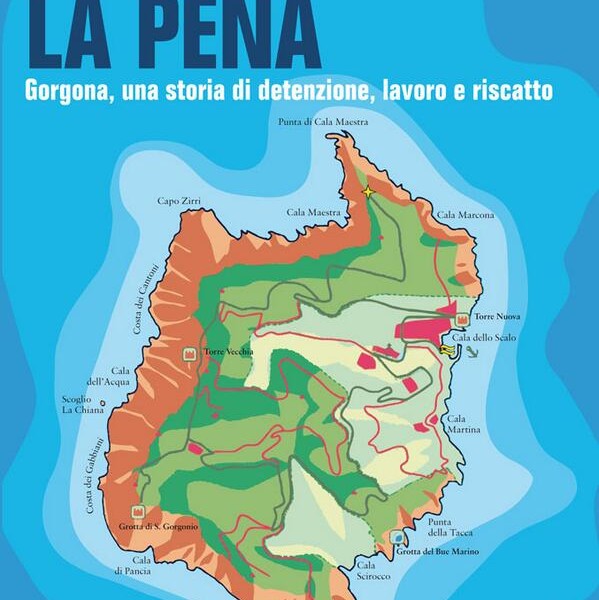Dopo un percorso esplorativo dietro le quarte e tra i Sotterranei di minimum fax, Flanerí conclude questo appuntamento mensile incontrando Martina Testa.
Da redattrice a figura di riferimento, il ruolo di Martina Testa è cresciuto insieme a minimum fax grazie alle abilità di traduttrice e alle competenze editoriali soprattutto nel campo della narrativa straniera: un lungo lavoro che ha impresso lineamenti sempre più riconoscibili al volto della casa editrice.
Sei la direttrice editoriale di minimum fax. Ci racconti in che cosa consiste il tuo lavoro?
Innanzitutto sono l’editor responsabile della narrativa straniera, che nel nostro caso è praticamente tutta in lingua inglese, proveniente perlopiù dagli Stati Uniti: in questo settore, mi occupo di leggere e valutare i testi che ci mandano in lettura le agenzie letterarie e, nel caso, di acquistarne i diritti; di commissionare le traduzioni (alcune, per bieco favoritismo, a me medesima), di rivederle (non tutte ma molte), di scrivere i testi di presentazione (schede per la promozione, risvolti e quarte di copertina). In quanto direttore editoriale, sovrintendo poi alla scelta dei testi di tutte le collane, esprimendo pareri sui progetti presentati dagli altri colleghi nelle loro aree di competenza, e coordinando il loro lavoro. Sovrintendo alla scelta dei titoli e delle copertine di ogni libro e lavoro a stretto contatto con gli altri editor e la redazione dando pareri su vari aspetti del lavoro editoriale (per questo libro serve una prefazione? a chi la assegniamo? in questo ci mettiamo un indice dei nomi? che ci scriviamo su questa fascetta promozionale? in che ordine mettiamo le collane nel catalogo novità?). Un mio compito molto importante è anche strutturare il piano editoriale, ossia decidere (tenendo conto delle esigenze di ciascun reparto della casa editrice) quali e quanti libri di ciascuna collana devono uscire quando. Collaboro inoltre con l’ufficio commerciale e con l’ufficio stampa in vari momenti della filiera del lavoro editoriale: per esempio quando si tratta di presentare le novità ai promotori, di lanciare una campagna promozionale, di organizzare il viaggio in Italia di un autore straniero, ecc., vengo interpellata e ragioniamo insieme sul da farsi. Poi c’è una parte diciamo di rappresentanza e di public relations: incontro autori, agenti letterari, editori stranieri, ogni tanto parlo a delle tavole rotonde e – last but not least – rispondo alle interviste come questa.
minimum fax lavora da anni a un progetto editoriale che si è rivelato vincente, tanto da affermarsi come modello nel panorama italiano anche in un momento di crisi editoriale. Di questi tempi, su quali aspetti avete puntato per mantenere vivo l’interesse verso le vostre proposte?
A questo punto tipicamente l’editore o il direttore editoriale risponde in maniera molto decisa snocciolando la propria strategia, elencando una serie di punti di forza del piano editoriale recente e facendo previsioni ottimistiche per il futuro. Ma io preferisco essere sincera: la crisi del mercato editoriale ci disorienta, ci fa fare un sacco di domande a cui non sappiamo dare le risposte. In casa editrice parliamo molto, ci confrontiamo, mettiamo sul tavolo ipotesi e poi le smentiamo, qualcuno la vede in un modo, qualcuno in un’altra. Insomma: non abbiamo ricette pronte per garantirci che, anche in un periodo di contrazione di tutto il settore, i lettori continuino a comprare i nostri libri. Fin qui, abbiamo continuato a muoverci sulle linee che ci hanno sempre contraddistinto: la qualità e l’originalità della proposta (pubblicare libri che non siano la fotocopia di altri libri, che non si inseriscano in questo o quel trend, che non abbiano un punto di vista banale sul mondo, né siano scritti in maniera approssimativa e piatta); la cura redazionale, anche a scapito della convenienza economica (puntuali revisioni delle traduzioni, molto lavoro di editing, grande cura nelle scelte grafiche, alta qualità cartotecnica); un rapporto il più possibile diretto, capillare, aperto con i lettori (organizzazione di presentazioni e reading su tutto il territorio nazionale; partecipazione a fiere, festival, eventi; e sempre più, negli ultimi tempi, forte presenza online e interattività sui social network). Insomma, l’idea in cui continuiamo a credere è quella di pubblicare libri che ci entusiasmino, di realizzarli il meglio possibile, di accompagnarli con passione verso il lettore. Il mercato è in forte decrescita, e già quest’anno ne abbiamo fatto le spese: la nostra visione editoriale, alla quale fin qui siamo rimasti coerenti, continuerà a essere sostenibile o dovremo modificarla? Modificarla nei contenuti? Nelle modalità realizzative? Ancora non lo sappiamo: è una sfida delicatissima, quella di adeguarci a una realtà mutata senza snaturare la nostra identità, di cui siamo orgogliosi. Posso solo dire che io la prendo molto sul serio, e proprio perché la prendo sul serio non voglio far finta di avere la soluzione in tasca.
Oltre a essere direttrice editoriale, sei anche traduttrice di autori molto complessi. Le tue traduzioni sono note per la raffinatezza lessicale e l’eleganza della resa narrativa. Ci sono dei traduttori a cui ti ispiri? Quali sono i tuoi modelli di riferimento?
No, veramente non ho traduttori a cui mi ispiro e non ho modelli. Non ho seguito corsi di traduzione, non ho avuto insegnanti. Ma da quando ho cominciato, una quindicina di anni fa, ho avuto occasione di lavorare come revisore sul lavoro di traduttori che stimo, in molti casi più o meno miei coetanei, e il confronto con loro mi ha senz’altro aiutata a migliorare (con alcuni mi sento di dire che “siamo cresciuti insieme”, professionalmente parlando: Matteo Colombo, Federica Aceto, Adelaide Cioni…); così come mi hanno aiutata i redattori e i traduttori che si sono occupati della revisione del mio lavoro, e a cui devo molto.
Ho letto il tuo editoriale del settembre del 2008. L’incontro con David Foster Wallace che cosa ti ha lasciato? È un’esperienza che indirizza tuttora i tuoi percorsi?
Se intendi l’incontro con lui di persona, mi ha lasciato semplicemente il ricordo di un uomo gentile e affettuoso, e molto, molto intelligente. Sai quando si dice che uno non dovrebbe mai incontrare di persona i propri “miti”, perché si resta sempre delusi? A me non è quasi mai capitato di restare delusa nell’incontrare a tu per tu qualcuno che ammiravo, e Wallace non fa eccezione. Detto questo: aver conosciuto l’uomo David Foster Wallace non direi che mi ha “indirizzata” in nessun senso. Aver letto i suoi libri (vorrei precisare che ne ho letto qualcuno, non tutti: in Italia ci sono lettori e critici che senz’altro conoscono molto meglio di me la sua opera) invece ha senz’altro contribuito a formare il mio gusto letterario, e alcune delle sue idee sulla letteratura, e sulla cultura e la società contemporanea in genere, mi sembrano talmente condivisibili che costituiscono tuttora una parte fondamentale del mio modo di vedere il mondo. Mi riferisco soprattutto a un suo saggio intitolato «E unibus pluram», in Tennis, tv, trigonometria, tornado, ma anche ai suoi saggi sull’11 settembre e sul senatore McCain (in Considera l’aragosta), e alle cose che dice in alcune delle sue interviste (che ora sono raccolte in Un antidoto contro la solitudine). L’idea che la letteratura sia, appunto, un antidoto al solipsismo e alla solitudine, che l’ironia sia rivoluzionaria ma possa diventare conservatrice, che la cultura commerciale di massa rimuova morbosamente il dolore e somministri ossessivamente un certo tipo di piacere superficiale, che la propria “normalità” vada coltivata molto più del proprio ego… queste idee continuano, in un certo senso, a darmi la rotta. E i suoi reportage dalla crociera nei Caraibi e dalla fiera statale dell’Illinois e dalla campagna elettorale di McCain continuano a farmi ridere tantissimo quando mi capita di rileggerli. Pure questa è una bella eredità.
Grazie a Martina per la disponibilità.