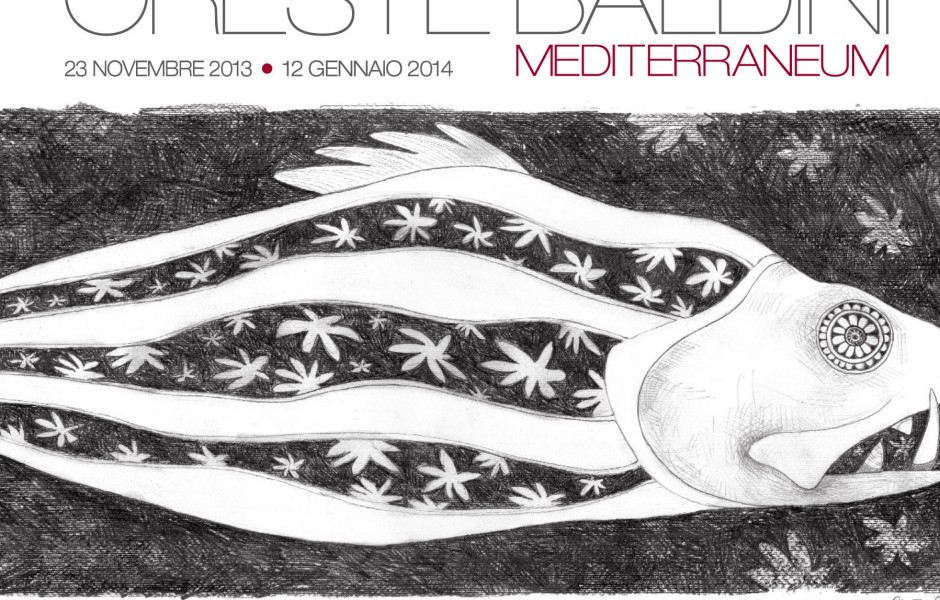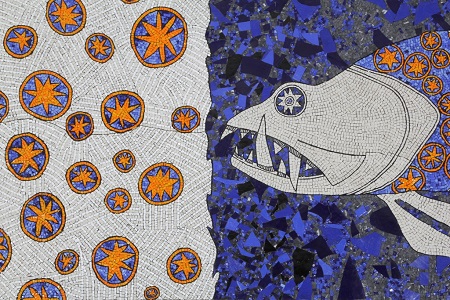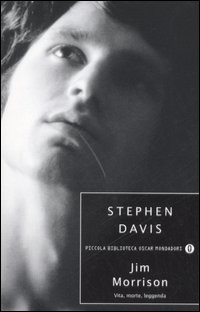A due anni di distanza da Finalmente la felicità torna uno dei campioni di incassi della commedia in Italia, Leonardo Pieraccioni, con Un fantastico via vai.
Arnaldo Nardi (il cognome è un omaggio a Francesco, truccatore amico e collaboratore di Pieraccioni scomparso recentemente) ha una vita abitudinaria e tranquilla. È sposato con Anita e vive con le loro due gemelle in una villetta fuori Arezzo, lavora in banca, ogni mercoledì sera esce con i colleghi Giovannelli e Esposito per un karaoke o per andare dietro a una delle fiamme di Giovannelli, e nel tempo libero ripara vecchi giocattoli. Tutto sembra scorrere normalmente finché un equivoco con la moglie lo butta fuori di casa. Arnaldo ha l’occasione per ripartire all’inseguimento di quei vent’anni di cui ha improvvisamente iniziato a sentire la mancanza. Va a vivere con quattro studenti fuori sede e adegua la sua vita alla loro, divenendo consigliere e amico fino a capire che fare di sé.
È cresciuto, se non altro anagraficamente, Leonardo Pieraccioni, e la sua filmografia segue questa crescita nel personaggio che propone, passato con gli anni e i film da scapolone in caccia d’amore a uomo impegnato con diversi gradi di difficoltà, fino all’ultima esplosione della crisi di mezza età.
Sposato con figlie, Nardi si lascia sedurre solo per un istante dalla nostalgia delle avventure di giovinezza per capire che il suo posto è lì, in quella villetta, con le sue abitudini e i suoi giorni tutti uguali.
C’è di rassicurante nei film di Pieraccioni che ogni volta che ne vedi uno, qualunque esso sia, sai esattamente come andrà a finire. Ci prova, in questo caso con la collaborazione in scrittura di Paolo Genovese, a creare sussulti, ostacoli o intralci, ma non ci riesce. Vedi e già sai che sarà l’ennesimo, inevitabile lieto fine generale. Perché oltre alla sua relazione in crisi, Arnaldo Nardi risolve i problemi di tutti i personaggi che incontra, con la parola giusta al momento giusto.
Con un andamento moraleggiante da oratorio della domenica, Arnaldo esorta i suoi coinquilini a superare le loro paure per vivere appieno la loro età. Perché «a vent’anni si è stupidi davvero», come cantava un cantautore amico di Pieraccioni, ma con il consiglio giusto si può essere meno stupidi. E quindi la ragazza un po’ facile risolve i problemi di comunicazione, anche tecnici, con il padre e risolve se stessa, il ragazzo di colore trova il coraggio di presentarsi al padre razzista della ragazza, il padre razzista della ragazza capisce di essere lui, la bestia, mentre la coinquilina incinta trova il coraggio di dire ai genitori che è incinta, e il calciatore fallito che vuole essere chirurgo vince la sua paura del sangue facendola partorire e superando ogni altra paura, anche quella di dover amare due persone insieme. Tutto questo in una giostra di dialetti diversi, umbro, romano, catanese, varie toscanità, napoletano, per non far mancare niente a nessuno e non scontentare nessun pubblico. C’è questa abitudine di affidarsi ai regionalismi di ogni tipo per caratterizzare i personaggi che ormai da tempo ha rivelato il goffo tentativo di coprire difetti di scrittura, ma ci si continua a fare affidamento.
«Bisogna saper scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà», per continuare a riferirsi a quel cantante che ha fatto anche qualche film con Pieraccioni. Arnaldo capisce che non è più tempo di girare «con le tette al vento» e anziché continuare a rimpiangere il tempo che fu lo affida ai giovani.
Cresciuto come i suoi personaggi, Pieraccioni guarda al passato con nostalgica ironia (l’autocitazione da I laureati della fuga dal ristorante e dal conto da pagare, con finale leggermente differente), capendo che «solo chi ha vent’anni può farti capire che non ce li hai più», come chiarisce l’inevitabile voce fuori campo.
Farcito di un giovanilismo semplice che annulla i problemi e ogni tipo di dimensione drammatica della condizione giovanile contemporanea, Un fantastico via vai si affida a un repertorio rodato di riferimenti alla cultura popolare e cliché narrativi basati sulla contrapposizione giovane-anziano, maturo-inesperto, senza aggiungere nulla al già visto e al noto.
I fedelissimi Panariello e Ceccherini fanno il razzista e il padre assente, la nuova coppia Maurizio Battista-Marco Marzocca i colleghi. Cameo di Enzo Iachetti e Alessandro Benvenuti.
(Un fantastico via vai, di Leonardo Pieraccioni, 2013, commedia, 95’)