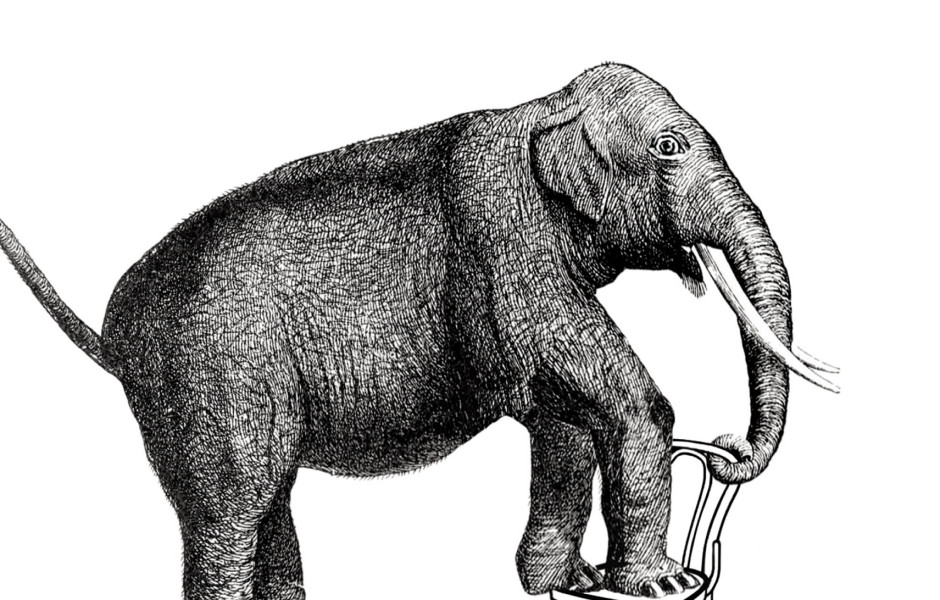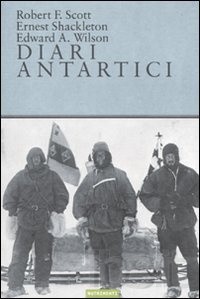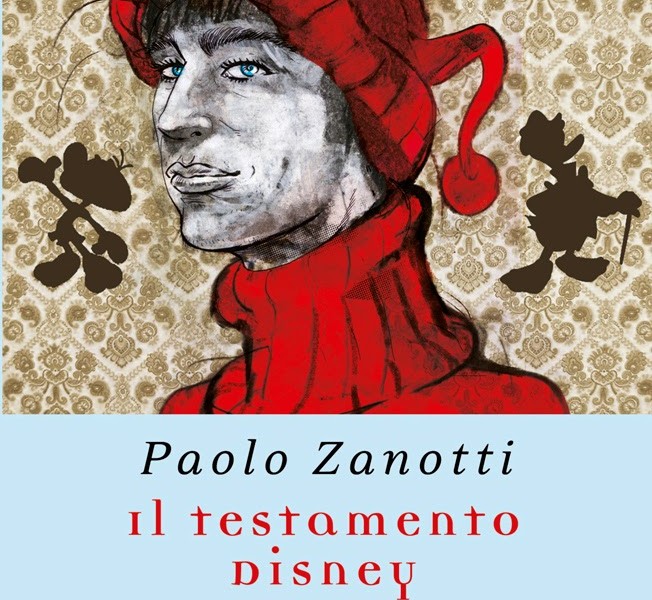Un genitore è la persona nei cui occhi il bambino può rispecchiarsi e nel cui amore ritrovare se stesso e la sua storia: «Mia madre e mio padre sono i libri che avrei voluto scrivere, che avrei voluto leggere, nonostante gli errori di battitura, i refusi, le bruciature, gli angoli piegati. Sono i libri che riapro e rileggo, dai quali ottengo risposte, che mi suscitano nuove domande. Sono i libri che non ingialliscono col tempo e che del tempo conservano il profumo, lo spessore, la ruvidezza e la leggerezza, il peso e il volume, lo sguardo».
Così, a questa conclusione, Christian Mascheroni, autore televisivo e scrittore, giunge al termine del suo romanzo autobiografico Non avere paura dei libri (Hacca, 2013), un viaggio nel suo io più intimo e profondo, tramato e forgiato dalle letture fatte sin dall’infanzia. L’amore per tutti i libri, l’invito a non averne paura anche se non adatti alla sua età, è il lascito più prezioso ricevuto dai genitori, in particolare dalla madre Eva.
Ma Non avere paura dei libri è soprattutto una storia di dolore costellata di qualche parentesi di felicità. Nei libri il piccolo Christian si rifugiava quando la madre era talmente ubriaca da non reggersi in piedi per andare a insegnare tedesco alle scuole serali. Ai libri letti sono legati i ricordi, a volte caldi come una carezza, più spesso laceranti come un graffio inciso da unghie laccate di smalto rosso: «Mia madre Eva – la viennese colpevole di bere davanti al figlio; io – il bambino colpevole di non essere abbastanza da farla smettere. Ero tormentato da questa idea. Pensavo che se fossi stato un figlio più forte e amorevole, sarei stato in grado di salvarla».
Quando la paura dei demoni del passato non assaliva Eva, Christian aveva modo di godere momenti di sfrenate risate e di conversazioni stimolanti sui libri letti, momenti di grande complicità. Perché Eva era eccesso e misura, euforia e apatia, allegria e depressione. Eva era capace di ridere fino alle lacrime e un attimo dopo di mettere il broncio e piangere fino a non avere più lacrime. Ma nessuno, neppure l’amore discreto e silenzioso del marito pompiere Gino riusciva a sedare le fiamme dell’incendio che le divampava dentro. Un’eterna lotta di cui alla fine non rimaneva che la cenere dei mozziconi di sigaretta sulle pagine sparsa, bottiglie vuote seppellite sotto maglioni, pillole colorate lasciate nei posti più impensabili.
Quanto lontani erano allora quei giorni di sole e di mare quando il succo di anguria, trangugiato tra le risate, cadeva sui libri acquistati in vista della villeggiatura.
Nato nel 2011 come racconto a puntate sul blog di Chicca Gagliardo, «Ho un libro in testa», Non avere paura dei libri è un romanzo sofferto, dalla scrittura essenziale e vigorosa, e necessario per elaborare il lutto. Solo ora che la sua assenza è incolmabile, l’autore si rende conto di quanto il senso dato alla sua vita fosse dipendente e volto a compensare la dura esistenza della madre. Un amore viscerale non privo di scontri e rappacificazioni, distacchi e ritorni ma indissolubile e incancellabile.
Mascheroni sa indagare con semplicità e coinvolgimento gli stati d’animo, le fragilità proprie e dei suoi familiari, i fantasmi psicologici che si aggirano dentro le lezioni di tedesco, i natali e le pasque sempre uguali, le sbornie, il logorio dell’autoanalisi, quella sorta di delirio che lo porta a maledire la persona che più ha amato e che amerà per sempre oltre la vita e la morte, rammaricandosi di non essere stato per lei abbastanza.
(Christian Mascheroni, Non avere paura dei libri, Hacca, 2013, pp. 256, euro 14)