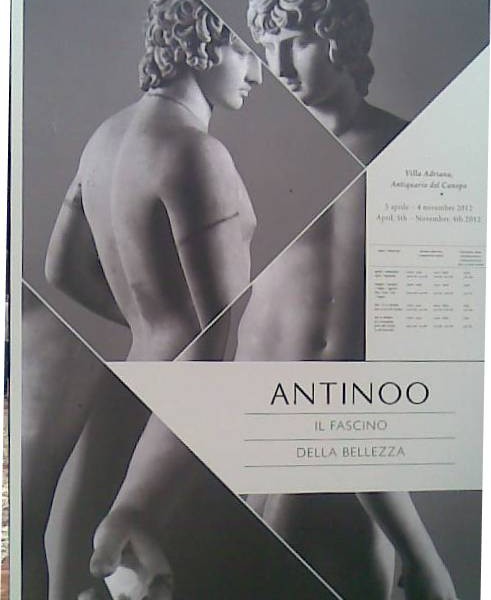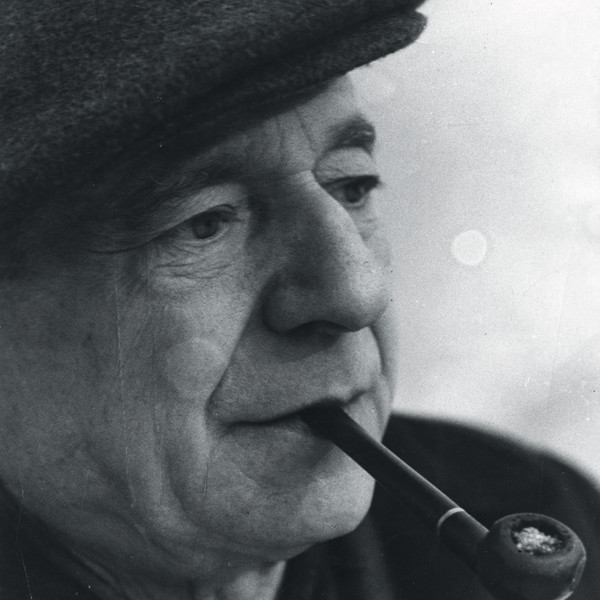Giovedì 11 ottobre esce nelle sale italiane On the Road, trasposizione cinematografica per la regia di Walter Salles del romanzo di Jack Kerouac Sulla strada (riedito da Mondadori nella collana Numeri Primi).
Il rapporto tra il capolavoro della letteratura beatnik e il cinema è lungo e travagliato. Sin dall’anno della sua prima pubblicazione negli Stati Uniti nel 1957, Kerouac iniziò a immaginare una versione di celluloide delle avventure di Sal Paradise, alter ego dell’autore, e compagni. L’idea era chiara: sarebbe stato lui stesso a curare la sceneggiatura, comprimendo e riorganizzando la trama del libro in un viaggio unico, andata e ritorno, da New York al Messico, passando per Frisco, Denver, New Orleans. Questo è quello che si apprende da una lunga lettera che lo scrittore di Lowell inviò a Marlon Brando nel 1957 e ritrovata solo nel 2005. Il sogno di Kerouac era che l’attore di Fronte del Porto e de Il Selvaggio interpretasse il ruolo di Dean Moriarty, il compagno di viaggio del protagonista, mentre a vestire i panni di Paradise sarebbe stato Kerouac stesso, per espressa volontà della Warner Bros.
Con il suo film, Kerouac si poneva il non poco ambizioso obiettivo di rivoluzionare il cinema, conferendogli quella «spontaneità» al di fuori del preconcetto della «situazione» che gli era mancata fino a quel momento.
Il progetto, però, naufragò prima ancora di uscire dal porto: Brando non rispose mai alla lettera, la Warner Bros perse in fretta l’interesse e si smise di parlarne per un lungo periodo.
Fu solo nel 1979, dopo che Francis Ford Coppola acquistò i diritti del libro per la sua casa di produzione, che si iniziò a parlare di nuovo di una versione cinematografica. Il primo regista contattato fu Jean-Luc Godard, ma il progetto si perse in fretta. Fu poi la volta, anni dopo, di Gus Van Sant, con Brad Pitt chiamato a interpretare il ruolo di Moriarty. Sembrava fosse ormai tutto pronto, tanto che Barry Gifford, sceneggiatore di Cuore Selvaggio di David Lynch, assunto per buttare giù il copione, dichiarò, a inizio anni novanta, che ormai il film era «cosa fatta». Ancora una volta, invece, le riprese si arenarono ancora prima di iniziare.
Arriviamo così al Sundance Film Festival del 2004, in cui Walter Salles, dopo aver presentato I diari della motocicletta, viene raggiunto da Roman Coppola, figlio di Francis e presidente della casa di produzione di famiglia, l’America Zoetrope, che gli propone la regia del film. Salles accetta, ma prima di concentrarsi sul progetto decide di dedicarsi a un lungo lavoro documentario attraverso gli Stati Uniti sulle tracce di Kerouac, come già aveva fatto con Che Guevara prima di mettersi al lavoro sui suoi diari. Durante il viaggio durato quasi sei anni, Salles ha avuto modo di incontrare i protagonisti del romanzo e i loro figli, di intervistare musicisti e artisti che in varia maniera sono stati influenzati dalla Beat Generation, di visitare il luoghi del romanzo e della vita di Kerouac.
Per preparare il film, poi, Salles mette su un Beatnik camp vicino Montreal dove chiama a raccolta gli interpreti, da Kristen Stewart a Viggo Mortensen, per un ritiro preparatorio di tre settimane a base di musica e lunghe conversazioni sulla letteratura beat.
Presentato in concorso durante la sessantacinquesima edizione del festival di Cannes, il film di Salles è ora chiamato alla prova del pubblico. La resa di un mostro sacro della letteratura internazionale come è il libro di Kerouac è impresa ardua e rischiosa che ha pochi precedenti.
A parte i falliti tentativi di trasposizione di Sulla strada, manca un’interrelazione diretta tra letteratura beat e cinema. Lasciando in un angolo l’influenza implicita che lo spirito degli anni’40 e ’50 narrato da Kerouac e dagli altri autori dell’epoca ha avuto sulla produzione della cosiddetta New Hollywood, da Easy Rider in poi, i tentativi di raccontare apertamente su schermo i testi e i personaggi di quella grande rivoluzione letteraria sono rari e confusi.
Nel 1959 Kerouac sceneggiò Pull My Daisy, film breve, di cui fu anche voce narrante, per la regia di Robert Frank e Alfred Leslie. Il cortometraggio può essere ritenuto l’unico autentico esperimento di cinema beat. Prendendo il titolo da un poema composto negli anni ’40 dallo stesso Kerouac, Ginsberg e Neal Cassady, ma ispirandosi per la trama al terzo atto del dramma, sempre di Kerouac, The Beat Generation, il film muove dall’incontro a cena tra un ferroviere e un vescovo che assumerà mano a mano connotati surreali con le incursioni degli amici bohémien del macchinista. Partendo da un copione minimo, gli interpreti, tra i quali i poeti Allen Ginsberg e Gregory Corso e l’artista David Amram, si lasciano andare al flusso dell’improvvisazione con un linguaggio più simile a «quello della pittura o del collage che a quello della regia cinematografica» (Jim Jarmusch).
L’anno successivo la Metro Goldwyn Mayer acquisì i diritti per The Subterreans, romanzo del 1958 dello stesso Kerouac. La vicenda, imperniata sulla relazione tra un giovane scrittore e Mardou Fox, una donna afroamericana, venne indebolita in riscrittura sin dalle premesse, trasformando il personaggio di Mardou in una giovane francese, per suscitare minor clamore tra il pubblico della middle-class statunitense. Il film che ne seguì, La nostra vita comincia di notte, per la regia di Ranald MacDougall, fu fortemente criticato da Ginsberg per la resa scialba e inespressiva dei personaggi.
Negli anni ’60, la MGM realizzò alcuni film ispirati velatamente alla cultura beatnik ma non direttamente collegati alla corrente letteraria, come The Beat Generation di Charles F. Haas.
Nel 1980 John Byrum realizza Heart Beat, ispirandosi all’autobiografia di Caroline Cassady e al triangolo che lei, interpretata da Sissy Spacek, Neal Cassady/Nick Nolte e Jack Kerouac/John Heard intrattennero sul finire degli anni ’50. Allen Ginsberg rifiutò che venisse utilizzato il suo nome nel film ritenendolo una cattiva rappresentazione dell’epoca, mentre William Burroughs ebbe modo di lodare la pellicola scrivendo su Rolling Stone di essere «tornato a respirare la stessa atmosfera del passato» dopo una visita sul set.
A parte una serie di documentari, tra i quali The Beat Generation: An American Dream (1987)in cui i protagonisti dell’epoca, da Ginsberg a Ferlinghetti, ricordano la nascita della movimento, bisognerà attendere fino al 1991 prima che qualcuno torni a confrontarsi con un classico beat. Il pasto nudo di David Cronenberg rappresenta, infatti, l’ultimo, e anche il primo, grande incontro tra cinema e letteratura beat prima del film di Salles. Partendo dal romanzo di William S. Burroughs, da molti ritenuto infilmabile per il suo alternare deliri e allucinazioni da droghe in un susseguirsi di frasi e periodi senza apparente correlazioni logiche, Cronenberg mette in scena una lettura più ampia della vita e dell’opera dello scrittore muovendosi in equilibrio tra ironia, satira politica e fantascienza.
Nel 1997 esce, poi, L’ultima volta che mi sono suicidato, di Stephen Kay, mediocre ricostruzione di un amore di Neal Cassady basata su una lettere inviata a Kerouac.
Nel 1999 Chuck Workman realizza The Source, mockumentary in cui si raccolgono ricordi e confessioni di Kerouac, Ginsberg e Burroughs attraverso immagini di repertorio e filmati privati. A interpretare i tre autori, in alcuni spezzoni basati su documentazione non filmata, sono, rispettivamente, Johnny Depp, John Turturro e Dennis Hopper.
Vicino a The Source, anche se appartenente a tutti gli effetti al genere della fiction, è il recente The Howl – Il grido (2010) in cui Rob Epstein e Jeffrey Friedman ricostruiscono il processo per oscenità intentato contro la City Lights di Lawrence Ferlinghetti per la pubblicazione di Howl and Other Poems, raccolta a firma di Allen Ginsberg in cui si narrano vicende di droghe e di sesso sia eterosessuale che omosessuale. Nel film, suddiviso in quattro sequenze alternate – la prima lettura di Howl nel 1955, alla Six Gallery di San Francisco; il processo; la poesia recitata in voice over su animazioni digitali a cura di Eric Drooker; un’intervista a casa del poeta –, il Ginsberg interpretato da James Franco ricostruisce i primi anni della Beat Generation, il suo incontro con Neal Cassady e Jack Kerouac e quei tempi in cui loro non erano nient’altro che un gruppo di scrittori in cerca di un editore.
Nel 2013 si vedrà invece sullo schermo un altro classico di Kerouac. Dopo On the Road, infatti, lo scorso 23 settembre è uscito on-line il primo trailer ufficiale di Big Sur per la regia di Micheal Polish, tratto dal romanzo omonimo del 1962, in cui Jean-Marc Barr interpreta lo scrittore nei suoi giorni trascorsi nella costa centrale della California per sfuggire alla celebrità di Sulla strada.