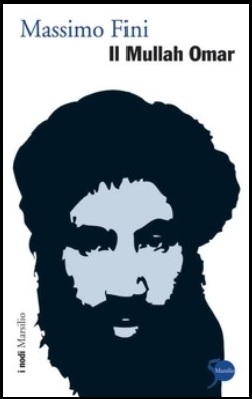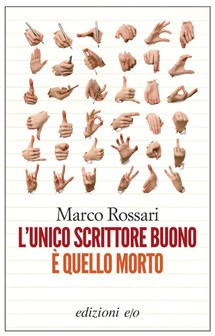Ok, il caso editoriale dell’anno (passato), nel suo genere (moda e costume) è sicuramente La parigina – Guida allo chic (L’Ippocampo, 2011) di Inès de la Fressange e Sophie Gachet, quest’ultima giornalista di moda di Elle Francia.
Copertina di pelle rosso lacca, scritte corsive in oro e un’elegante firma in calce della stessa Inès; molti tra coloro che l’hanno acquistato non lo hanno fatto per leggerlo, ma per averlo: è un oggetto che chi si interessa di costume e di stile desidera possedere. La figura allungata di una donna in pantaloni e capelli al vento incisa sulla copertina vi obbliga a prendere dallo scaffale questo oggetto sublime. Da veri feticisti.
Spulciando il web e le varie riviste di settore di cui sono fornita, nessuno, che so’, nemmeno una signora in sovrappeso indispettita dalla silfide Inès, ha osato storcere anche di poco il naso leggendo la sua ultima fatica. Vediamo perché.
Chi è Inès de la Freissange? Ad oggi la definirei una post-model di 54 anni che lo scorso anno tornava a sfilare per Chanel e Jean Paul Gaultier, calcando le passerelle con la sua famosa falcata a X e i bronci che la resero la regina delle stesse negli anni ‘80, a soli vent’anni, quando Kaiser Karl Lagerfeld, per Chanel, la assunse a sua musa ispiratrice con un contratto di sette anni in esclusiva. Il perfido decise anche che Ines, che era tanto bella e rappresentava tanto bene la sua arte, poteva anche esprimere, a tratti, delle opinioni, da qui il soprannome “la mannequin qui parle”, la modella parlante (speriamo anche pensante!). La leggenda narra che però lei gli fece uno sgarro terribile: decise di prestare il suo volto per la Marianna di Francia. Kaiser Karl bollò questa scelta come iniziativa personale di tono rozzo e volgare, insomma, non in sintonia con l’esprit di Coco: il Kaiser «non veste le statue», quindi la licenziò e fecero la pace solo più di vent’anni dopo. Credo che il pianeta si sia ragionevolmente rassegnato a tale increscioso evento molto presto.
Come è arrivata Inès a parlare con e per Karl Lagerfeld? A essere definita una delle maggiore autorità al mondo in quanto a stile? A diventare ambasciatrice e manager per la boutique del lusso francese Roger Vivier? Be’, altri comuni mortali avrebbero fatto di certo più fatica.

Figlia del marchese André de Seignard de la Fressange e della modella argentina Cecilia Sánchez Cirez, Inès cresce appena fuori Parigi in un clima alto borghese e bohémien.
Sua nonna paterna, Madame Simone Jacquinot, era l’erede della grande banca Lazard: nella sua fatica letteraria precedente (Professione mannequin, Dalai, 2011), Inès esordisce infatti dicendo che a quattro anni la nonna le fece cucire su misura un pelliccia di ermellino e che passò l’infanzia e l’adolescenza a spulciare tra i sofisticati capi di alta moda di “nonnina” e “mammina”.
Certo, lei sostiene che era ricca e contornata dalla bellezza ma che i genitori non le davano affetto – sta cercando chiaramente di non farsi odiare.
Ci riuscirà? Un’ereditiera dell’alta finanza, dunque, di sangue blu, alta un metro e ottanta che a più di cinquant’anni sfila ancora per Chanel tenendo testa alle modelle russe quindicenni, che rifiuta il botox e a cui le rughe donano davvero. No, non ce la può fare, ci sta antipatica per forza.
E invece, basta guardare qualche sua immagine e soprattutto sfogliare questo libro e vi sembrerà, se non un’amica, un’amabile consigliera, nella maggior parte dei casi più bella e ricca di voi, certo, ma umana e non distante.
Inès de la Fressange è davvero un’icona dell’eleganza francese. A cinquantaquattro anni sembra una ragazzina, è sottile, elegante, ha una classe unica che oggi distilla in una guida allo chic à la parisienne, modello parigina.
Ma cosa avranno di tanto speciale queste parigine? La risposta è accennata nelle prime pagine di questa leggera guida, illustrata con 350 disegni della stessa autrice: «Non occorre essere nate a Parigi per avere uno stile da parigina. Avere l’aria “made in Paris” è un atteggiamento mentale».
Avendo vissuto a Parigi, posso dire che sì, le madames d’oltralpe hanno un’allure speciale e senza voler entrare nel merito del significato più stretto del termine chic, di certo si distinguono.
Inès ci dice che: «La parigina non cade mai nella trappola delle tendenze: la sua ricetta segreta sta nel lasciarle maturare e nel servirsene con discernimento. Senza perdere mai di vista il principale obiettivo, cioè quello di divertirsi con la moda». E questo mi piace, «divertirsi». La signora fa un’operazione rara nel mondo in cui si muove: gioca, sa che sta parlando di cose frivole, non le interessa peregrinare filosoficamente sul significato di chic o peggio ancora sul valore dell’estetica, vuole svelare al gentil sesso delle dritte che ha imparato da addetta ai lavori, con le quali sa divertirsi e che possono facilitare le operazioni di vestizione giornaliera di tutte le donne.
Apparentemente facile, ma davvero difficile da mettere in pratica senza conoscere i sei punti dello stile parigino (diciamo dello stile) e i sette capi classici di abbigliamento che non possono mai mancare nel nostro guardaroba: una giacca da uomo, un trench, un pullover blu marine, una canottiera, un tubino nero, dei jeans e un blouson di pelle. Il tutto dosato senza cadere nella trappola che differenzia la vera Parigina dalla non, ovvero essere bling. Mai avere un guardaroba carico di orpelli, marche in evidenza, stampe vistose, paillettes, animaletti, pupazzetti: bisogna imparare a eliminare, tenere solo l’indispensabile, pensare basico.
È necessario ricordarsi che il vero must è la sobrietà, trasgredire alla ferrea dieta solo con eventuali accessori scelti ad hoc.
Sobrietà, che termine meraviglioso! Credo che molti ne sentano finalmente un estremo bisogno.
Dagli abiti alle borse, dalle scarpe al trucco e alla cura del corpo, Inès ha il suggerimento probo per tutte le situazioni, cene di lavoro e primi appuntamenti compresi; quelle che cercano la soluzione giusta per un invito a cena, ma anche per chi vuole rivoluzionare la sua immagine seguendo un modello ben collaudato.
La parte migliore del libro è quella degli indirizzi utili in città, dove acquistare i capi di abbigliamento della parigina doc o dove scegliere il complemento d’arredo giusto per aggiungere un po’ di french style al vostro appartamento. Perché lo stile parigino si riflette anche nel modo di vivere la vita, nel savoir faire. È per questo che Inès ci suggerisce anche il modo giusto per vivere la città, frequentare librerie o scegliere il ristorante.

Ora, a me il libro è piaciuto, credo altresì che il suo vero punto di forza, al di là di essere davvero sfizioso e leggero (spesso non dice niente di assolutamente inedito, specie per chi ha coltivato un certo interesse per la letteratura di moda), sia il modo accattivante in cui si propone: è piacevole per chi già sapeva che le spalline del reggiseno in silicone in estate sotto i vestiti smanicati sono semplicemente orrende, ed è fondamentale per chi, povera lei, ha nel cassetto tale oggetto. Spero che con un po’ di vergogna se ne sbarazzi presto.
Credo che sia un testo, non me ne vogliano i veri etici, che in questo momento storico possa anche essere approcciato con un occhio alla crisi e al severo cambiamento epocale che stiamo vivendo.
Inès, infatti, per quasi tutto il libro ci propone di evitare di comprare, o comunque ci invita a comprare poco, less is more. Sono necessari pochi capi nell’armadio, poche borse, e se vogliamo spendere ci guida a Parigi per lo shopping più avveduto e di qualità.
Io ho trovato quella sezione deliziosa, sembra redatta con l’affetto di chi davvero vuole condividere un pezzetto del proprio vissuto.

Certo, non c’è una riflessione sul concetto di chic in sé. Il libro, come dicevo prima, non ha nessuna pretesa: da parte mia gli perdono una certa dose di buonismo, o di distrazione su alcuni dati del corpo femminile che potrebbero far cadere il suo teorema sui must have.
Cara Inès, vorrei dirle con affetto, la giacca da uomo con canotta maschile, scarpe All Star o ballerine, abbinata al mitico jeans bianco cinque tasche non sta bene proprio a tutte, non credo possa essere il “look vincente” sempre e comunque come lo definisce lei per ovvie ragioni di proporzioni, (la giacca da uomo dona a donne con spalle larghe, vita stretta e pochissimi fianchi, così come canotta, ballerine e le All Star, che insieme ai pantaloni chiari hanno il potere di abbassare e allargare drammaticamente ogni essere umano non sufficientemente sottile e slanciato). La perdono perché la credo candida: per nascita, natura e vocazione probabilmente si è trovata raramente a interrogarsi sui fisici di donne diverse da quelle che si muovono nel suo Pantheon di moda e stile. La perdono perché mi piace pensarla lì, ancora un po’ distante da tutto il resto, chic con sette cose nell’armadio e capace, nonostante tutto, di non esserci antipatica, bensì di grande aiuto. Chapeau.