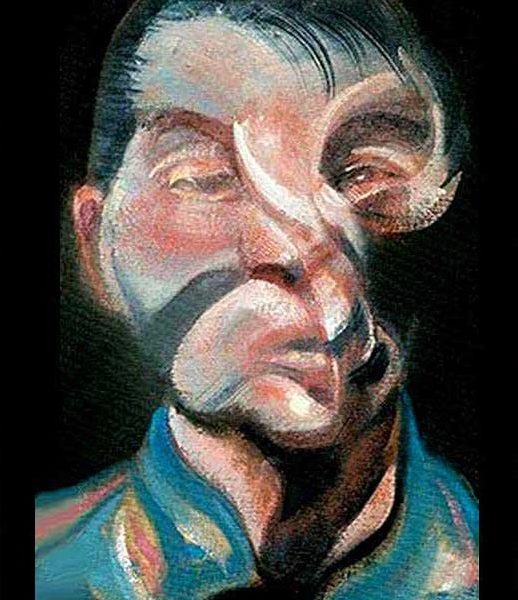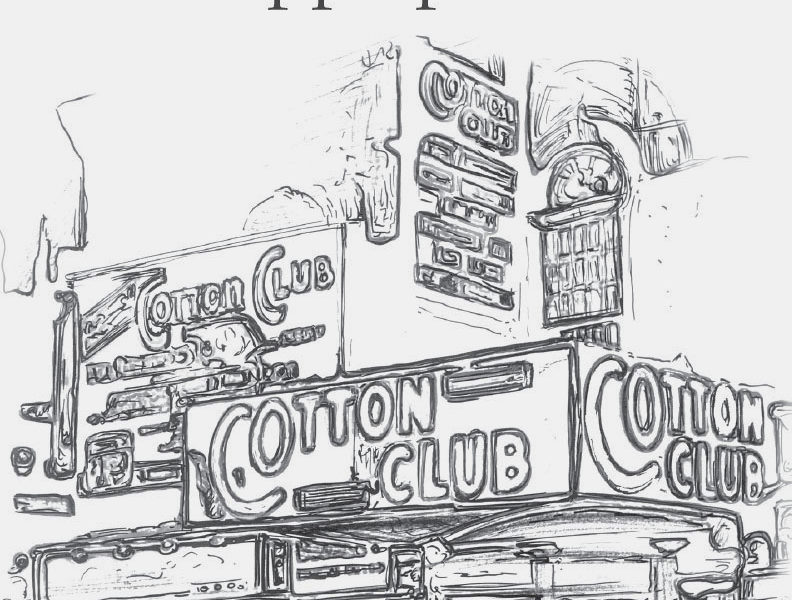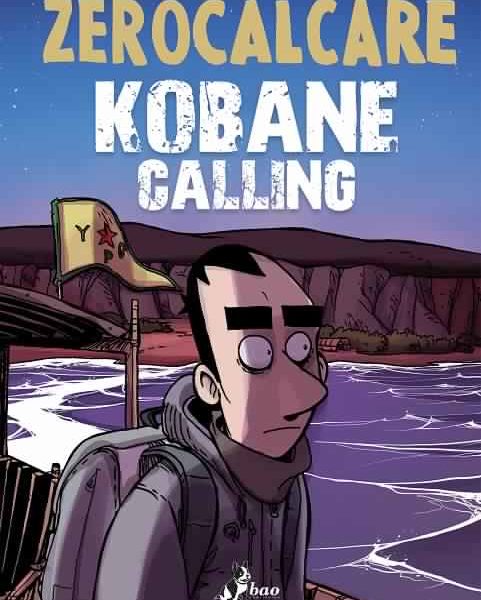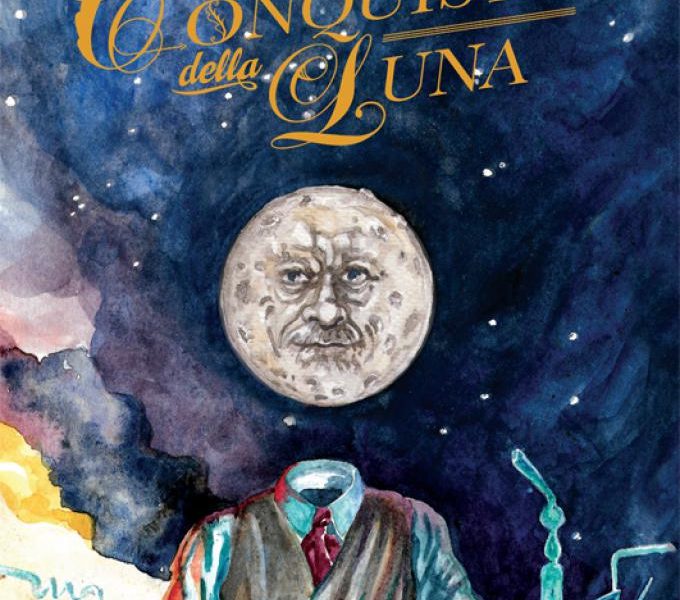Della mia vita precedente ricordo soprattutto certe notti. In quel periodo abitavo in un appartamento dalle pareti sottili, in un condominio di periferia pieno di giovani rumorosi e coppie con figli. Nelle notti d’estate la gente chiacchierava fino a tardi, sui balconi o appoggiata ai davanzali delle finestre; le parole si sollevavano come volute di fumo, filtrando attraverso muri porosi come gesso. Sentivo quelle conversazioni come se fossero pronunciate da qualcuno seduto ai piedi del mio letto. Partecipavo, inevitabilmente. C’erano dichiarazioni d’amore toccanti, lacrime di furore e persino soliloqui imbarazzati. Nelle liti più accese distribuivo le colpe e, sdraiato nella penombra, prendevo le parti di chi mi sembrava nel giusto. Mia moglie non si è mai accorta di nulla: aveva il sonno pesante, lei, le sue palpebre erano gravi e carnose quando dormiva, due scuri serrati, e il respiro le scivolava giù fino in fondo al petto, talmente leggero da farsi impercettibile. Forse lei non respira, non respira affatto, mentre dorme.
Un mattino di settembre – aveva appena piovuto – mi sono svegliato con il braccio indolenzito. C’era un parco giochi malmesso davanti al mio palazzo, e avevo sognato di dondolare sull’altalena cigolante, di notte. L’aria era fredda e rarefatta, nel sogno, bianca come la luce della luna piena. Mi alzavo in piedi sull’altalena, come a volte facevo da piccolo per volteggiare trasportato da un surplus di eccitazione, ma scivolavo in continuazione e rimanevo appeso alle catene per non cadere. La spalla destra era dolorante, ma pensai di aver dormito in una posizione strana, e non ci avrei mai più pensato se due giorni dopo, appena sveglio, non mi fossi ritrovato un’evidente escoriazione sulla faccia.
«Che cavolo mi hai fatto?» Chiesi a Benedetta, uscendo dal bagno. Lei cacciò un urlo non appena mi vide.
«Che cavolo hai fatto?»
Nessuno dei due ne sapeva nulla. Mi medicai come meglio potevo e andai a lavorare. All’epoca ero dipendente di una concessionaria di auto usate e per un venditore un’abrasione di dieci centimetri sotto l’occhio sinistro non è un gran biglietto da visita, per cui mi relegarono in ufficio a gestire i passaggi di proprietà per i successivi dieci, noiosissimi giorni. Seguivo il viavai della clientela dalla porta a vetri della mia stanzetta (tutte pareti a vetri, in quel negozio, un presidio contro gli scansafatiche, una specie di rete a strascico in cui finivano intrappolati anche esemplari più o meno innocenti, uomini i cui corti calzini bianchi spuntavano da sotto la scrivania, o che avrebbero dovuto rinunciare al vizio di infilarsi le dita nel naso). Fu quando un collega tirò fuori la Cadillac Escalade per un test drive che mi tornò in mente il sogno. La Cadillac, un grosso Suv americano tanto potente quanto inutile, era un bestione invenduto, nero come un gatto nero: per quanto abbassassimo il prezzo non riuscivamo a vederlo sparire. Se ne stava al centro del garage come un grosso scarafaggio, un animale infestante fatto di lamiere a forma di senso di colpa, che accusava noi dipendenti di incapacità, non appena il capo metteva un piede nel negozio. La notte prima di svegliarmi sfigurato, avevo sognato di viaggiare sulla Escalade da solo, serpeggiando in discesa lungo una serie di tornanti. Dopo un paio di curve l’auto aveva iniziato a non rispondere più ai miei comandi: i freni funzionavano e la Cadillac era in grado di girare, solo che non ero più io a decidere cosa fare e quando farlo. L’Escalade scalava diligentemente prima delle curve e disegnava traiettorie perfette, ma il panico cresceva dentro di me metro dopo metro: fissavo il parabrezza con gli occhi spalancati e le mani alzate, come se fossi la vittima di una rapina. Percorremmo circa due chilometri poi la cintura di sicurezza si sganciò lasciandomi indifeso: l’auto inchiodò e io schizzai come il proiettile di una fionda sfondando il parabrezza. Mi ritrovai disteso sul cofano, disperatamente aggrappato al radiatore, mentre la Escalade riprendeva la sua corsa accelerando nella notte.
Le strade erano vuote di persone e di cose: niente auto, niente gatti, niente bidoni della spazzatura, solo la luce spettrale dei citofoni sui muri dei palazzi, e i bordi sbeccati dei marciapiedi. Gli oggetti arretravano per fare spazio al ruggito della Cadillac, o almeno questa era la mia impressione, e la città era diventata una conca abbastanza ampia da accogliere per intero il mio dilagante terrore. Al negozio teniamo sempre le auto lucide e incerate: non ricordo come fossi vestito ma so che i pantaloni che indossavo non facevano alcun attrito sulla carrozzeria dell’auto e venivo sbattuto da una parte all’altra. Mi ritrovai con i piedi precariamente appoggiati su uno dei fanali, finché non scivolarono entrambi e io con loro, riuscendo ad aggrapparmi solo al radiatore. L’asfalto correva veloce trenta centimetri sotto la mia schiena, e anche se avevo il viso rivolto verso il cielo ora ricordo la linea di mezzeria sfilare via rapidamente come se allora fossi in grado di vederla. L’auto, sadica, accelerò ancora, andò avanti a una velocità irreale per due o trecento metri e alla fine inchiodò. Io persi la presa, mi rigirai non so come nell’aria e atterrai di fronte all’auto strusciando il viso sull’asfalto.
«Che cazzo è successo, qui?» L’urlo mi strappò via da quei pensieri, o da quei sogni (non so bene, infatti, se stessi solo ripensando a quel sogno o se lo stessi sognando di nuovo). Mi feci sulla porta dell’ufficio, un’iniziativa velleitaria, considerando le pareti di vetro. Carlo era appena sceso dalla Cadillac, e si guardava intorno. È un fumatore incallito, ha le dita gialle di nicotina e la voce roca, per cui sarebbe stato difficile non accorgersi che era stato lui a parlare.
«Che cazzo è successo?» Ripeté. Rivolse lo sguardo verso noi colleghi, passandoci in rassegna mentre indicava il parabrezza frantumato della Escalade. Fecero tutti spallucce. Feci lo stesso anch’io, anche se un certo rossore mi salì alle guance. Un po’ me l’aspettavo, in realtà: avevo già capito com’è che andava la cosa.
Per i cinque o sei giorni successivi non accadde nulla, e cominciai a coricarmi più sereno dopo due o tre notti in cui mi ero infilato sotto le coperte come se partissi per un viaggio dalla destinazione ignota. Poi però fu la volta della paralisi: sognai di essere sdraiato sul divano della casa in cui abitavo da bambino. Ero in posizione supina, rigido come un morto eppure cosciente; riuscivo a muovere solo gli occhi, in su e in giù, per osservare le persone che sfilavano ai lati del divano gettandomi una rapida occhiata di curiosità o compassione, poi si affrettavano per uscire. Anche se non arrivavo a vederla (più che uscire quei muti visitatori si dissolvevano ai margini del mio campo visivo) ero certo che passassero attraverso la porta di legno chiaro che un tempo introduceva al salotto dei miei. Riuscii a distinguere il mio vecchio insegnante di pianoforte, con i denti gialli e il colorito canceroso; la prozia Eugenia a mani giunte; il garagista che aveva custodito l’Alfetta di mio padre; i miei compagni di classe in fila per due, nei loro grembiuli stirati, e ovviamente i miei genitori e i miei nonni, né sorridenti né tristi, e mio fratello maggiore ancora vivo nonostante due infarti. Passarono persone che non sapevo di conoscere, ma che evidentemente si nascondevano in un anfratto riposto della mia memoria, e personaggi inventati usciti fuori da libri e telefilm. Passò anche un bambino che avrebbe potuto essere mio figlio, se ne avessi avuto uno, o anche un altro me stesso riemerso dall’infanzia. Alla fine arrivò mia moglie. Era bella come quando l’avevo conosciuta, i capelli ricci che brillavano di una luce dorata: è come fissare il sole attraverso un barattolo di miele, le dicevo sempre. La prima volta che l’avevo vista aveva poco più di vent’anni. Era seduta con altre due ragazze di fronte a una fontana, in centro. Rideva. Non so se il suono che ricordo è quello della sua risata o il frastuono schiumoso dell’acqua alle spalle delle ragazze; sono suoni indistinguibili, nella mia memoria. Avrei voluto sedermi accanto a lei e non alzarmi mai più. Avrei voluto gettarmi ai suoi piedi e giurarle che non l’avrei lasciata. Avrei voluto che mi uccidesse per essere per sempre suo. Ero giovane. L’amico con cui mi trovato, Fausto, conosceva una delle ragazze che erano con lei, così ci presentammo. Da quel giorno iniziai a seguirla ovunque, cercando pretesti per passare sotto casa sua, trasalendo ogni volta che una ragazza con il suo stesso motorino mi passava davanti, fingendo di avere bisogno del suo parere (ma ne avevo bisogno davvero, e fingevo di fingere) e facendomi invitare ai compleanni di persone che detestavo, se sospettavo che lei fosse presente. Cercavo di forzare la sorte, per quanto possibile.
In quel periodo Benedetta studiava filosofia e collaborava con una piccola casa editrice. Definirlo un lavoro forse è troppo, ma era un’occupazione meravigliosa, dal mio punto di vista. La pagavano poco per affibbiare titoli efficaci a racconti e romanzi, in sostituzione di quelli spesso prolissi e poco incisivi che autori scapigliati e forforosi apponevano in cima ai loro manoscritti. Lei era bravissima. Ricordo Luna di sangue, Oblomov al canottaggio, I denti perfetti di Miss cagnolina, Esperanto sentimentale… L’ossessione per i titoli finì per condizionarla a tal punto che cominciò a dare un titolo a tutte le esperienze che viveva o che le venivano raccontate: quando si laureò, lei che si sottovalutava sempre, disse che quello sarebbe passato alla storia come Il trionfo della regina da un soldo; Fichi sott’olio era il resoconto di un mio incidente in motorino mentre da casa sua tornavo nell’appartamento dei miei; Salici di vetro raccontava una settimana di vacanza in montagna, Nervi di nylon e pelle di tamburo, invece, un concerto jazz all’Alexander Platz. Da conoscitrice esperta di titoli, aveva una sua personale classifica: adorava L’amore ai tempi del colera, anche se non aveva mai letto il libro, Il mondo come volontà e rappresentazione, Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo. Ripeteva i suoi titoli preferiti a bassa voce, muovendo appena le labbra, seduta su una poltrona di velluto blu rivolta verso il muro, contro una parete bianca. La cosa cominciò a darle dipendenza. Trovare un titolo per ogni esperienza vissuta sembrava la soluzione più efficace per ovviare al caos dell’esistenza. Ogni evento in un segmento di tempo, ogni segmento con il suo cartellino: tutto era ben delimitato e circoscritto, senza possibilità di sconfinamenti. Quello che fino a poco prima era stato il regno di una sfrenata fantasia si tramutò nell’esatto contrario: una gabbia, una rete, la trappola di un sentiero già tracciato. Invece di dare un nome a ciò che accadeva, Benedetta finì per partorire titoli inventati di sana pianta, calandoli poi dall’alto sulla realtà: un gioco d’incastri dagli esiti discutibili. In quel periodo stavamo insieme da circa tre anni. Si era laureata e non aveva fatto nulla della sua laurea, così, invece di prendersela con sé stessa per come aveva impiegato il tempo, se la prese con il tempo che l’aveva ingannata. Partorì l’idea di scrivere un libro costituito solo da titoli: voleva essere un modo per dare un significato al lavoro degli ultimi anni, ma era solo un’altra maniera per limitarsi. A cosa serve un titolo se non intitola nulla? È un recinto intorno al vuoto. L’editore (il suo editore) rifiutò la proposta. Benedetta si licenziò, ammesso che ci si possa licenziare da qualcosa che non è propriamente un impiego; si tagliò i capelli all’altezza delle orecchie e cominciò a indossare orribili tailleur pantalone dai colori spettrali. Di lì a qualche mese trovò lavoro in un’agenzia immobiliare, ottenendo l’approvazione di suo padre e arrivando con il tempo a dirigere quella piccola azienda con l’attitudine manageriale e spigolosa che tutto di lei promanava d’improvviso.
Ecco perché mi stupì tanto vederla china su di me, mentre io rimanevo sdraiato sul divano in quel sogno che forse non era un sogno o forse sì: perché a tutti gli effetti Benedetta era quella di una volta. I capelli, gli occhi, le mani. Le labbra socchiuse mimavano un bacio, o forse dicevano qualcosa che non riuscivo a cogliere, nello stato comatoso di quella morte onirica. Una M, credo, una smorfia come per soffiare con la lingua tra i denti, poi ancora una M, un soffio e la lingua tra i denti, e poi ancora, di nuovo.
«Svegliati», sentii dire. Ma ero già sveglio. Le ossa mi facevano male e non riuscivo a muovermi; ero lì, disteso come una salma, prigioniero nella mia stessa pelle. Con enorme sforzo chiusi e riaprii le palpebre. Tutto intorno a me cominciò a fari sfocato, per poi riacquistare nitidezza secondo nuovi contorni: le pareti della casa dei miei genitori divennero quelle della mia camera da letto e i capelli di Benedetta tornarono all’altezza delle orecchie. «Svegliati», mi disse lei. Mi diede anche uno schiaffo. «Sono sveglio», risposi io tirandomi su dal letto. Mi massaggiavo la guancia colpita. Non ero sicuro di essere sveglio, in realtà. Erano poche, ormai, le cose su cui potevo fare affidamento.
Nelle notti successive feci sogni tempestosi. Credetti di essere orbo e lo fui, il giorno dopo, seppur brevemente. Cantai alla perfezione per quarantotto ore dopo aver recitato un’intera notte in I Troiani di Berlioz. Facevo anche sogni più prosaici, sogni – per esempio – in cui divoravo cipolle ritrovandomi da sveglio in preda all’alitosi. Poi le mie notti cominciarono a perdere consistenza, lasciavo il mio involucro carnale e acquistavo una consistenza altra: ero un anemone frusciante nel mare, il grasso nella gobba di un cammello, la scia tracciata da uno scafo sulla superficie dell’acqua. Di più: ero un’etimologia, il suggerimento sussurrato a un attore in teatro, una nota stonata o un fischio, il sibilo di una fiamma che brucia. E tale mi sentivo, per ore e ore, vibrando impercettibilmente dopo essermi lavato e vestito.
Non era solo la tangibile intensità dei miei sogni, a stupirmi, né la loro tendenza a invadere la veglia, ma anche il processo inverso per cui la realtà sembrava contaminata dall’illusione. Quando tornavo a casa dal lavoro, la sera, il cielo acquistava bizzarre sfumature. Strane creature gracchianti lo attraversano, mentre dal buio umido dei tombini che calpestavo mi spiavano sclere giallognole e luccicanti. La ruvida concretezza di quelle chimere e l’eterea intensità dei miei sogni erano pezzi di un puzzle perfettamente combacianti, ma la cerniera tra le due tessere era tutt’altro che netta: le immagini si muovevano dall’una all’altra parte, scavalcando un limite convenzionale e dunque vano.
«Devi farti vedere da qualcuno», mi disse una mattina Benedetta con il tono che usava per gestire i suoi dipendenti (non quello di chi ordina, ma quello di chi dispone: l’ordine lascia pur sempre un margine ai ribelli). Semiaddormentato, mi aveva trascinato dal letto in cucina, e seduto di fronte a lei, sbocconcellavo biscotti con gli occhi ancora polverosi di sonno. Era vestita e pettinata, pronta per andare in ufficio, ma doveva essersi ricavata un po’ di tempo per farmi un discorsetto.
«Guardare da chi?» Biascicai.
«Da un medico, da uno psichiatra, non lo so… Da qualcuno che ti possa guarire».
«Non sono sicuro di essere malato». Afferrai un altro biscotto. Benedetta pensava che fossi sonnambulo, o per lo meno che nelle mie notti agitate fossi così confuso da compiere atti di autolesionismo, mentre lei dormiva protetta dalle sua palpebre carnose. La fatica di quei sogni spiegava, secondo lei, le visioni che mi turbavano da sveglio. Era una teoria come un’altra. Afferrai un altro biscotto.
«Vuoi andare avanti così? Vuoi vivere una vita così come… come un pazzo?»
Lei cominciava a irritarsi e perse completamente le staffe quando improvvisamente scoppiai a ridere. Il fatto è che i denti avevano iniziato a caderle via dalla bocca, uno dopo l’altro. Prima l’incisivo centrale destro, poi il canino sinistro, poi quelli anteriori dell’arcata in basso, e via via gli altri, molari compresi. In pochi minuti le labbra le si arricciarono sulla bocca svuotata.
«Ti stanno cadendo tutti i denti», le dissi per rispondere al suo stupore.
«Sei pazzo!», urlò alzandosi.
«E tu sei vecchia», risposi io ridendo più forte, ma poi cercai di calmarla in qualche modo: «È solo un sogno», le dissi. Questo non la calmò.
«Non hai più limiti», urlò, «non vedi più il limite».
I denti ricominciarono a spuntarle nella bocca, ma questo non bastò per farla sembrare meno vecchia e iniziai a provare pena per lei. Mi vennero in mente le notti in cui, anni prima, si era sistemata a cavalcioni su di me, pelle contro pelle, strusciando i suoi fianchi sui miei nel tentativo di rimanere incinta. Non ci riuscì. Non ci riuscimmo. Lasciai perdere la colazione e mi avvicinai; le feci una carezza, ma lei si scansò, come se in quelle circostanze lo ritenesse un gesto inopportuno. Passai il resto della giornata con il magone, ignorando la bufera che imperversò sulla città fino a sera. Un vento feroce trascinò sull’asfalto i platani, riempì le strade d’acqua melmosa, scoperchiò le case, strappò uomini e cose al dominio della terra, facendoli roteare come stracci di tela nel cielo incupito dalla pioggia. Arrivai a casa fradicio e distrutto. Benedetta dormiva già, il respiro leggero leggero, come sempre, quasi impercettibile. Mi sedetti sul letto accanto a lei, accarezzandole i capelli. Dormiva supina, le braccia sopra la testa come fanno i neonati; gli occhi si muovevano freneticamente sotto le palpebre spesse. Adesso mi sembrava già vecchia e ancora giovane a un tempo. Forse era vero che avevo perso la capacità di individuare i confini che separavano le cose. Avrei voluto svegliarla e chiederle di spogliarsi, salire ancora a cavalcioni sopra di me, strusciare la sua pelle sulla mia, ruotare gli occhi indietro, graffiarmi i muscoli del petto, invece non feci altro che sdraiarmi su di lei, la mia pancia sulla sua, stringendola forte con le braccia mentre la sentivo mugolare e contorcersi. Mi addormentai così e trascorsi la prima notte senza sogni dopo tanto tempo.
Quando mi svegliai Benedetta dormiva ancora, il fiato giù in gola come se non respirasse affatto. Dormiva anche quando tornai dal lavoro. C’erano due poliziotti accanto al letto, un medico legale e tre uomini in tuta arancione. Gli agenti mi misero le manette ai polsi e mi portarono via. Passai un periodo indefinibile in una cella le cui pareti si scioglievano ogni notte, colando su loro stesse come muri di fango. Quando il legale che mi assisteva chiese l’infermità mentale mi opposi urlando in mezzo all’aula che ero sanissimo; la cosa, scoprii più tardi, ottenne l’effetto opposto a quello che speravo, spingendo il giudice ad accettare l’istanza.
Ora vivo in una clinica di campagna. È una villa dalle pareti bianche dove gli infermieri si muovono lenti, a passi felpati. Tutti parlano a voce bassa, come se i suoni fossero lame capaci di ferire. Si sta bene, se si riesce a sopportare la noia: sembra di essere rimasti intrappolati in uno di quegli interminabili pomeriggi invernali che si passano in casa sbuffando, con la testa pesante. Io trascorro il tempo in giardino, osservando l’acqua ferma del lago che si stende lucente di fronte alla villa. Gli infermieri mi dicono che non devo oltrepassare il recinto tra il cortile e la spiaggetta, ma io questo confine non sono ancora riuscito a individuarlo. Comincio a pensare che sia proprio per questo che mi sono messo nei pasticci, perché non ho mai saputo riconoscere la differenza tra le cose: la vita e la morte, il prima e il dopo, il possibile e ciò che possibile non è. Spero di rivedere mia moglie, un giorno, ma so anche che non la rivedrò mai più: sono pensieri che si muovono indipendenti nella mia testa, ma quando si incontrano stridono come il gesso sulla lavagna, e rischiano di farmi impazzire sul serio. Strizzo gli occhi e mi tocco le tempie, allora, e mi sistemo sulla sdraio proprio davanti al lago. Porto scarpe bianche, senza lacci. Le sfilo e cerco di concentrarmi sull’acqua che si increspa. In pochi minuti sono di nuovo io, e sento di star bene. Mostri marini si sollevano dal lago, fissandomi con occhi come biglie di vetro. Forse si chiedono se esisto davvero.
Federico Leoni è nato a Roma nel 1977. Giornalista, è caporedattore di Sky Tg24. Collabora con periodici e siti web di cultura e informazione. Nel 2008 ha pubblicato con Utet John McCain. Tutte le guerre di Maverick. Nel 2013 è uscito il suo primo romanzo, Starry Night (Ensemble).