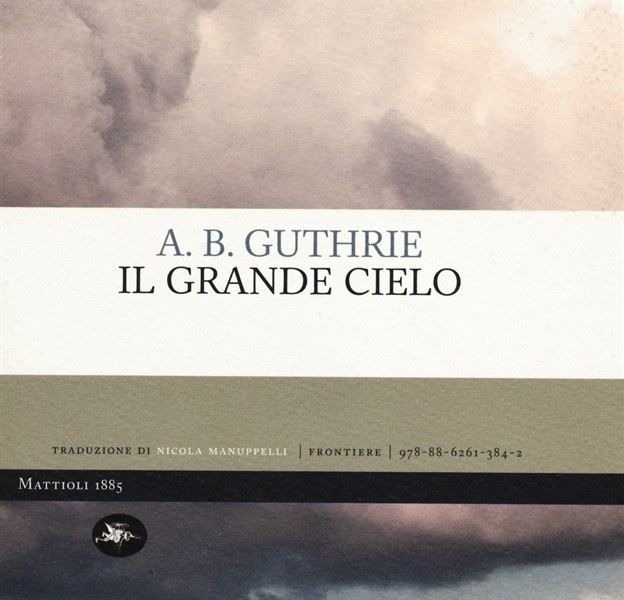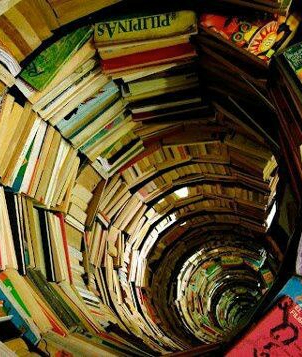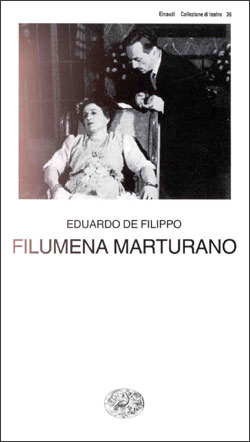Nei giorni immediatamente precedenti a quest’ultimo Natale si è creata una situazione di tensione diplomatica a dir poco particolare che ha coinvolto una potentissima multinazionale giapponese, la Sony, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica democratica del popolo di Corea, comunemente definita Corea del Nord.
Alla fine di novembre, un gruppo di hacker che si fa chiamare Guardians of Peace si è introdotto nel sistema informatico della Sony entrando in possesso di una serie di informazioni riservate, dati personali e materiale ancora protetto da esclusiva. La Sony, per il gruppo di pirati informatici, sarebbe responsabile di un «atto di guerra e di terrore» nei confronti della Corea del Nord e gli Stati Uniti sarebbero loro complici. C’è chi ha detto che il gruppo di hacker provenisse dalla Cina e che fosse stato ingaggiato e indirizzato dal governo di Pyongyang.
Quello che rende l’intera vicenda surreale (a dir poco) è che l’attacco bellico di cui hanno parlato i Guardians of Peace non è altro che un film, e non un film di denuncia, o un documentario, ma una commedia dal forte connotato demenziale. Si tratta di The Interview, scritto, diretto e prodotto da Evan Goldberg e Seth Rogen, che insieme avevano già ideato Facciamola finita, in cui un gruppo di celebrità doveva affrontare l’Apocalisse, e scritto una serie di film di discreto successo (Suxbad, Strafumati, Molto incinta). Il punto è che The Interview immagina un tentativo organizzato dalla CIA di uccidere Kim Jong-un, il supremo leader nordcoreano, e questo per Pyongyang è imperdonabile.
Già a giugno scorso il governo della Corea del Nord aveva annunciato ritorsioni in caso di distribuzione del film. La Sony e la sua controllata Columbia avevano comunque fissato la data di uscita del film per il giorno di Natale. Poi sono arrivati gli attacchi informatici, che di fatto hanno rilasciato sulla rete una serie di informazioni riservate della Sony, di mail personali con giudizi poco lusinghieri sulle star di Hollywood e di film non ancora distribuiti in sala (si parla di Sony Leak). La Corea del Nord non ha mai riconosciuto la paternità diretta dell’incursione, anche se la CIA – quella vera – ha parlato di un chiaro collegamento. Sono seguite minacce ulteriori di azioni «stile 11 settembre» contro i cinema che avrebbero proiettato il film. La conclusione è stata che, a circa una settimana dall’uscita, la Sony ha deciso di annullare la distribuzione di The Interview per paura delle conseguenze.
Sono seguiti giorni di furibonde reazioni di personaggi del cinema e della tv statunitense via internet che hanno twittato in difesa della libertà e del diritto di esprimere qualsiasi opinione, in qualsiasi forma e contro chiunque. Il presidente Obama, addirittura, è intervenuto sulla questione suggerendo che la Sony avesse sbagliato a ritirare il film. C’è stata una riscossa patriottica contro il terrorismo e anche solo la sua possibile minaccia (fonti di intelligence hanno assicurato che la Corea del Nord non sarebbe assolutamente in grado di compiere azioni miliari, o di guerriglia, in paesi stranieri) e alla fine è arrivata la decisione di cambiare nuovamente idea: The Interview è uscito in anteprima il 23 dicembre in duecento sale degli Stati Uniti. Goldberg e Rogen hanno partecipato a una proiezione a Los Angeles in un delirio di pubblico. Il film è stato distribuito on demand su una serie di piattaforme web a pagamento, in tutto il mondo. Insomma, si è passati dalla possibilità di non vedere mai il film a quella di poterlo vedere in ogni modo. E oltretutto non è successo niente: nessun attacco terroristico, nessuna ritorsione degli hacker, neanche una nota dal governo nordcoreano. L’unica conseguenza che c’è stata è che The Interview sta registrando incassi ben superiori alle aspettative.

Rimane da chiedersi solo una cosa: com’è questo film che ha rischiato di far scoppiare una guerra? Brutto.
L’intervista del titolo è quella che David Skylark (James Franco), conduttore di un talk show scandalistico, ha l’opportunità di realizzare con il supremo leader. Ad accompagnarlo in Corea sarà Aaron Rappaport (lo stesso Seth Rogen), suo produttore, braccio destro e miglior amico. Prima della partenza, però, un’agente della CIA affida ai due l’incarico di far fuori il dittatore usando un veleno che simula una morte naturale. Ci saranno disastri, inganni e una lunga serie di contrattempi.
Di base, The Interview è una bromance (da bro, diminutivo di brother, fratello, e romance, storia d’amore) con momenti di parodia del cinema d’azione e di spionaggio. Si inserisce nel filone sempre più ricco della commedia demenziale statunitense basata sul turpiloquio e l’allusione sessuale che ha nella coppia Rogen-Goldberg uno dei suoi punti centrali (un altro è Judd Apatow). Facciamola finita del 2013 era stato quasi una summa del genere in cui si erano radunati tutti i suoi principali esponenti davanti e dietro la macchina da presa. È un cinema che si basa su una comicità infantile, cretina a tratti, basata su un immaginario da maschi adolescenti che gioca sempre con il limite del cattivo gusto. Quando è fatta bene, funziona, fa ridere. Quando non è fatta bene, invece, mostra tutti i limiti di un mondo di masturbazione, falloforie e rumori intestinali. Ecco, The Interview è uno di quei film non venuti bene e in cui i limiti si vedono tutti.
L’ironia si fonda su due concetti: uno è l’honeypot. Letteralmente vaso del miele, in gergo informatico l’honeypot è un’esca usata come sistema di difesa contro i pirati informatici (guarda caso). In un slang più di strada, invece, honeypot è uno dei tanti nomi della vagina. Ogni volta che in The Interview compare una donna sta provando a fare una honeypot su uno dei due protagonisti, quindi lo sta attraendo verso una possibile conclusione sessuale per sfruttarlo. Se, invece, l’inganno è tra uomini parlano di honeydick. L’altro punto centrale è l’ano, che viene chiamato in causa già nei minuti iniziali e torna parecchie volte, e non c’è bisogno di aggiungere altro. Poi ci sono battute discriminatorie verso gli asiatici, gli omosessuali e gli ebrei, apparizioni di molte star della musica (Eminem), del cinema e della televisione statunitense, un carro armato, le canzoni di Katy Perry come metafora della libertà individuale, il rapporto padre-figlio e il peso delle aspettative. Della Corea del Nord si dice molto poco e quella di Kim Jong-un non è neanche una parodia, è solo una maschera, lo stereotipo del ragazzino viziato, solo e insicuro. Con la differenza che ha un arsenale atomico.
The Interview non funziona perché le battute sono ripetitive, perché James Franco, come giornalista cretino e ignorante, è eccessivamente sopra le righe e decisamente poco credibile, perché c’è un precedente, Team America: World Police, dei creatori di South Park Trey Parker e Matt Stone, in cui deve essere ucciso il padre, di Kim Jon-un, Kim Jong-il, e quel precedente graffia molto di più, sia la dittatura che la democrazia statunitense, e soprattutto il film di Rogen e Goldberg non funziona perché non fa ridere praticamente mai, perché ha una trama sfilacciata e debole che serve solo come contenitore per le gag dei due protagonisti.
Un po’ poco per far scoppiare una guerra.