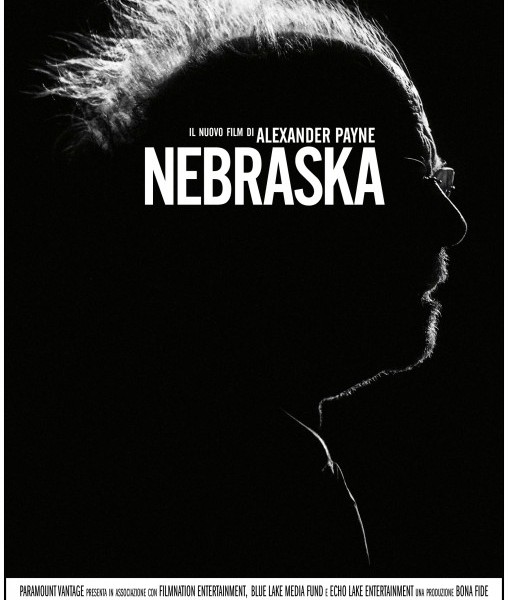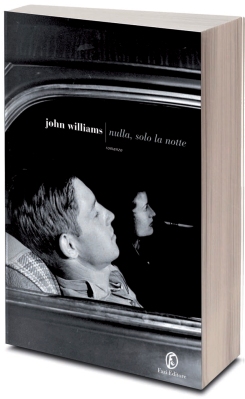L’iperbole veloce e rocambolesca di una promessa del calcio, che tale sarà per sempre. Dal talento che emerge disordinato, sino all’incanalamento in un mondo che lascia sempre meno spazio all’improvvisazione. Claudio Grattacaso, nel suo esordio letterario, racconta con La Linea di fondo (Nutrimenti, 2014), l’alba, la vita e il tramonto di un sogno infranto, non solo professionale.
José Pagliara, in arte Freccia, è un giovane calciatore di belle speranze. Ha talento, e il suo nome circola con rispetto già su tutti i campetti polverosi della sua città.
Attorno a lui si muove un colorato manipolo di amici, che diverranno in pochissimi casi di lunga data; immancabile, inoltre, il primo amore. Corre veloce, Freccia, con le idee chiare e quell’aura d’invincibilità propria dell’adolescenza.
Al passato, molto più colorato e sereno, in un sud riconoscibile ma appena accennato, l’autore contrappone in modo diametralmente opposto un tempo più recente, fatto di silenzi e nebbie, proprie del grande nord, dove tutto sembra impercettibile e riflessivo.
Nel mezzo, l’evento doloroso di una perdita, la fine dell’infanzia, delle belle giornate trascorse a dare calci a un pallone, il ricordo delle feste, del bel tempo dell’innamoramento; poi l’età adulta, improvvisa, che ha che ha visto sgretolarsi una dopo l’altra le attese alle quali è stato sempre più difficile dare conferma: «Il destino sceglieva al mio posto, mi rendeva impotente, decideva lui a che angolo svoltare».
L’estro, e le devastanti falcate di Freccia, trovano così il loro stop nel peggiore dei modi, con un brutto infortunio che condizionerà inevitabilmente tutta la sua carriera. Ma peggior sorte gli toccherà quando sarà costretto a ritrovarsi solo e inascoltato, di fronte al fuoco incessante di poteri criminali, sempre più presenti nel pianeta calcio, ormai consegnato al denaro. La vicenda si fonde dunque con la realtà e ritornano in mente gli anni bui del calcioscommesse, che mai si è riusciti a debellare totalmente, e che invece sembra persistere in maniera ancor più consistente nelle serie minori, sui campi di provincia, dove l’attenzione mediatica non è quella dei grandi palcoscenici. Altro fattore di cui Grattacaso si occupa, seppur di sfuggita per ovvi motivi, è il doping e le sue conseguenze; nel calcio, a differenza del ciclismo, non è mai esplosa una vera e propria bolla doping, forse per tranquillizzare le masse e blindare così gli investimenti attraverso un penoso silenzio. Eppure, è un argomento che ha sempre aleggiato nelle discussione da bar, nel sottobosco di un calcio che fa sempre più fatica a restare soltanto un gioco: «Basta vedere un filmato d’epoca per rendersi conto di quanto siano differenti da come eravamo noi. Grandi il doppio, cattivi il triplo, resistenti il quadruplo. Mi chiedo che sostanze assumano per essere così». Ma gli addetti ai lavori, marionette di ben altri poteri, liquiderebbero la faccenda chiamando in causa le tre partite a settimana, il calcio moderno, l’evoluzionismo.
Oltre alla carriera spezzata, Freccia è costretto a interfacciarsi con ulteriori difficoltà da dribblare, questa volta tra le mura domestiche: la malattia di una moglie troppo debole per sopportare le angherie e le cattiverie, e una figlia che vuol smettere d’esser tale.
Freccia arriva alla fine del suo percorso con lo stoicismo dei vecchi calciatori, prendendo coscienza del tempo trascorso, ricco di disillusioni, e di un tempo ancora da vivere. Arriva così alla linea di fondo, alla fine del campo, dove tutto sembra finire se non hai più voglia di inseguire la palla, magari per rimetterla al centro, dove finisce l’erba e cominciano gli spogliatoi: «…era tempo di rimanere immobili e vederla perdersi oltre la linea di fondo».
(Claudio Grattacaso, La linea di fondo, Nutrimenti, 2014, pp. 256, euro 16)