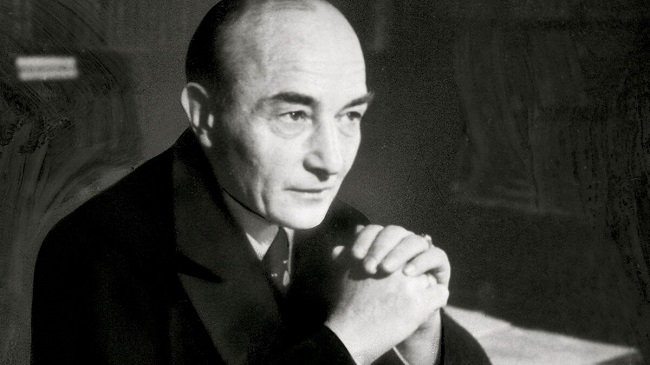«Now TV isn’t one that I watched five hours straight, but a movie is the one that I don’t turn on because it’s two hours. I don’t want to be in front of my TV for two hours I want to be in front of the TV for one hour five times».
Tina Fey e Amy Poehler, monologo di apertura ai Golden Globe 2021.
Quando Amy Poehler ha fatto questa battuta nel monologo iniziale della settantottesima edizione dei Golden Globe ho riso molto, ma soprattutto mi sono sentita chiamata in causa e stranamente compresa. Spesso, nelle serate infinite e tutte uguali che quest’ultimo anno ha saputo regalarci, mi sono trovata davanti alla smart tv, telecomando in mano, indecisa non solo su che cosa guardare, ma addirittura su che icona di un servizio d’intrattenimento cliccare per cominciare a cercare. L’unica mia certezza era che non avevo voglia di vedere un film, di impegnarmi per conoscere da zero un personaggio, affezionarmici e poi lasciarlo andare nell’arco di due ore. Avevo voglia di riprendere uno dei personaggi che già conoscevo, e vedere come andava avanti la sua storia. Avevo voglia di una serie tv.
Nell’ultimo ventennio, probabilmente, le serie tv sono diventate la principale fonte d’intrattenimento per il mondo occidentale. Più dello sport, più del cinema, più dei reality. E, ovviamente, più della vita fuori dallo schermo; in competizione, forse, solo con i social network.
Una parte così importante e pervasiva della vita di moltissimi di noi (sicuramente della mia) ha bisogno di essere analizzata con cura, in caso contrario rischieremmo di sminuire e perdere di vista l’influenza che questo tipo di narrazione ha sulla nostra società, contribuendo a costruire e mantenere i rapporti di forza al suo interno.
Marina Pierri ha pienamente ragione, dunque, quando dice che siamo immersi nelle storie delle serie tv e che le loro narrazioni ci aiutano a comprendere il reale, attraverso personaggi che escono dallo schermo e finiscono per guidarci nel nostro vissuto quotidiano. Per questo è da accogliere con entusiasmo il suo volume, Eroine. Come i personaggi delle serie tv possono aiutarci a fiorire (Tlon, 2020).
Il libro si propone di analizzare l’influenza della narrativa seriale sulla vita, cosciente e inconscia, delle donne che sullo schermo vedono agire altre donne, le seguono nella loro crescita, si immedesimano o provano empatia, e grazie a quello che vedono scoprono qualcosa su loro stesse, e sul loro viaggio. Per farlo, Pierri si concentra sulle serie tv e sui personaggi degli anni Dieci appena conclusi per fotografare e raccontare il presente, grazie a un’ampia conoscenza sia delle stesse serie tv, sia della letteratura filosofica, psicologica e narratologica, in particolare gli studi sul “viaggio dell’Eroe”. La sua analisi si sofferma in particolare sui personaggi-archetipo incarnati dalle Eroine, che si manifestano durante il viaggio narrativo e risuonano in noi che guardiamo.
Gli archetipi dell’Eroina hanno una carica universale: arrivano al singolo come immagini, rappresentano momenti e atteggiamenti femminili arcani, riconducibili alle figure della mitologia greca, e portano sulle spalle lo sviluppo della narrazione e la ricezione della narrazione stessa da parte dello spettatore, in un susseguirsi di stati incarnati e possibili per la donna. Per esempio, nel suo viaggio l’Eroina, dopo essere stata Guerriera come la Angela Abar di Watchman e Alex Levy (Jennifer Aniston) in The Morning Show, diventa Angelo Custode, rispecchiandosi in Mave, madre disperata che fa di tutto per ritrovare sua figlia in Westworld, e nella combattiva ma accogliente Ruth di Glow. Ed ecco quindi l’identificazione: «La Guerriera ha bisogno di riposare. La integriamo all’Angelo Custode quando combattiamo la misoginia online degli psicologi e dei sociologi da strapazzo; quando rivendichiamo la validità e l’amore nei confronti dei nostri corpi non conformi; quando ci schieriamo con un’altra donna in una discussione dove impera il mansplaining; quando ricopriamo un ruolo di potere e ci adoperiamo affinché anche ad altre donne, diverse da noi, vengano offerte delle possibilità per farsi strada».
Uno dei grandi pregi di questo libro, quello che più me lo ha fatto amare, è che pur raccontando storie diverse, ciascuna delle quali nasce da idee, immaginazioni e fantasie di moltissime persone diverse (showrunner, sceneggiatrici e sceneggiatori, registe e registi, ecc.), l’analisi di Pierri è riuscita a penetrare nel profondo della mia storia personale, e a farmi sentire compresa. Pensando a Fleebag, Kimmy Scmidth, Nadia Vulvokov, Miriam Masel, Raffaella Cerullo, Jane Villanueva e altre Eroine in questa chiave, ho conosciuto meglio me stessa e alcune fasi del mio percorso di crescita personale.
Il personaggio di una serie tv è una porta attraverso la quale chi guarda può accedere a elementi archetipici capaci di agire sulla sua mente, sulla sua sensibilità e sul suo vissuto. Pierri riflette su come alcune serie tv si smarchino dal paradigma classico, pienamente immerso nella cultura patriarcale, del viaggio dell’Eroe, creando nuovi archetipi che prendono vita e si rivolgono al mondo femminile. Ne nasce un testo profondamente femminista e militante, che aiuta a immaginare e costruire una società paritaria. Il viaggio di distruzione e coscienza di sé dell’Eroina, che per progredire deve necessariamente confrontarsi con i limiti e le imposizioni di una società che la considera inferiore, che la cancella e le impone standard impersonali e violenti, è lo stesso che noi donne che leggiamo sentiamo di dover fare, e sentiamo di stare facendo, anche se ognuna con il suo passo e la suo storia. Gli archetipi delle Eroine – i vari modi di essere in viaggio e di affermarsi – ci mostrano le possibili strade. E la strada andrà ripercorsa più volte, inciampando e ricominciando da capo dopo l’arrivo, ma ci porterà molto lontano.
Nelle parole dell’autrice: «Anche se Eroine è un libro femminista, il femminismo non è un pacchetto Office pronto per l’installazione. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo grazie alle donne che mi circondano. Se è vero che il fulcro del Viaggio dell’Eroina è il raggiungimento progressivo di una consapevolezza circa l’erosione interiorizzata del patriarcato, allora non ho finito di smantellare le impalcature obsolete che nascondono la facciata del mio palazzo in costruzione. La natura del Viaggio prevede che sia insieme finito e non finito. […] Ci si rimette in marcia, ogni volta più risolte, o almeno meno irrisolte di prima».
La rappresentazione, nelle storie, è esistenza sociale, e grazie a Eroine ogni lettrice potrà sentirsi viva e consapevole.