C’è una luce diversa nello sguardo di Jack stamattina. Si vede da com’è entrato in ufficio, da come ha sorriso quando ha centrato l’attaccapanni con la giacca e da come mi ha salutato, unendo pollice e indice e alzandoli alla bocca per invitarmi a bere un caffè. Qualcuno una volta ha detto che l’essere umano si abitua a tutto, eppure io dopo dieci anni non mi sono ancora abituato a questo caffè che sa di piscio. Non mi sono abituato all’odore del disinfettante. Non mi sono abituato alla morte.
Mentre lavoriamo, Jack ogni tanto butta un occhio al comunicato che qualcuno gli ha lasciato sulla sua scrivania, poi si accarezza l’ingessatura e sorride. Sono lì già da qualche giorno quelle lettere scritte con il pennarello verde sulla piega del suo gesso, vicino al gomito. Qui a McAlester la vita è sempre difficile, e ultimamente per Jack lo è ancora di più, e non solo per l’incidente in cui si è fratturato il radio. Per questo vederlo sorridere è strano.
Sul braccio ingessato di Jack c’è scritto «Richie», e la erre è calcata più delle altre lettere. Richie era poco più di un bambino quando ha ammazzato il suo patrigno; quindici anni e mezzo, troppo pochi persino per bere alcolici qui in Oklahoma, ma sufficienti per condannarti a morte. Una morte ingiusta che metterà fine a una vita ancora più ingiusta, perché più della metà di quei quindici anni e mezzo Richie li ha trascorsi pregando un dio che non l’ha mai ascoltato. Li ha trascorsi pregando una madre alcolizzata che s’infilava quel bastardo nel letto senza chiedersi perché quello di Richie, di letto, fosse così spesso macchiato di sangue. E un giorno, stanco di pregare, Richie ha imbracciato il fucile e gli ha sparato un colpo dritto in mezzo al petto, a quel bastardo che lo violentava tutte le notti.
Qui a McAlester la morte è di casa, perché non sono solo le iniezioni a uccidere; anche su di noi pende una condanna. Siamo condannati a morire lentamente, ogni giorno che passa, portando negli occhi i loro ultimi passi, i loro ultimi sguardi, occhi talmente stanchi che non hanno nemmeno più la forza di chiedere giustizia.
Siamo condannati a sperare fino all’ultimo di vederli tornare indietro, ripercorrendo gli stessi passi, con sguardi diversi, con occhi diversi.
Siamo condannati a renderci conto che nessuno torna mai indietro. Nemmeno gli innocenti. Nemmeno quelli che sono colpevoli solo di non essersi rassegnati a una vita di merda. Quelli che hanno provato a cambiarla, quella vita di merda. Quelli come Richie.
E allora ti metti alla tua scrivania, davanti al tuo computer, e compili il tuo file con l’ennesimo nome di quell’ennesimo nessuno. È così che capisci quanto vale una vita: pochi passi, un’iniezione, un nome su un registro elettronico. E dieci minuti dopo nessuno si ricorda più di te, di chi sei stato, di chi saresti potuto essere se ci fosse stata un’altra giustizia.
E Jack non lotta più. Ormai è abituato a sedersi accanto alla morte, eppure con Richie è diverso. Loro hanno sempre avuto un legame speciale, forse perché sono entrati a McAlester insieme, diciassette anni fa. Forse perché Richie con quegli occhi grandi e quei capelli rossi gli ricorda suo figlio David. O magari perché Jack, nonostante si sia sempre dichiarato un fedele servitore del suo paese, si vergogna di rappresentare uno Stato che non vede che Richie è solo un ragazzino a cui è stata tolta la possibilità di diventare un uomo.
Ma oggi Jack sorride, e ormai ho imparato che se Jack sorride c’è un motivo valido. Forse dopo anni di appelli è finalmente arrivata la commutazione della pena per quel povero ragazzo, la cui unica colpa è di essere nato da una madre degenere.
E sul comunicato che giace sotto il gomito buono di Jack c’è scritto che la condanna a morte di Richard Evans, fissata per il 4 febbraio prossimo, è stata annullata. Jack sorride. Non dovrà mai fare quegli ultimi passi a fianco di Richie, non dovrà guardare la rassegnazione nei suoi occhi, non dovrà mai sperare di vederlo tornare indietro, non dovrà mai aprire quel maledetto file e compilare quel maledetto registro di morte con il suo nome. Perché Richie è morto, stanotte. Un infarto se l’è portato via, a trentatré anni.
La legge della natura è più giusta di quella dello stato di Oklahoma. E Jack lo sa, per questo sorride.

“Ultimo Parallelo” di Filippo Tuena
«Il libro più aspro che ho mai scritto. Soltanto apparentemente è il resoconto di un’esplorazione polare. Disorientamento, distruzione, fallimento».
Con queste parole Filippo Tuena sintetizza Ultimo parallelo, uno dei suoi migliori romanzi (Premio Viareggio 2007), pubblicato per la prima volta da Rizzoli nel 2007 e ora riscoperto da Il Saggiatore con una nuova edizione.
La storia che Tuena racconta è nota e terribile. Nell’assoluta solitudine dell’Antartide quattro uomini guidati dal capitano Robert Scott immolano il proprio corpo e il proprio spirito nel tentativo di raggiungere la loro illusione, il polo sud – luogo reale per convenzione –, dove piantare la bandiera della gloriosa Gran Bretagna. Ma già a pochi chilometri dalla meta capiscono di essere stati preceduti dalla spedizione rivale del norvegese Roald Amundsen. Sfaldati dall’atroce delusione, Scott e i suoi compagni sono destinati a pagare l’impietoso contraccolpo della sconfitta nel peggiore dei modi. Durante il viaggio di ritorno, vinti dalla stanchezza e dal freddo, si consumano inesorabilmente. I loro corpi verranno ritrovati mesi dopo, insieme ai diari e a una macchina fotografica, tutto ciò che resta del tragico fallimento.
Testimone onnipresente della dolorosa missione è l’«uomo in più», un oscuro miraggio, l’evanescente presenza percepita dagli esausti esploratori, resi ciechi dal riverbero della luce sulla neve. Di lui ce ne accennano i diari, di lui T.S. Elliot ne fa poesia in The Waste Land. Come una premonizione nefasta affianca i cinque inglesi, vaglia la loro forza e il loro istinto di sopravvivenza, prende atto delle scelte errate che porteranno all’annientamento finale delle loro esistenze.
Attraverso un magistrale lavoro di tessitura del dato reale con l’elemento di fantasia, Filippo Tuena riesce a costruire un romanzo corale in cui la voce del misterioso accompagnatore – un artificio narrativo di grande effetto – si alterna alle parole vive e strazianti dei membri della spedizione. E sembra proprio di vederli, allora, Scott, Bowers, Oates, Wilson e Evans, mentre soccombono, sopraffatti dalla delusione e dalle intemperie, con l’eroica sottomissione propria dell’essere primordiale.
Ultimo parallelo è, dunque, una feroce rappresentazione della fragilità dell’uomo e delle sue illusioni. Un libro che si imprime nelle ossa come il gelo artico, che disorienta come una sconfitta definitiva, che commuove come un addio forzato, entrando di diritto nel canone della letteratura italiana contemporanea.
(Filippo Tuena, Ultimo parallelo, Il Saggiatore, 2013, pp. 296, euro 15)
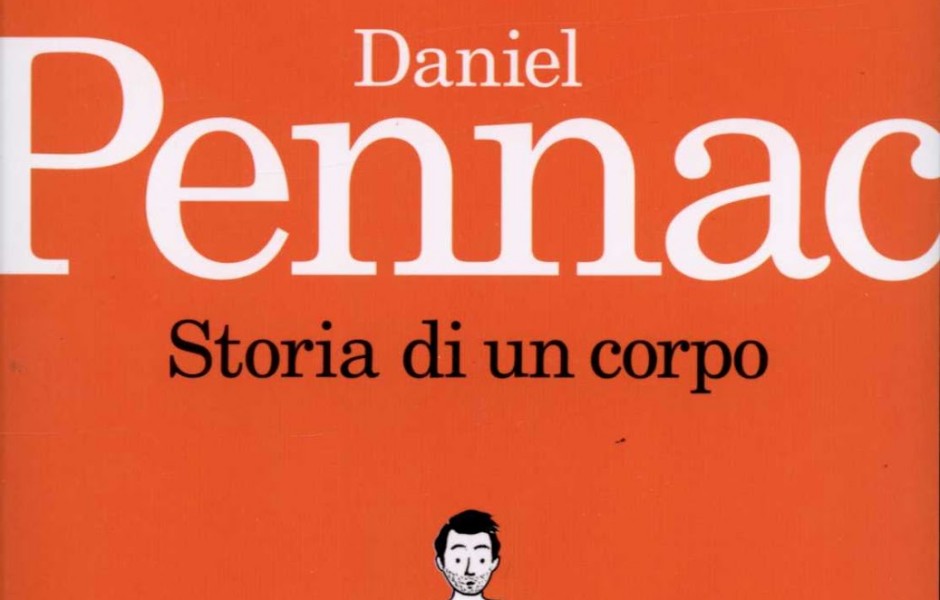
“Storia di un corpo” di Daniel Pennac
A dieci anni dal suo ultimo romanzo, Daniel Pennac torna con Storia di un corpo (Feltrinelli, 2012).
Il protagonista, dodicenne, dopo un episodio in cui la paura fa reagire il suo corpo come non si sarebbe aspettato, creando una dissociazione tra il fisico e la mente, si propone di tenere il diario del suo corpo. Sarà l’inizio di un processo di ricerca e scoperta che, quaderno dopo quaderno, lo accompagnerà fino alla morte. Il ragazzino emarginato delle prime pagine si trasforma rapidamente, sotto gli occhi del lettore, in adolescente, giovane uomo, marito, persona di mezz’età, fino al raggiungimento della vecchiaia. L’esistenza fluisce, rapida e inarrestabile, attraverso una costante ricerca tesa alla conoscenza dei meccanismi e dei cambiamenti del corpo, in un viaggio intimo e realista che raccoglie il tentativo di superare l’eterno conflitto fra il corpo e l’anima. Il corpicino esile del dodicenne che comincia ad annotare le reazioni della sua fisicità rispetto a quello che lo circonda, fino a diventare corpo consumato di un anziano alla soglia dei novant’anni, concentra su di sé le vicende umane che lo caratterizzano, offrendo una prospettiva materialistica, reale, sui moti dell’anima; il corpo accompagna la mente per tutta la vita e insieme a essa cambia, stagione dopo stagione, sfuggendo spesso alla governabilità.
L’intensità delle emozioni si imprime inesorabile sul corpo, plasmandolo. Attraverso una grande lente tutta fatta di carne, muscoli, sangue e ossa, scorre davanti a noi un carrello vitale che passa per la pubertà, la scoperta sessuale, l’innamoramento, la paternità; un carrello che rovescia, tramite la stessa lente, l’individualità del corpo quando il protagonista, prima padre e poi nonno, potrà trasmettere il frutto della sua ricerca a figli e nipoti. Tutto avviene in maniera completamente cruda, senza lasciare spazio a descrizioni emozionali astratte; i turbamenti, le insicurezze, le esperienze sono raccontati impiegando l’uso dei cinque sensi e del loro impatto sul corpo: odori, profumi, secrezioni, sensazioni tattili, immagini, suoni, si uniscono in un amalgama fino a diventare fotografia unica.
Daniel Pennac, con il suo ultimo romanzo, offre una visione allo stesso tempo nuda e delicata del rapporto che siamo costretti ad avere con il nostro involucro, trattando in maniera originale ed efficace quello che sembra essere uno degli ultimi tabù della nostra società: il corpo. Lo fa in un percorso che conduce la giovinezza mentale insieme alla compattezza delle membra fino all’inevitabile declino di un’interiorità scheggiata sempre più in profondità dalla malattia e dal lutto. Il libro si chiude su un esausto ottantasettenne, stremato dal peso della propria penna, il quale lascia la sua testimonianza alla figlia e si prepara a morire, insieme al fratellino immaginario che aveva inventato da bambino nel tentativo di lenire le sue paure e solitudini.
(Daniel Pennac, Storia di un corpo, trad. di Yasmina Melaouah, Feltrinelli, 2012, pp. 341, euro 18)

“Spring breakers – Una vacanza da sballo” di Harmony Korine
Bastano i pochi minuti della sequenza iniziale del party alcolico in spiaggia per avere il quadro completo dell’estetica da videoclip di Spring breakers – Una vacanza da sballo, di Harmony Korine, già presentato con un buon successo lo scorso settembre a Venezia.
Quattro amiche poco più che adolescenti decidono di lasciare il campus deserto per raggiungere la Florida per lo spring break, la vacanza di primavera dei college statunitensi. Il desiderio è uno solo: andare a divertirsi. I soldi che hanno non bastano, per cui decidono di rapinare una tavola calda armate di martello e pistole ad acqua. Ci riescono. Ora hanno i soldi, partono. Iniziano le feste, la droga, i ragazzi. Finiscono anche in carcere, in costume da bagno, per un blitz della polizia durante un festino in cui si consuma cocaina su corpi nudi. Devono pagare una multa o rimanere dentro per un paio di giorni. A tirarle fuori ci pensa Alien, un gangsta-rapper bianco che morde la vita con i denti d’acciaio che si è fatto impiantare, spaccia droga, colleziona armi e sogna una vita alla Tony Montana. Le feste riprendono ma sono un po’ diverse; meno studenti e più criminali. A una di loro non sta bene e se ne torna a casa col pullman. Le altre rimangono e si lasciano coinvolgere, complici consapevoli, in un gioco sempre più grande di rapine e sparatorie.
L’idea del film è nata da un’immagine: ragazze armate in bikini. Questo è lo spunto da cui è partito Harmony Korine per realizzare il suo primo film con un budget medio-alto. Si è limitato ad aggiungere ben poco all’immagine di partenza, in verità. Dopo aver esplorato nei suoi film precedenti (Gummo, Julien Donkey-Boy, le scritture per Larry Clarke di Kids e Ken Park) il white trash degli Stati Uniti, Korine sposta lo sguardo dalla provincia grottesca e arcaica verso i più rassicuranti climi della Florida, lasciando da parte i freaks per concentrarsi su una gioventù spensieratamente allo sbando.
La furbizia dell’operazione è tutta nel prendere due stelline Disney come Selena Gomez e Vanessa Hudgens, spogliarle e calarle dal mondo dorato delle favole nello squallore alcolico del vizio, mettere accanto a loro un attore di tendenza come James Franco, mascherato quel tanto che basta per creare curiosità, e affidare la colonna sonora a un idolo dei giovanissimi come Skrillex. Aggiungendoci il sesso, ostentato più che mostrato, i dialoghi al limite del banale propri dell’adolescenza, una fotografia che esaspera i colori, un montaggio frenetico nel procedere rapsodicamente tra anticipazioni e recuperi, si ha pronto un film perfetto per risultare alternativamente provocatorio e innovativo e convincere qualcuno a ritenerlo un affresco veritiero, seppur esasperato, di quel mondo in cui libertà e licenza si confondono e che per molti è l’unica realtà e l’unico Eden verso cui aspirare.
Non è così: il vuoto che si intravede tra le carni in mostra non è quello delle coscienze, è quello della sceneggiatura. Rimanendo sulla superficie del sociale, senza problematizzare, limitandosi a mostrare senza indagare, Korine mette in scena un accrocco di colori che vuole essere un’esperienza sensoriale unica e coinvolgente ma risulta invece un ripetere ostentativo di sordidezze (alcune filmate in autentici spring break) e cliché narrativi (sequenze in ralenti, voice over retoriche e ridondanti). Nella mostra delle atrocità non c’è condanna, neanche ironica, neanche quando le ragazze azzardano una coreografia armata sulle note di “Everytime” di Britney Spears suonata al piano, al tramonto, col mare sullo sfondo, da Alien/Franco.
«Bikini e bei culi e la vita si trasforma in uno sballo» e «Il sogno americano è solo fare soldi e io ce l’ho fatta» sono le frasi che ripete Alien alle ragazze e che passano come manifesto di un film che ammicca con malizia ai videogames e a Miami Vice, tra eccessi e cultura pop. Non c’è giudizio per le azioni delle protagoniste: i loro delitti sono senza castigo, nella pausa di primavera tutto è permesso, tutto è giustificabile. Questo è l’unico messaggio che emerge dalle immagini che il regista lascia parlare come unico arbitro.
(Spring breakers – Una vacanza da sballo, di Harmony Korine, 2012, Commedia/Drammatico, 92’)

“The bridge”: a tu per tu con gli almanoir
Abbiamo intervistato gli almanoir, uno dei gruppi che suoneranno alla serata di musica dal vivo organizzata da Flanerí martedì 12 marzo presso Contestaccio. Ecco che cosa ci hanno detto.
Raccontateci brevemente la nascita della band, che ha visto confluire al suo interno varie esperienze.
Ci siamo conosciuti tutti presso la scuola di musica dove studiavamo. Suonando insieme all’interno dei laboratori abbiamo iniziato ad avvertire un certo feeling. Io (Maristella) mi dilettavo a scrivere e avevo un po’ di canzoni nel cassetto, così un bel giorno ho proposto loro di arrangiarle e da lì è nato tutto.
Da quali suggestioni è nato il nome del gruppo?
Ci siamo arrovellati il cervello per mesi, quasi tutti i nomi che ci piacevano già esistevano e noi volevamo ovviamente essere gli unici al mondo. Alma è una parola dai diversi significati: in spagnolo significa anima, ma deriva dal latino almus che significa “che nutre”. Ci piaceva perché racchiudeva in sé il senso che noi diamo alla musica. Noir, è il nero, la somma di tutti i colori, la somma di tutti i nostri colori.
La scelta dell’inglese: spontanea o un mezzo per esaltare il cantato e la melodia?
Un po’ tutte e due. In realtà inizialmente i brani erano anche in italiano, ma poi, quasi senza accorgercene, l’inglese ha preso il sopravvento. Ascoltando e ispirandoci per gran parte alla musica inglese e americana il passaggio è avvenuto in maniera naturale. L’inglese poi ha una caratteristica che amiamo molto, quella di lasciare molto spazio all’interpretazione, in quanto una stessa parola può avere significati anche molto diversi tra loro.
La scena musicale romana è un crogiolo costante e ampio di nuove band: come vi ponete di fronte a questo contesto?
Cerchiamo il più possibile di stabilire dei contatti con i gruppi che ci piacciono e che ci corrispondono di più, crediamo che creare una “rete” in questo senso sia il primo passo per promuovere e far ascoltare la musica originale e indipendente. Ma siamo anche competitivi, nel senso “sano” del termine. Il confronto ti spinge a migliorarti sempre per cercare di emergere, e per certi versi è il vero e proprio motore: vedere gli altri, ascoltarli, può essere uno specchio nel quale guardarsi e scorgere pregi e difetti anche di noi stessi.
Parliamo del vostro ep, The Bridge: quali esigenze e intenti sentite di aver sfogato al suo interno?
L’intento principale di questo primo EP era quello di raccontare i nostri primi due anni e mezzo di musica insieme: i brani scritti in questo periodo sono stati molti, ma abbiamo scelto questi cinque perché ben rappresentativi di ogni singola fase del nostro percorso. L’esigenza che avevamo era di mettere una sorta di punto, inteso non solo come fine di un periodo, ma anche e soprattutto come un nuovo inizio. In poche parole, attraversare il ponte.
Ho trovato molto riuscita la vostra sintesi tra momenti melodici e altri più rock: quali sono i vostri modelli musicali che credete di aver degnamente onorato in The Bridge?
Ci ispiriamo molto alla musica nord europea: Pink Floyd (che abbiamo voluto omaggiare anche nell’EP), Radiohead, Bjork, Sigur Ros, Porcupine Tree, ma anche Tori Amos, per quel che riguarda il versante americano. Se li abbiamo degnamente onorati non saprei, ma sicuramente c’è un po’ di loro in ognuno di noi.
C’è un tema ricorrente, o comunque un tratto marcante, che caratterizza i vostri brani e la vostra musica?
Un tema ricorrente può essere quello del cambiamento, inteso come continua tensione e passaggio tra stati d’animo positivi e negativi: c’è gioia solo se c’è stato dolore, c’è il bianco ma solo in contrapposizione con il nero. Il tratto marcante invece è l’elemento visivo: ci sono molte immagini nei nostri testi, molte metafore , e questo credo che emerga anche dalla musica stessa, dal nostro suono.
Si parla sempre della morte del cd e dell’egemonia di internet: qual è la posizione di una band agli esordi su questa situazione?
Internet è una grande risorsa, ti permette di essere ascoltato in ogni parte del mondo e questo ti apre la porta a infinite possibilità. Crediamo che vada sfruttato al massimo, i nostri brani sono già in streaming online e tra breve sarà possibile anche acquistarli in digitale. Il cd fisico però ha sempre il suo fascino, crediamo sia importante averlo e puntiamo molto alla vendita durante i concerti, più che a una vera e propria distribuzione.
Dopo The Bridge opterete per un vero e proprio album o pensate di dedicarvi all’attività live?
Per ora ci vogliamo divertire, suonare il più possibile, farci conoscere. Abbiamo altri brani in cantiere e l’attività di scrittura e composizione non si è mai fermata e mai si fermerà. L’album vero e proprio è sicuramente nei nostri progetti a lungo termine.
Ipotizziamo che questo disco sia una colonna sonora: di quale film vi piacerebbe che lo fosse?
Anche se ha già una colonna sonora pressoché perfetta, “Into the wild”.
Ultima domanda. Avete l’opportunità di scegliere un artista a cui aprire il live: quale sarebbe il vostro sogno?
Radiohead, senza ombra di dubbio.
Dodici Dita
Al saggio non può capitare niente di male.
È più forte di tutto ciò che lo circonda.
Lucio Anneo Seneca
Dodici Dita si guardò le mani. Aveva solo dieci dita, come tutti. Con calma e dedizione si abbandonò ai gesti automatici che lo avrebbero condotto a rimontare la sua vecchia pistola.
Per prima cosa, il popolo. Quella massa di esseri brulicanti che schiamazzavano nelle strade attorno a lui. Mercanti, artigiani, contadini… Vecchi e giovani, uomini e donne. Scendendo nello specifico qualcuno di loro poteva essere interessante, forse abbastanza da condividere con lui qualche pena, ma bastava salire un po’ più in alto sulla torre, allargare un po’ la visuale, defocalizzare, rifocalizzare, e cosa si otteneva? Marmaglia. Si può imparare a vedere tutto dall’alto, basta abbandonare ogni curiosità, e tradire la fantasia. Improvvisamente sono tutti uguali. Così li percepiva, Dodici Dita.
Dodici Dita incastrò velocemente tutti i pezzi dell’arma. Una serie di click lo rassicurò sul giusto posizionamento degli ingranaggi, ma non ce n’era bisogno. Aveva smontato e rimontato la pistola centinaia di volte, centinaia.
Il punto di vista delle pietre. Le pietre che lastricavano l’intera via erano state posizionate lì dai grandi re del passato, e avevano attraversato i secoli, in parte sepolte dalla terra, in parte spaccate dal tempo, in parte levigate dal continuo passaggio. Ognuna di quelle pietre era un testimone logoro dell’insignificanza dell’esistenza. Quante volte avranno ascoltato i discorsi delle persone che distrattamente le calpestavano? Discorsi sulla politica, sulla famiglia, sul bene e sul male, ogni volta pronunciati come se fossero cose importanti, fondamentali, addirittura cose vitali. Sorrise. Vitali, ma non per le pietre. Forse per quelle brevi esistenze. Secoli dopo qualcuno rifarà gli stessi discorsi, e le pietre restano lì, costrette a risentirli.
Spinse il cristallo nella canna. Energia luminosa si sprigionò dalle superfici lisce della scheggia vetrosa, prima che scomparisse nel buio del cilindro di essedreel. Senza quel cristallo, l’arma non avrebbe sparato. Il cristallo era il cuore dell’arma.
La via religiosa verso la salvezza. Alcuni religiosi si muovevano tra la folla, il corpo ammantato di vesti costose, nonché di sicurezze inventate. Lungo la strada incontravano altra gente, anime impaurite e riverenti, che elargivano sorrisi in cambio di benedizioni. Buone maniere in cambio di serenità. Non è male come scambio.
L’arma vibrò in maniera quasi impercettibile. Il metallo che assorbiva l’energia del cristallo. Dodici Dita infilò una mano in tasca e ne estrasse una manciata di proiettili, grossi pallettoni argentati. Un paio caddero a terra, scivolarono seguendo le spaccature nelle assi del pavimento e finirono per infilarsi sotto il mobilio spartano della stanza. Dodici Dita vuotò la mano in una ciotola di legno, su uno sgabello, vicino alla finestra.
La sordità alle grida del mondo, laceranti e stridule, acute e altissime, angoscianti e terribili. Perché le orecchie delle altre persone non sanguinavano? Dodici Dita lo sapeva. Perché erano nati sordi. Tutti quanti. E per non sentirsi inadeguato Dodici Dita aveva cercato di sfondarsi i timpani con un chiodo da staccionata all’età di diciassette anni. Ora ne aveva trentasette, era sopravvissuto per tanti anni a quei lamenti strazianti grazie al fatto che ci era riuscito, anche se solo a metà. L’orecchio destro non ascoltava più, nulla. Nemmeno il fragore della sua arma, quando l’avvicinava al volto per fare fuoco.
I proiettili scorrevano all’interno della pistola, come cubi d’acqua congelata in una gola di ferro. Dodici Dita distese il braccio e sfiorò col dito il grilletto. Uno scatto, il ritrarsi istantaneo di una molla, una cuspide di essedreel avrebbe scalfito il cristallo, l’energia avrebbe percorso la canna, il proiettile sarebbe stato vomitato fuori dal buio. Una pallina lucente che schizza nell’aria incurante di tutto quello che attraversa. PAM. Cielo azzurro, drappo di una bandiera, ancora cielo azzurro, lembo di una tunica, pelle, cranio, cervello, cranio, pelle, cielo azzurro… pietra angolare della torre. Così sarebbe andata.
E infine il denaro. Le monete d’oro, i lingotti d’argento. Gemme, pietre preziose, diamanti. Stoffe pregiate, vesti di lusso, vini speziati, portate deliziose, droghe esotiche, cortigiane e feste senza calendario. Dodici Dita aveva rinunciato a tutto questo tanto, tanto tempo fa. Strisciava tra i vicoli, come un grosso topo carognoso, per non essere visto e non vedere. Sapevano dove trovarlo, all’occorrenza, sapevano come chiamarlo, se avevano bisogno di lui. Lui non aveva bisogno di niente, di niente e di nessuno. Solo di una sentenza di condanna. Perché le persone emarginate come lui potevano permettersi di giudicare la società, ma non di condannarla. Era sempre stato così, e così sarebbe stato per sempre.
Tirò il grilletto con forza. Dodici Dita.
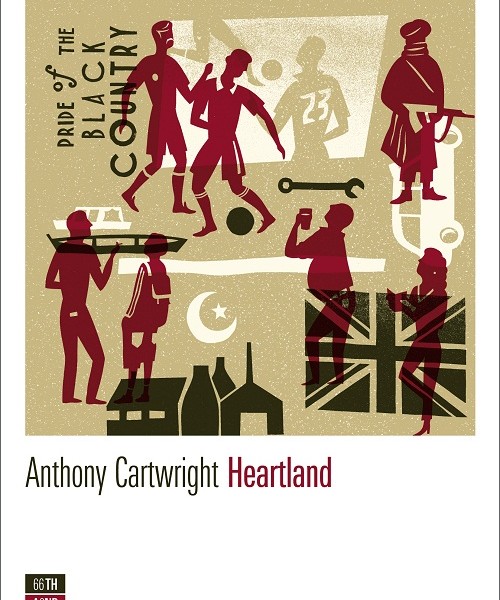
“Heartland” di Anthony Cartwright
Fallimento. Una parola senza appello ma pronunciata senza tirarla troppo per le lunghe. Senza compiacimento – per quel che può riuscire alla letteratura, va da sé. Il romanzo Heartland di Anthony Cartwright (66than2nd, 2013) è una storia di fallimenti, individuali e collettivi, detti con una lingua scabra, senza vezzi, denotativa – almeno, stando alla lettura in traduzione (a opera di Daniele Petruccioli). Diversi personaggi – in particolar modo Rob Catesby, insegnante di sostegno faticosamente alle prese con classi piene di immigrati e una carriera mancata da calciatore – che si agitano intorno a due partite di calcio e dentro vite, è il caso di dirlo, traballanti e senza sbocchi.
Nonostante la premessa poco allegra, il lettore ha la sensazione di avere a che fare con qualcosa di essenziale: le storie e i personaggi vanno avanti e indietro, ogni tanto si perdono per poi tornare, ma è un mondo, quello squadernato davanti al lettore, che sembra molto prossimo a una “vita vera”, recente e maledettamente seria. Ambientato nel 2002, durante i mondiali asiatici di calcio nell’Inghilterra dei distretti siderurgici, in cui convivono a fatica nativi e musulmani, pronti a darsele di santa ragione in una banale partita di calcio, mentre la squadra nazionale è impegnata contro la nemica di sempre, l’Argentina, il romanzo mostra come le crisi dei nostri tempi, fra crolli economici e nuovi scontri culturali, flagellino le classi sociali più deboli insinuandosi velenose anche nella loro vita privata, nelle relazioni fra le persone, e nella fiducia che i poveri cristi non riescono più ad avere in se stessi: «Tom ci provava eccome, a essere un buon marito, un buon padre, un brav’uomo, per quel che ancora poteva voler dire. Non durava».
Sulla scia di un ruvido ma tutt’altro che “semplice” realismo (prendiamo la nozione con ovvio beneficio d’inventario) che in terra inglese vanta un’importante tradizione, Cartwright – nato a Dudley nel 1973 – non perdendo mai di vista il racconto (il calcio è un po’ il centro nevralgico da cui muove la macchina narrativa – anche qui: con una perizia già sperimentata nella corrente letteratura di quelle parti) – richiama la natura politica del nostro stare al mondo – che se ne sia consapevoli oppure no (in terra inglese ma anche no). Fra l’allucinazione dei grandi schermi (in cui campeggia la figura di David Beckham) e un match fra indigeni e musulmani impregnato di valenze tutt’altro che sportive, la vita delle persone, per quanto impegno ci mettano, pare trascinata dai flussi della storia in una frantumazione delle certezze sociali, del lavoro per esempio, che i partiti nati per difenderlo hanno dimenticato: un sentimento di disfatta tradotto nel paesaggio delle West Midlands in cui le fabbriche spariscono e lasciano un vuoto spettrale.
In Heartland il calcio è un po’ lo spazio-tempo di una nemesi, o forse solo una fuga, una rappresentazione catartica che liberi dal soffocamento questa nuova umanità fragile ma reattiva, cui non mancano vitalità e memoria della bellezza – di quella che potrebbe essere bellezza della vita. La stessa che giustifica un romanzo come questo, onesto e sgangheratamente virile.
(Anthony Cartwright, Heartland, trad. di Daniele Petruccioli, 66tha2nd, 2013, pp. 289, euro 17)
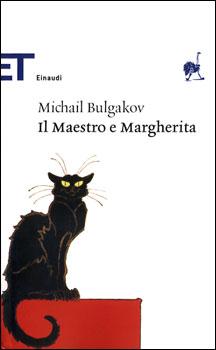
“Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov
In una calda sera di primavera agli stagni Patriaršie due uomini discutono sull’esistenza di Dio. Si tratta di Michail Aleksandrovič Berlioz, direttore di una rivista letteraria e presidente di una delle più importanti associazioni letterarie di Mosca, il Massolit, e del giovane poeta Ivan Nikolaevič Ponyrëv, detto Bezdomnyj. Il primo contesta al secondo il fatto che nel suo poema su Gesù quest’ultimo viene presentato come una persona realmente esistita, mentre egli, ateo militante, ne nega storicamente l’esistenza. Nel bel mezzo di questa disquisizione teologica al limite dell’eresia, improvvisamente compare un bizzarro personaggio, all’apparenza uno straniero, che si presenta come un professore esperto di magia nera: «Poteva avere una quarantina d’anni o poco più. La bocca un poco storta. Rasato con cura. Bruno. L’occhio destro nero e il sinistro, chissà perché, verde. Sopracciglia nere, ma una più alta dell’altra. Per farla breve si trattava di uno straniero».
Le sue affermazioni sono ancora più singolari del suo aspetto: dice di essere stato a colazione con Kant e di conoscere Ponzio Pilato, ma soprattutto di essere certo che Gesù sia esistito. Di fronte all’insistenza di Berlioz nel sostenere la sua tesi e la falsità della predestinazione dell’uomo, lo strano professore gli preannuncia che quella stessa sera morirà decapitato da un tram guidato da una donna. E così accade. Il giovane poeta, sconvolto, si getta al suo inseguimento non sapendo di rincorrere Satana in persona. Non creduto dalle autorità finirà in manicomio dove conosce uno scrittore (anche se ama definirsi uno “storico”, lasciando ai meschini letterati suoi persecutori tale etichetta) senza nome. Si fa chiamare Maestro. Questi gli racconta la sua storia d’amore con una bellissima donna, Margherita, e la vicenda tormentata del suo romanzo su Ponzio Pilato, la cui stroncatura da parte della critica lo ha fatto precipitare nella follia e internare. Il Maestro è un eroe mancato, un debole, un disperato che brucia il suo manoscritto e si lascia vincere dalla malvagità dei critici.
Romanzo nel romanzo, quello del Maestro si sviluppa all’interno della narrazione principale interrompendola di tanto in tanto. Esso è la riscrittura di un altro testo che egli non considera rispondente alla realtà dei fatti accaduti, un testo sacro per di più: il Vangelo. Il protagonista è Gesù, chiamato con il nome aramaico Jeshua Hanozri, negli attimi finali della sua storia terrena. È una figura più umana di quella ortodossa che emerge dal Nuovo Testamento, che rinnega quanto scritto sulla sua vita dal discepolo Levi Matteo.
L’altro personaggio principale è Ponzio Pilato, procuratore della Giudea, anch’egli al momento di ratificare la condanna del giudeo, preso umanamente dal dubbio e dalla viltà. Woland (questo il nome del diavolo) è protagonista insieme ai suoi accoliti (Behemoth, un grosso e grasso gatto nero parlante, Korov’ev, detto anche Fagotto, un ex maestro di cappella e Azazello, l’addetto alle intimidazioni), di una serie di avventure drammaticamente comiche e incredibili in cui sono coinvolti tantissimi personaggi.
Nella seconda parte del romanzo finalmente fa il suo ingresso sulla scena Margherita, diventandone la vera protagonista: da donna pigra, privilegiata e annoiata da un matrimonio senza amore, subirà un metamorfosi strabiliante una volta catapultata nel mondo oltre il reale di Woland.
Non c’è ne è uno tra i tantissimi personaggi che affollano la Mosca bulgakoviana con il quale ti fermeresti a scambiare quattro chiacchere. Tutta gente meschina e ipocrita che fa della truffa e della delazione la sua seconda pelle. Rappresentando così le sue creature, Bulgakov mette alla berlina la banalità della letteratura prodotta dal “realismo socialista”. La Russia post rivoluzione del ’17 è un vero inferno. Ciò che emerge è un odio profondo e inascoltato per il potere dominante, un sentimento condiviso dai lettori sovietici quanto taciuto e dissimulato, represso nella coscienza di ciascuno. A questa empatia probabilmente si devono lo straordinario successo cheIl Maestro e Margherita ha riscosso per più di vent’anni in Urss sin dalla prima pubblicazione censurata sulla rivista Moskva nel 1966-67, e le critiche e le umiliazioni subite dal suo autore.
Michail Afanas’evič Bulgakov nacque a Kiev nel 1891. Laureatosi in medicina nel 1916, cominciò a lavorare come apprendista medico nella provincia di Smolensk. Da questa esperienza nasceranno Le memorie di un giovane medico, composte nel 1926. Nel 1919 avviene la svolta: Bulgakov abbandona la medicina per dedicarsi totalmente alla letteratura. Già con il suo primo romanzo, La guardia bianca, lo scrittore si scontrò con le autorità sovietiche. La pubblicazione del libro nel 1925 su rivista venne interrotta infatti dalla censura. Dello stesso anno è Cuore di cane, in cui la narrazione è affidata al punto di vista estraniato di un cane, che viene trasformato in ominide da uno scienziato con esiti disastrosi.
Dopo Le uova fatali e Diavoleide, Bulgakov si dedica aIl Maestro e Margherita nel 1928, ma la prima versione viene distrutta nel 1930 per sfuggire proprio ai controlli del regime. Ne riprende la stesura l’anno successivo completando questa seconda redazione, già vicina alla definitiva, nel 1936. La terza versione è del ’37, anche se l’autore continua a lavorare di cesello aiutato dalla terza moglie, Elena Sergeevna Silovskaja. Alla quarta stesura metterà mano fino a quattro settimane prima della morte, avvenuta nel marzo del 1940 a soli 48 anni. Il romanzo sarà ultimato dalla moglie l’anno seguente. Bisognerà attendere il 1973 per la pubblicazione in Urss della versione completa, anche se le parti censurate erano già circolate in samizdat, cioè edite in proprio (fenomeno assai diffuso in Unione Sovietica e nei paesi sotto la sua influenza fra anni ’50 e ’60).
Quella che leggiamo noi oggi è la redazione preparata, frutto del lavoro filologico sui manoscritti dell’autore, della studiosa letteraria Lidija Janovskaja. Nel romanzo si sovrappongono tre diverse dimensioni: quella della cronaca contemporanea della Mosca degli anni ’30; quella antica agli albori dell’era cristiana che ha come ambientazione Jershalaim (Gerusalemme); infine quella atemporale e metastorica dove domina il problema del bene e del male e della salvezza dell’uomo.
In questo ferocemente esilarante capolavoro, elementi grotteschi e comico satirici alla Gogol’ si fondono con elementi esistenziali, surreali e fantastici in cui si sente l’influenza di Dostoevskij, ma anche del Faust di Goethe da cui Bulgakov trae l’epigrafe («…chi sei tu, dunque? / Sono parte di quella forza che / eternamente vuole il male / e eternamente opera il Bene»). Proprio quest’ultima svela in realtà la vera natura di Woland, un diavolo a vederlo bene tutt’altro che crudele e terribile, piuttosto uno scompigliatore dell’ordine costituito, un giustiziere rivoluzionario. A fare da concorrente alla sua magia nera è infatti una stregoneria terrena ben più diabolica. Se Lichodeev, il direttore artistico del Teatro di Varietà viene fatto scomparire da Mosca e fatto ricomparire a Jalta, altri, nella capitale russa, venivano quotidianamente fatti sparire: «Una volta, un giorno di festa, capitò nell’appartamento un poliziotto, fece venire in corridoio il secondo inquilino (il cognome del quale è andato perduto) e disse che lo pregavano di fare un salto al vicino commissariato per firmare una certa carta. L’inquilino aveva ordinato ad Anfisa […] di riferire in caso di telefonate che sarebbe rientrato dieci minuti dopo, ma non tornò più del tutto. La cosa più sorprendente fu che con lui, a quanto sembra, sparì per sempre anche il poliziotto. […] “Stregoneria!” dichiara la cameriera Anfisa». La scomparsa dell’inquilino è seguita da quella degli altri inquilini, finché non scompare anche la testimone di tutto, la cameriera Anfisa. Era l’epoca delle purghe staliniane.
(Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita, Garzanti/Mondadori/Einaudi)

Keller: storie da confezionare
Un vitigno è un progetto. Si pettina dentro i filari, s’inzuppa e si asciuga come sceglie il suo cielo. E poi lascia che il tempo costruisca il finale, che maturi dentro ogni acino, che solletichi le foglie e le faccia grondare. Che imbottigli l’attesa e poi la dissolva in chi vorrà gustarla. È un lavoro paziente, che racconta la storia di una terra; ogni volta diversa, con la cura devota e sofferta di chi sa di accarezzare la vita. E per quanto sembri azzardato, non c’è poi molta differenza con chi si occupa di editoria. O meglio, con chi se ne pre-occupa.
Questo mese il nostro incontro è dedicato a un’altra piccola preziosa realtà editoriale chiamata Keller. L’avventura parte nel 2005, a Rovereto, per iniziativa di Roberto Keller, ex editor di Marcos y Marcos e attualmente direttore editoriale. Il comitato editoriale è composto anche da Sara Passerini, Federico Diener, Giulia Cumer, Paolo Fabris e Silvia Bruno. I primi mezzi a disposizione non sono certo illimitati, ma l’idea fondante è quella di realizzare «libri di qualità, anzitutto, sia nei contenuti che nella forma, caratterizzati da un attento lavoro di redazione, grafica e confezione. La linea editoriale, aperta alla letteratura italiana e straniera, è costruita attorno a titoli che trasmettono idee forti, capaci di percorrere e comunicare, nei temi e nella scrittura, la complessità del mondo. Scritture e libri “obliqui” che sanno coinvolgere e far riflettere senza allontanarsi dal piacere della narrazione». Dedizione artigianale, accortezza a ciò che si dice e a come lo si dice. Rispondendo del valore di ogni volume. Perché ogni testo comincia dalla volontà di chi vuole condividerlo, anche attraverso una semplice ma raffinata scelta delle veste tipografica e dei materiali impiegati.
Sono presenti due collane:
– Passi;
– Vie, di formato più piccolo.
Entrambe sono due modi di disseminare impronte, «scorrendo lo sguardo sul mondo». I libri pubblicati (e distribuiti da CDA) sono tradotti dall’inglese, dal tedesco, dal ceco, dal romeno, dal polacco, riservando notevole spazio all’area mitteleuropea, in cui segnaliamo Max Blecher, Alek Popov, Angelica Overath e il Premio Nobel Herta Muller. Ma il catalogo annovera anche autori spagnoli e italiani tra cui i catalani Jordi Bonells ed Eduard Márquez e il piemontese Davide Longo.
Un percorso ricco di nomi interessanti e scritture originali, tra cui ci diverte offrirvi tre titoli:
– Lo scaffale degli ultimi respiri, di Aglaja Veteranyi. Storia magica e straziante di una girovaga circense che viaggiando come migrante tra i migranti inala i brividi e gli umori di terre e Paesi. Una carovana di sensazioni e riti, soffiati da una poesia straordinaria.
– La felicità di Emma, di Claudia Schreiber. Favola densa e commovente di Emma e dei suoi maiali, dell’amore che sa tradursi in modi impensati, estremi e travolgenti.
– Dio non appare in foto, di Jordi Bonells. La tenue esistenza di zia Maria, monaca di clausura, s’intreccia all’improvviso con la guerra civile, diventando timore e poi follia. Svelando la sua essenza solo settant’anni dopo.
Ma il vigneto Keller promette ancora molti frutti. A noi il piacere di saperli leggere.
Per ulteriori informazioni: http://www.kellereditore.it/

“Parigi. Un apprendistato” di Roger Caillois
Una raccolta di tre testi intorno Parigi, la scrittura e le dinamiche dell’ immaginazione, questo il libro di Caillois, Parigi un apprendistato, riproposto da Edizioni di Passaggio (2012). Parlare di opera composita sarebbe negare l’organicità che vincola in modo indissolubile le tre parti.
Nella prima, «Piccola guida del XV arrondissement ad uso dei fantasmi», partendo dalle passeggiate d’infanzia nel quartiere dove un tempo sorgeva l’antico villaggio di Grenelle, Caillos ci propone la riscoperta di una parte ormai scomparsa della capitale francese. Attraverso il suo sguardo da flâneur e uno stile idiosincratico, l’autore ci trascina in un viaggio fantastico che mostra, sebbene in filigrana, la propria formazione surrealista, lasciando al ricordo della città il compito di evocare se stessa trascendendo la propria immagine radicata. L’urbanistica, l’architettura, perfino i nomi dei locali o le affissioni pubblicitarie murali imprimono la direzione delle astrazioni: fantasmi che abitano in edifici piatti quasi costruiti a loro uso, e altre creature che sono, come in un negativo, complementari al mondo umano, dirigono l’immaginario dell’autore verso una scrittura autobiografica che risulta inscindibile dalle riflessioni introspettive su se stesso e sulle dinamiche della narrazione fantastica, siano esse consapevoli o inconsce.
L’occhio teso alle zone d’ombra della città, lì dove non sono puntati i riflettori, l’invisibile e l’anomalo indagati attraverso la memoria, sono le costanti che attraversano i tre scritti, il ganglio su cui l’autore fa leva per restituire una Parigi altra da quella proiettata sul sentore collettivo. Soprattutto nella prima e nella terza parte, intitolata «Apprendistato parigino», privilegiando l’immaginazione fantastica ci viene narrata una città scevra da ogni tipo di analisi storica e socio-culturale, in piena antitesi, stilistica oltre che tematica, rispetto alla Parigi dipinta dallo stesso autore nel saggio giovanile Parigi, mito moderno (1938).
Tuttavia, il discorso non si esaurisce in una rappresentazione eclettica della capitale francese. La stessa estenuante vicenda che accompagna la redazione del libro, ne forgia la forma definitiva, sembra farsi parte integrante dell’economia generale dell’opera. Nel secondo capitolo ad esempio, intitolato «Storia di una metamorfosi», è raccontata la trasformazione del testo in seguito alla scelta di una trasposizione cinematografica, e di come l’operazione d’adattamento e conseguente riscrittura sia stata per l’autore occasione per riflettere con più consapevolezza intorno al significato e le modalità del proprio lavoro.
Un libro, dunque, che può essere osservato da differenti angolazioni ad appagare diversi interessi. Come antesignano, per certi versi, delle moderne guide turistiche culturali; come riflessione sul fantastico da parte d’uno studioso che vi ha dedicato molte energie; come esperimento narrativo in cui si intersecano e sovrappongono differenti registri, rendendo a tratti sfuggevole la stessa figura dell’autore, dichiaratamente impegnato a «seminare nello spirito del lettore il dubbio iperbolico […] sulla continuità o l’identità di me stesso».
(Roger Caillois, Parigi. Un apprendistato, trad. e cura di Roberta Coglitore, Edizioni di Passaggio, 2012, pp. 192, euro 12)

“Last Resort” di Shawn Ryan
Il mondo della televisione americana è senza dubbio un mostro spietato con cui i produttori televisivi devono vedersela ormai da svariati anni. Quando si parla di serie televisive la qualità e l’originalità del prodotto saranno sempre subordinate alla dura legge degli ascolti e dei “rating”.
Lo sa bene Shawn Ryan, uno dei creatori di successi come The Shield, vittima di questo brutale sistema. Già nel 2011 il suo The Chicago Code aveva ricevuto il benservito dalla FOX. Questa volta è toccato a Last Resort, una delle serie più attese di questa stagione televisiva. Alla ABC è bastata poco più di metà stagione per trarre le proprie conclusioni e annunciare che il tredicesimo episodio sarebbe stato anche l’ultimo.
Eppure lo show sembrava davvero promettere bene: il sottomarino americano USS Colorado si ribella coraggiosamente a un ordine proveniente da un canale non ufficiale di lanciare dei missili contro il Pakistan. Quando l’equipaggio capisce di essere stato dichiarato nemico del proprio paese l’unica soluzione è fuggire. La meta? La splendida isola di Sainte Marina, un paradiso già controllato da Serrat, una sorta di despota a capo di praticamente qualsiasi attività.
Il comandante Marcus Chaplin si ritrova tra due fuochi, costretto a guardarsi le spalle dai banditi locali e attento a difendersi da un paese pronto a cancellare lui e il suo equipaggio dalla faccia della Terra pur di insabbiare l’accaduto. Tra complotti, segreti e intrighi internazionali Last Resort aveva gettato le basi per una serie capace di diventare se non un capolavoro almeno un prodotto all’altezza delle aspettative. Nel corso degli episodi però qualcosa si è perso e in alcuni casi si è avuta l’impressione di vedere una sorta di appiattimento della qualità.
Anche gli americani sembrano essersene resi conto, visto che si è passati dai 9 milioni di spettatori dell’episodio pilota andato in onda a settembre 2012 ai circa cinque milioni di metà stagione, il motivo per cui la ABC è giunta alla decisione di dare l’addio alla serie. Se per Shawn Ryan fosse valso il famoso detto «mal comune mezzo gaudio» ci sarebbe stato quasi motivo per gioire.
Solo in questi ultimi mesi lo stesso canale ha tagliato anche l’altro successo annunciato dell’anno, 666 Park Avenue, reo a sua volta di non aver portato al proprio mulino un numero sufficiente di spettatori.
Anche l’anno scorso la stessa sorte era capitata a The River e Missing, portando il conto a quattro cancellazioni illustri praticamente in dodici mesi solo da parte della ABC, pronta a mietere altre vittime dopo l’esordio un po’ fiacco (ovviamente solo a livello di share) di Zero Hour, in onda da un paio di settimane ma già forse con un piede nella fossa. D’altra parte il successo viene prima di ogni altra cosa, forse anche dell’effettiva qualità del prodotto. Non è il caso degli show che continuano a rendere soddisfatte le alte sfere del network, come Castle o Modern Family, ma è sicuramente quello di serie come Last Resort (e ancor più 666 Park Avenue) giunte a una conclusione affrettata e probabilmente imprevista senza avere la possibilità di mostrare fino in fondo il proprio valore, qualunque esso sia.
Penso che il lavoro di Shawn Ryan difficilmente avrebbe raggiunto un immenso successo (la qualità dello show sembrava un po’ in calo dopo i primi episodi), ma rimango sempre deluso dall’atteggiamento dei grandi canali; veramente troppo spesso in questi ultimi anni molte serie sono state eliminate più o meno in malo modo senza possibilità di dimostrare la proprie complete potenzialità almeno con una stagione pulita e senza affanni. Lo share è un tiranno esageratamente senza pietà.

“Complicità. Diego e Frida” all’Istituto Cervantes di Roma
Una creatura leggiadra, delicata e fragile ne incontra una del tutto diversa: come si potrebbe dire di una colomba che si avvicina a un rospo. Difficile pensare che una tale unione possa essere non solo plausibile, ma addirittura armonica. Eppure Frida Kahlo e Diego Rivera hanno mutato una tale assurdità in una vita insieme. La piccola ma tenace donna sceglie “El panzón”, così veniva chiamato il grande Rivera, dalle forme opulente. Lei ammira i murales del pittore e lui resta profondamente colpito dai suoi dipinti: considerazione e stima reciproche, prime radici di un duraturo amore.
La mostra Complicità. Diego e Frida è dedicata proprio a questa intesa, complessa e intensa. Un affiatamento durato un’esistenza intera, costellato di difficoltà e infedeltà, sofferenze e scontri. Ma solido e autentico, acceso da forti passioni, quella reciproca e quella condivisa per gli ideali politici e per il proprio paese, il Messico, a cui entrambi furono estremamente legati.

Le fotografie in bianco e nero esposte, una piccola raccolta dal tono intimo, narrano questo: una vita condivisa tra politica e arte, un sodalizio che ha attraversato la storia e ne è entrato a far parte, tanto da divenire importante per le vicende del Messico.
La mostra, strutturata in tre parti – le tre sale in cui è diviso l’ambiente espositivo dell’Istituto Cervantes a Piazza Navona – si apre proprio con alcuni scatti dedicati alla Rivoluzione messicana: testimonianza di questo movimento armato di riscatto contro la dittatura del generale Díaz, è la prima immagine di una sequenza di armi rivoluzionarie, a cui seguono fotografie di case distrutte e di un militante colpito e agonizzante. Il primo atto dell’esposizione definisce il punto focale: l’importanza che la Rivoluzione ha avuto nella storia dei due artisti e nella loro unione. Furono le loro convinzioni politiche, legate al Comunismo, e la determinazione a perseguire un ideale sociale a segnare l’inizio del loro legame, forte proprio perché intriso di intenti e speranze comuni. Si ricordi che Frida Kahlo dichiarò sempre di esser nata nel 1910, quando la vera data era invece il 1907, per identificarsi con l’anno dell’inizio della rivolta, da autentica figlia del cambiamento e della lotta per la libertà del proprio Paese.

Il 1917, con la promulgazione della nuova costituzione, è l’anno che chiude formalmente la rivoluzione – anche se gli scontri proseguirono fino al decennio successivo –. Una delle fondamentali figure politiche a emergere è quella di José Vasconcelos che favorisce l’avvio di una rinascita messicana basata sulla consapevolezza dell’identità nazionale. È lui a commissionare nel 1921 a Rivera il primo dipinto murale: una fotografia nella prima sala ritrae il pittore intento nel lavoro de “La creazione”, realizzato presso l’anfiteatro Bolivar della Scuola Nazionale Preparatoria di Città del Messico.
Passando nello spazio successivo, si approda a nuovi scatti che presentano i due artisti in momenti pubblici, sempre di carattere politico, come le immagini che li ritraggono con Trotsky, esiliato dall’Unione Sovietica e recatosi in Messico proprio su invito del pittore. A questi scatti si accompagnano momenti di vita privata: ecco allora la fotografia realizzata nel giorno del loro matrimonio. Frida appare piccola in confronto alla figura imponente di Diego. Lei è composta, avvolta in uno dei suoi amati vestiti messicani, quelli che indosserà sempre, come una pelle cucita addosso, simbolo dell’attaccamento alle sue radici. Ha uno sguardo serio. Il peso delle sofferenze già affrontate le ha dato quella profondità che traspare non solo dal volto, ma dal corpo intero. L’incidente in tram avuto nel 1925, a cui è sopravvissuta per miracolo, segna il suo fisico per sempre e la condannerà a problemi e dolori continui fino alla fine. All’inizio la costringe per mesi interi a letto: dipinge e sprofonda in sé, assottigliando la sua sensibilità. In questa foto come in altre che la ritraggono, c’è tutto questo, una profonda intensità data da quella tenacia che le era necessaria. Una donna estremamente forte in un corpo fragile. Ama intensamente Diego. Quell’uomo volubile, che continuerà ad abbandonarsi ad altre femmine, non le risparmierà certo sofferenze. Eppure tra momenti di lontananza e separazione restano accanto, come in questa foto, fino alla fine.

La terza e ultima sala presenta proprio questo momento, l’avvio verso la conclusione. La pittrice ormai sempre più debole e malata fa la sue ultime apparizioni prima di andarsene nel 1954. Tre anni dopo Diego la seguirà.
La mostra ha un impatto emotivo indiscutibile. È inevitabile dato il soggetto. Due personalità così forti non possono che emergere e toccare lo spettatore. Il fatto che sia raccolta, trentacinque scatti in tutto, lascia il desiderio di vedere altro, di scavare ulteriormente. Dal punto di vista dell’offerta espositiva, va detto che le sale anche nei momenti di apertura al pubblico non sono state sempre rese agibili alla visita, perché occupate da altre attività.
Ma per due artisti e due vite di quella portata è valsa la pena tentare più volte.
Complicità. Diego e Frida
Instituto Cervantes, piazza Navona 91, Roma
13 febbraio-10 marzo 2013
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.roma.cervantes.es

