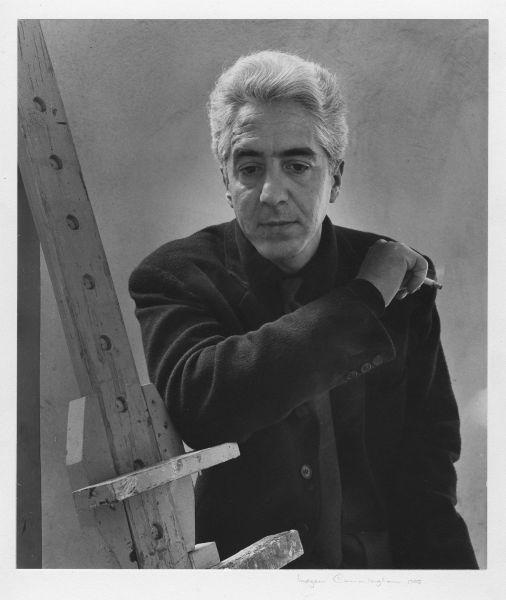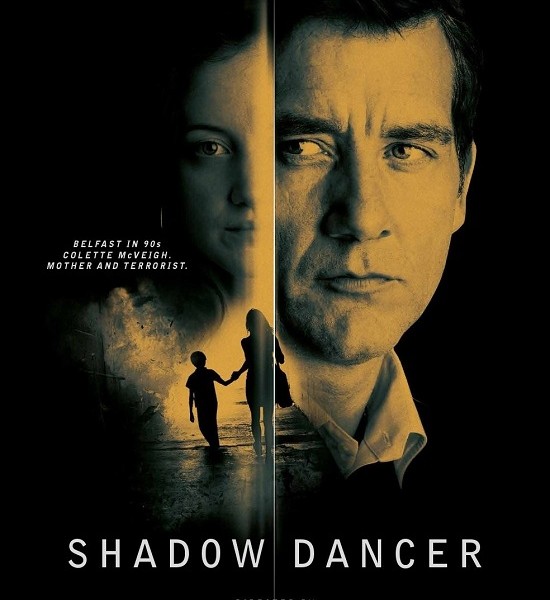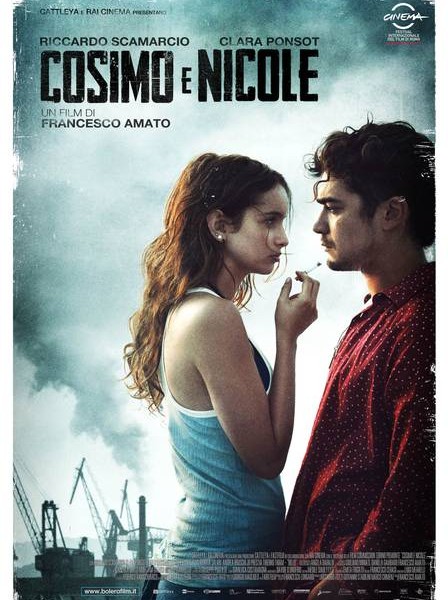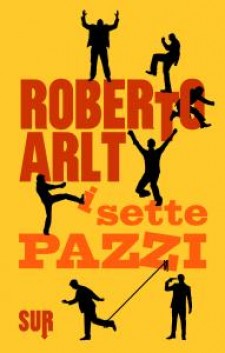Einaudi pubblica agli inizi di novembre la terza parte di 1Q84 di Haruki Murakami (la prima e seconda parte hanno visto la luce nella traduzione italiana nel 2011) riservando gli onori della copertina rigida e di una sovraccoperta ben studiata a quello che non da pochi è considerato il capolavoro dello scrittore che ha sfiorato il premio Nobel per la letteratura lo scorso ottobre.
Prima di addentrarsi nell’analisi è bene sottolineare l’ovvio: stiamo parlando di un autore giapponese. È un fenomeno studiato nel campo delle relazioni internazionali, da non confondersi con lo scontro di civiltà di huntingtoniana memoria, quello rappresentato dalla difficoltà, per i partecipanti a una cultura quale può essere quella occidentale contemporanea, a riconoscersi e a comprendere una cultura molto distante dal punto di vista socio-culturale e valoriale come quella giapponese. Senza approfondire tematiche che non sono qui di interesse, vale la pena notare però come la poca familiarità con azioni, ritmi e filosofie con cui l’occidentale non è in grado di entrare in consonanza renda le storie, già punteggiate di surrealismo, maggiormente affascinanti. Una migliore definizione del proprio stile la dà lo stesso autore proprio in questo romanzo: «Sebbene la trama sia nell’insieme fantastica, le descrizioni dei dettagli sono estremamente realistiche. L’equilibrio tra questi due aspetti è eccellente». E ancora: «Come storia è molto interessante e trascina con una forza irresistibile il lettore fino alla fine, ma […] galleggiamo fino all’ultimo in una piscina piena di misteriosi punti interrogativi». Possiamo azzardare, leggendo queste righe, che tale godibilissimo esperimento di metaletteratura denoti, da un lato, una maturità artistica che non si carica di superbia dal momento in cui incorpora la voce dei critici, e dall’altro la disponibilità a venire incontro alle perplessità del lettore. 1Q84 è infatti il romanzo che meglio ci offre l’occasione per ripercorrere la lunga produzione del celebrato autore, offrendo al lettore le chiavi per interpretarla, poiché raccoglie all’interno di un unico contenitore narrativo tutti gli elementi essenziali della sua prosa.
Aomame e Tengo sono i due protagonisti del romanzo. La prima è una giovane istruttrice all’interno di uno esclusivo club sportivo, il secondo un professore di matematica. Due vite che a prima vista scorrono molto distanti l’una dall’altra ma tra le quali si distendono numerosi ponti in grado di trasformare il parallelismo su cui è impostato il romanzo in un sentimento di incerto determinismo, tenendo il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. L’autore tesse un intreccio al limite dell’improbabile i cui snodi sono costituiti da elementi che si presentano quasi sempre come di secondaria importanza, ma che ricompaiono nel corso di tutta la storia accrescendo il proprio peso e scandendo il tempo con un ritmo cadenzato.
Il tempo, in Murakami, è un elemento fluido che scorre liberamente attraverso espressioni franche quali: «Le settimane passavano senza che nulla accadesse». Il dilatarsi del plot non è un fattore di cruccio: come avviene in 1Q84, in molti dei suoi romanzi trascorrono interi mesi tra l’inizio e la fine delle vicende. D’altro canto, grazie ai flashback, l’autore addensa la mistura e cesella i suoi personaggi conferendo loro invariabilmente un passato che, se non è sempre possibile definire ingombrante, racchiude in ogni caso almeno una vicenda fondamentale alla comprensione della storia che viene narrata al presente. Esemplare a tal riguardo è il caso di Norvegian Wood, una Who I Am Story che si dipana lungo un unico lungo flashback. Norwegian Wood è un romanzo sul conflitto tra il desiderio di essere integrati e il bisogno di percepirsi degli individui. Murakami esplora la dimensione interiore dei personaggi mentre sullo sfondo tratteggia una delle sue Tokyo più riuscite, quella rivoluzionaria degli anni Settanta, fervente di proteste giovanili. Toru, il protagonista, è un solitario. Poco sicuro di sé, viene, da un lato, continuamente assalito dal dubbio, mentre, dall’altro, è guidato da un ostinato e personale senso della morale. Diviso tra due ragazze, Naoko, ricoverata in un ospedale psichiatrico incapace di superare il suicidio del fidanzato già migliore amico dello stesso Toru, e Midori, una ragazza con gravi problemi familiari, non può fare altro che decidere o aspettare che la vita, un equilibrio instabile tra futuro e passato, decida al suo posto.
Ma anche in A sud del confine, a ovest del sole è solo il ricordo di un’esperienza passata quello che permette al protagonista, Hajime, di reinterpretare il proprio presente. Hajime (traducibile con «inizio») nasce la prima settimana del primo mese del primo anno della seconda metà del XX secolo. Figlio unico, stringe amicizia con una figlia unica, Shimamoto, dalla gamba offesa dalla poliomielite. Il passaggio alla pubertà separa i due prima che possano riconoscersi innamorati. Il caso li riunisce troppo tardi, quel tanto che basta perché Hajime possa colmare i vuoti della sua vita prima che Shimamoto torni al nulla da dove era piovuta. A sud del confine, a ovest del sole potrebbe essere un’ideale continuazione di Norwegian Wood dal momento in cui approfondisce, pur senza la stessa incisività, la solitudine dei personaggi coinvolti nella vicenda e i loro sentimenti più nascosti. A differenza del suo ideale progenitore però, recupera una dimensione onirica suggerita al lettore dai dettagli e dalla capacità potenziale di condurre oltre la realtà dei sensi attraverso mani che si stringono anche solo per dieci secondi.
In 1Q84 Tengo e Aomame sono accomunati in primo luogo dalle storie della propria infanzia. Entrambi hanno dovuto confrontarsi con genitori fanatici, seppure ciascuno a modo proprio, ed entrambi hanno scelto di emanciparsi in tenera età dalla famiglia. Intuiamo subito, ma scopriamo solo dopo qualche centinaio di pagine, che, inoltre, i due protagonisti si sono conosciuti a scuola e all’età di dieci anni hanno sperimentato l’esperienza che li lega indissolubilmente e li determina all’età di trenta, quando ha luogo la vicenda narrata. Ma le connessioni tra le vicende dei protagonisti sono molteplici e vanno al di là del passato che condividono. Entrambi svolgono un lavoro segreto, il primo illegale, ma giustificato in termini etici, il secondo legale, ma eticamente disprezzabile. Il lettore, per quanto libero di formarsi un giudizio, non è chiamato, in questo caso come in altri, a dare una valutazione morale delle azioni dei personaggi. In questo romanzo i protagonisti si incaricano personalmente di giudicarsi e il giudizio è talmente minuzioso e la valutazione finale talmente perentoria che ciascuno dei protagonisti si trasforma in uno dei mondi lungo la strada del Piccolo Principe: piccolo, spesso assurdo, ma sorretto da una logica interna inattaccabile.
Questa dimensione fortemente etica dei personaggi la riscontriamo anche in altri testi. In Kafka sulla spiaggia, ad esempio, un ragazzo-adulto di quindici anni e un vecchio-bambino si incamminano separatamente e ignari l’uno dell’altro da Tokyo verso Taka-matsu, nel Sud del Giappone. Il ragazzo, che ha scelto come pseudonimo Kafka, è in fuga dal padre, scultore geniale e oracolo di Delfi, con cui vive in solitudine dall’età di quattro anni. Il vecchio, Nakata, fugge invece dalla scena di un crimine abbandonando una vita fatta di abitudini e rallegrata dai gatti. Kafka e Nakata vivono incardinati ai propri imperativi categorici – cui l’età intellettuale dei due personaggi dà diverso spessore morale – che si rivelano per l’uno la necessità assoluta di non replicare il destino di Edipo e tentare di sfuggire alla predizione e per l’altro il recarsi a svolgere, anche a costo della propria vita, un compito.
Aomame e Tengo si cercano. Il tema della ricerca e dell’assenza che determina la ricerca è un elemento che Murakami inserisce in tutti i suoi romanzi. Ne La ragazza dello Sputnik le storie d’amore a senso unico che i personaggi vivono si risolvono nella scomparsa di Sumire; in Kafka sulla spiaggia, come in uno specchio, è Tamura Kafka a dare inizio alla vicenda “scomparendo”; in Nel segno della pecora si inverte l’ordine degli addendi dal momento in cui, in un certo senso, tutto quello che non si riesce a trovare è lì presente, ma il risultato non cambia. Ne L’Uccello che girava le viti del mondo, la ricerca è, però, il cuore dell’intera vicenda. Toru Okada, il protagonista è un felice non-occupato che si dedica alla casa e alla moglie. Quando il gatto scompare si mette in moto un meccanismo di trasformazione della vita dell’uomo che lo porta in un viaggio fiabesco in cui egli diventa l’eroe incaricato della liberazione della principessa-moglie dal drago-cognato. Attraverso questo viaggio verso la moglie il protagonista intraprende un percorso parallelo alla scoperta del mondo dentro di sé e di ciò che era diventato impossibile tacere. I comprimari sono essi stessi parte dell’immaginario, e vivono contemporaneamente all’esterno e all’interno di Toru. Tra questi spicca May, un’adolescente laconica e lunatica, che spinge il protagonista verso una verità raggiungibile solo dal fondo di un pozzo inondato dalla luce della luna.
I personaggi delle storie appena nominate, sia che scompaiano sia che si incarichino della ricerca, a un certo punto del loro percorso incappano in un’altra realtà. Il lettore si accorge sempre troppo tardi di aver cambiato dimensione e la sensazione di sorpresa che si prova dal momento in cui lo straniamento si palesa, accompagnato da un filo di angoscia, è esattamente quello che rende grande Murakami e fa sì che la somma di tutti gli elementi in cui si può scomporre la sua letteratura sia comunque più grande del valore degli elementi stessi. In 1Q84 il topos dell’alterità, inteso nella suddetta maniera, viene assunto a titolo del romanzo e il passaggio di Tengo e Aomame alla nuova realtà viene indicato dalla sensazione fisica di torsione che i due avvertono dal momento in cui casualmente inciampano sulla soglia tra i due mondi. Ma il testo che in questa direzione meglio esalta la forza immaginifica dello scrittore è indubbiamente La fine del mondo e il paese delle meraviglie, la cui struttura a due binari riconosciamo anche in 1Q84. Si tratta di un romanzo che gioca con i generi letterari: da un lato una realtà cyberpunk e dall’altro un’ambientazione fiabesca in cui vivono gli unicorni che progressivamente si sovrappongono, si intrecciano e complessivamente travalicano le norme dell’uno e dell’altro genere di riferimento. Forte e destinata a rimanere impressa è anche l’immagine dell’ascensore con cui si confronta Yuki, in Dance, dance, dance.
Altre immagini sono invece come delle impunture fatte con il filo rosso che abbiamo appena tessuto: i gatti, la luna, il telefono e la musica sono infatti, differentemente combinati, la firma di Murakami. I gatti e la luna sono strettamente relati all’ambiguità e al mistero e l’autore àncora sui primi o sulla seconda le chiavi di volta per la comprensione da parte dei personaggi della loro nuova realtà; il telefono, sempre fisso e immaginato da chi scrive tale e quale ai vecchi apparecchi SIP con la ghiera per la composizione dei numeri, è il tramite per il quale passano le comunicazioni tra l’uno e l’altro mondo; la musica, infine, è la colonna sonora interiore del testo, introdotta con apparente noncuranza e invece sempre intonata al mood del libro più che alla circostanza in cui compaiono i titoli.
1Q84 è, alla radice, anche una storia d’amore e Murakami si dimostra tanto un maestro nel generare suspense quanto nell’indagare i sentimenti dei suoi personaggi. Da notare qui il paradosso per cui tanto potente è l’amore che si concretizza invariabilmente in gesti minimi e simbolici, quanto poco sensuale risulta, nelle righe di questo autore, il sesso. L’immagine della mano di Tengo stretta in quella di Aomame (come già in A sud del confine, ad ovest del sole dieci secondi bastano alla mano dell’una per lasciare un’impronta indelebile nella mano dell’altro) rappresenta con forza primitiva un legame amoroso che non può che perdere un po’ del suo smalto dal momento in cui il legame diventa carnale e convenzionale. Toru, in Norvegian Wood, grazie a Nagasawa, personaggio-sensale con cui fa conoscenza all’università, farà sesso più spesso con sconosciute cui non è legato da nulla che con Naoko e Midori, attorno alle quali ruota, invece, il suo centro di gravità.
Sembra in ogni caso strano ricordare solo alla fine che di storia d’amore si tratta, così come solo alla fine ci si ricorda di notare che Kafka sulla spiaggia è un romanzo di formazione, ma forse ciò avviene naturalmente nel lettore che segue l’istinto e che, come suggerisce Emily Parker nell’articolo “How to Read Haruki Murakami”, non si sofferma troppo a lungo a sezionare il cadavere alla ricerca dei significati nascosti, perché Murakami imposta le immagini e lascia il lettore libero di decifrarle come vuole e concede tempo-pagine sufficienti per immergersi nell’ambiente circostante e smettere di metterlo in discussione affinché il lettore si possa semplicemente godere il libro e il flusso delle parole nella sua interezza.