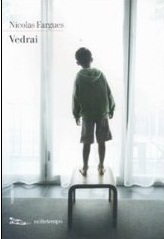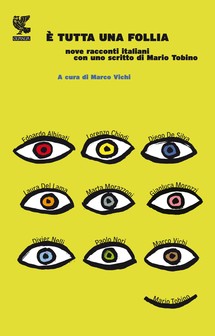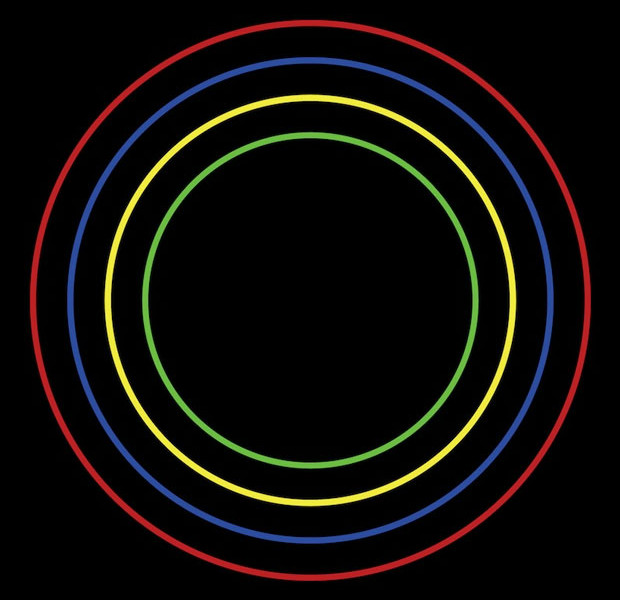C’è chi la musica la fa, c’è chi la musica la ascolta. E c’è chi della musica si prende cura, la porta in giro, lavora per creare a ogni spettacolo le condizioni tali affinché la magia tra palco e platea avvenga. Conversiamo con Stefano Iacovitti. Romano, 37 anni, laureato in giurisprudenza, nel 2003 inizia a lavorare come road manager con Roberto Angelini.
Come definiresti il tuo lavoro di road manager?
Divertente, interessante, però anche faticoso… road manager è una qualifica un po’ stretta, perché di volta in volta faccio il tour manager, il personal manager, da due anni mi occupo prevalentemente delle luci degli spettacoli, se non esclusivamente. In effetti, però, la qualifica ufficiale con cui ho iniziato era proprio road manager.
Hai scelto o sei stato scelto da questo lavoro?
Sono stato assolutamente scelto da questo lavoro in maniera casuale e anche un po’ bizzarra. Ero con Angelini in casa di un amico comune, impegnatissimi a parlare di massimi sistemi giocando alla PlayStation… [e sorride, sottolineando il contrasto della situazione.] Io ero tornato dal servizio militare ed ero in cerca di un lavoro che non fosse tradizionale, mi ero laureato ma già negli ultimi tempi dell’università avevo capito che quella non sarebbe stata la strada per me… non avevo ancora capito, però, quale potesse essere. Angelini mi offrì di accompagnarlo come road manager, aveva bisogno di una persona di fiducia. Feci le prime due tappe con lui in Puglia, il 2 e 3 agosto 2003 a Monopoli e Bitonto. Era il mio inizio, mi sembrava tutto un mondo dorato a cui non ero abituato, dissi a Roberto: «Ti ringrazio anche se dovesse finire domani!», perché quei due giorni erano una sorta di prova per me, lui magari era già convinto. L’autunno successivo cominciai il tour con Niccolò Fabi, e nell’ottobre 2005, a Benevento, feci la prima tappa con Simone [Cristicchi, ndr].
C’è stato un maestro che ti ha insegnato il mestiere o hai appreso tutto con l’esperienza?
Certo, ci sono delle figure di riferimento ma un vero maestro non mi è mai capitato. Io mi sono trovato sempre un po’ allo sbaraglio, ho cercato di carpire anche qualche semplice atteggiamento dalle persone con cui ho lavorato. All’inizio basi tutto sui rapporti personali e cerchi di fare bene il tuo lavoro.
Hai collaborato con Roberto Angelini, Niccolò Fabi e Simone Cristicchi: quali aggettivi sceglieresti per descrivere ciascuno di loro?
Non è facile eh… sono combattuto tra l’aspetto umano e quello artistico … sono tutti e tre amici… [E alla fine ce li racconta come si farebbe con una soggettiva, con un’inquadratura personale.] Roberto lo conosco dall’89, eravamo al ginnasio insieme, è un amico fraterno, è una persona a cui voglio bene, ma di quell’affetto proprio viscerale. Simone è un’altra persona a cui sono molto legato, dal 2005 a oggi ormai lavoro quasi esclusivamente con lui. È la mia seconda fidanzata! Niccolò è una persona eccezionale, profonda, sensibile, seria. Penso che sia uno dei cantautori più bravi e preparati. Ha una scrittura che a me piace molto.
Com’è la musica da dietro le quinte?
Sempre affascinante, potrebbe perdere quell’aura di magia però è sempre una forma di espressione bellissima. Mi emoziono, specie quando faccio le luci perché ci sono dei passaggi in cui mi sembra proprio di integrarmi alla perfezione, in qualche modo partecipo al concerto. [E prosegue nel suo racconto, appassionato.] Fare le luci mi fa sentire parte dello spettacolo, mi permette di esprimermi in maniera creativa… con Roberto al tempo della scuola, avevamo un gruppo, avevo quindici anni e suonavo la chitarra, ho continuato a suonare fin dopo la maturità poi ho smesso ma sono rientrato dalla porta di servizio, ed essere alle luci mi permette di essere un po’ sul palco.
C’è un episodio del dietro le quinte a cui sei particolarmente legato e che ci vuoi raccontare?
Oddio… sai che non lo so?! [Ma è questione di istanti e ci regala una storia spassosissima.] È un episodio di dietro le quinte sul palco! Era l’ultima data del tour estivo 2007 di Simone, e tradizione vuole che nell’ultima data si preparino degli scherzi. Io e il fonico di palco, Riccardo Boldrini, avevamo preparato delle tracce con frasi del Magnotta [e in una esilarante digressione ci racconta del tour 2007 la cui colonna sonora in macchina durante gli spostamenti era il cd con gli scherzi a Mario Magnotta e di aver raggiunto un tale livello di “esegesi” di quei testi da studiarne persino l’inflessione!] avevamo collegato il pc col mixer di palco, mixer che gestisce i monitor, o in alternativa le cuffie, che hanno i ragazzi sul palco. Quella volta erano tutti in cuffia, perciò avevamo fatto in modo che insieme agli strumenti sentissero le singole frasi del Magnotta: da quelle più scabrose a quelle più normali che però potevano far ridere perché erano un tormentone fra noi. Ogni tanto azzeccavamo anche una frase pertinente con la frase che aveva appena cantato Simone. Ricordo che il chitarrista, Davide Aru, crollò in ginocchio ridendo, io e il fonico eravamo piegati dalle risate. Il pubblico non sentiva e non si spiegava cosa stesse accadendo, perciò è un retroscena avvenuto però sul palco.
Una giornata tipo in tour?
Sai quando parti ma non sai quando vai a dormire! Questo potrebbe essere il motto. In sintesi, da foglio di lavoro: appuntamento per partenza, viaggio più o meno lungo, arrivo sul posto per allestire tutto, prove, concerto, mezz’ora di autografi.
Com’è presenziare a questa mezz’ora di autografi, osservare?
È un po’ strano… io non concepisco l’autografo, ho visto gente farsi fare l’autografo su pezzi di tovaglia di carta strappata dal tavolo del camerino, o sul braccio… proprio qualche giorno fa, con Simone, ci hanno fermato due ragazze per strada, non avevano visto il concerto ma volevano foto e autografo… per puro esibizionismo. Scriverei un libro, sugli autografi! Un’altra volta a Cavriglia, nel 2004 credo, giocai con la nazionale cantanti, a fine partita c’era Roberto circondato da mamme, bambini, adolescenti, ragazzi, mi ero avvicinato a lui per dire che stavo andando in spogliatoio e ci saremmo visti dopo ma non ho fatto in tempo perché questo “sciame” si rivolse verso di me. Presero per mezz’ora autografi da me senza sapere chi fossi, un bambino però mi disse: ma tu chi sei?
Fuori tour?
Non ho una vita sociale particolarmente attiva, essendo sempre in giro per lavoro quando sono a casa mi piace una vita tranquilla, con la mia ragazza. Faccio sport, mi piace leggere. Sono un feticista dei libri, solo quelli cartacei, non riesco a leggere quelli digitali. Pure in tour ho sempre un libro con me e anche se vado a letto alle 5 leggo almeno una pagina. Adesso , per esempio, sto leggendo Il senso del dolore di Maurizio De Giovanni.
C’è un concerto che vorresti andare a vedere, e sentire, da spettatore?
Sto per andare: Radiohead, 22 settembre, a Capannelle, Roma. [E lo annuncia soddisfatto, anche trepidante, mentre gli occhi gli si illuminano e accendono tutto il volto in un sorriso.]
Quale domanda vorresti venisse fatta a Stefano Iacovitti?
Non ne ho idea… in realtà forse me l’hai fatta chiedendomi del lavoro, per cui ho potuto dire quanto mi piace e mi emoziona essere alle luci. Di personale non saprei… anche perché pur avendone viste fare tante, di interviste, io non sono così abituato a essere intervistato.

Foto di Mauro Taddei e Maria Luisa Maricchiolo.