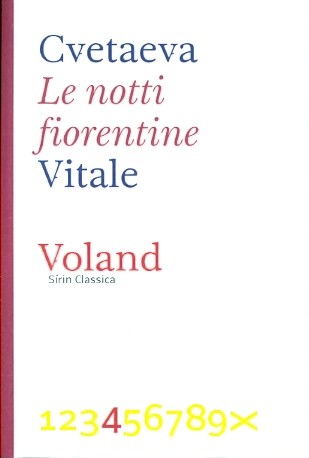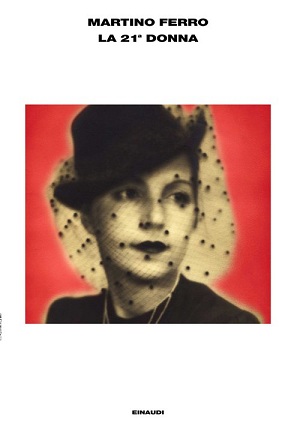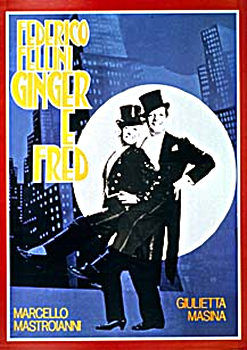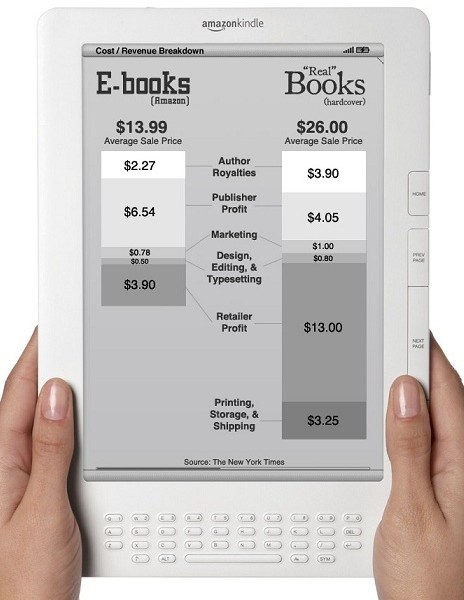Le notti fiorentine è una raccolta di appena undici lettere, breve ma intenso rapporto epistolare tra la poetessa Marina Cvetaeva e Višnjak l’editore nonché amante della stessa.
Questo scambio apparente di missive può essere considerato più uno sfogo lirico della poetessa che una vera e propria corrispondenza. Sotto certi aspetti richiama quei lunghi romanzi epistolari del Settecento in cui il destinatario era soltanto un pretesto per dar libero corso ai propri sentimenti. Una dichiarazione d’amore appassionato, dunque, il cui epilogo spietato si affaccia nelle ultime pagine: «Il mio totale oblio e il mio assoluto non–riconoscervi sono soltanto l’eco (rafforzata!) del vostro oblio e del vostro non–conoscermi».
La relazione, tra la poetessa e il suo amato, si modella sui termini utilizzati dalla scrittrice per definire i ruoli dei due amanti: lui è connotato come un bambino, «bambino mio», «piccolo mio», sono i suoi appellativi e lei si identifica con «una madre che manca al proprio figlio». Da ciò già si intravede lo squilibrio affettivo tra le due forme d’amore con le conseguenze di un sentimento sbilanciato che porterà a una sofferenza profonda e inevitabile. L’atteggiamento materno si evince anche dalle occorrenze dei personaggi delle fiabe che spuntano qua e là nelle lettere come termini di paragone o come immagini per fissare alcuni concetti in modo più definito. La Cvetaeva attinge certamente alla tradizione fiabesca europea comune ai lettori di ogni tempo e paragona il suo adorato a un mago aggiungendo: «Se voi siete un mago, io sono il pifferaio magico della leggenda, quello che con il suo flauto trascina via bambini e topi». In un altro passaggio esprime il desiderio romantico di vederlo addormentarsi: «Voglio assolutamente vederti dormire un giorno […] la sete di te che dormi, del Bell’Addormentato nel bosco».
Quello che emerge dalla scrittura è un amore proibito, impossibile, fatto di istanti sottratti furtivamente al tempo. Ecco l’apostrofe all’amato: «Mio ospite di un’ora». Sono attimi fugaci da vivere intensamente a discapito di tutto e di tutti: «Stanotte al caffè…» oppure «…Poco fa eravamo seduti al tavolino». La notte è un tempo privilegiato per gli incontri clandestini poiché nasconde da sguardi indiscreti ma aleggia pur sempre la minaccia di essere scoperti: «La notte è nostra, noi non le apparteniamo. E a forza di essere felice – felice di non essere amorosa – di poter parlare – di non dovervi baciare – per piena e pura gratitudine – vi bacio».
«Le strade vuote della capitale» diventano un teatro discreto in cui passeggiare nell’anonimato, una panchina diviene emblema della clandestinità come se si potesse sfuggire ai giudizi: «Qualche minuto fa, stavo accanto a voi su quella panchina vagabonda… panchina d’abbandono».
Un amore che ha due grandi avversari: il sonno e la stanchezza. Nelle ore di mancato riposo si sovvertono i ritmi naturali dell’umana vita: «Per la troppa attenzione mi è venuto di colpo un sonno tremendo». Ciò che maggiormente teme l’io poetico è la rivalità di una vita tranquilla che si manifesta con la naturalezza di una vacanza al mare – Višnjak aveva raggiunto la moglie e i figli in una famosa località marina sul Baltico. È la gelosia, allora, a far capolino tra le righe della lettera: «Non mi scriverete più: di giorno – mare, di notte – dormire». Il sonno incombe come una minaccia a discapito di tutto l’ardore che queste notti riservano agli amanti: «Ma ecco che la vostra fronte si aggrotta – in un nobile sforzo d’attenzione – e anche le vostre mascelle si contraggono – in un non meno lodevole sforzo di respingere un indomabile sbadiglio».
L’amore ha sete d’infinito e questo ideale cui anelare senza confini è simboleggiato dal cielo: «Amico mio, deve esserci un cielo anche per l’amore. Diverso dal baldacchino di un letto». In questa frase emerge tutta l’ansia di una donna che non può e non potrà mai accontentarsi di un amore a metà, di briciole lasciate per lei, tasselli di un amore claustrofobico che la spinge più d’una volta ad affacciarsi al balcone per respirare quell’aria che le manca, ma soprattutto per nutrirsi d’infinito con gli occhi rivolti verso il cielo. Non è un caso se nell’undicesima lettera, l’unica ricevuta da Višnjak, egli la ritragga così nel pensiero: «E ricordo voi, sul balcone, il volto levato verso il cielo nero, ugualmente implacabile per tutti».
(Marina Cvetaeva, Le notti fiorentine, trad. di Serena Vitale, Voland, 2011, pp. 85)