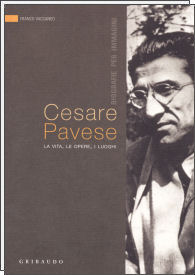La produzione lirica alfieriana, tra le più prolifiche di quelle tardo settecentesche, non ha mai incontrato fino ad ora un adeguato interesse storiografico. Nell’ambito dell’opera dello scrittore astigiano, una ricezione molto più profonda e appassionata è stata quella riservata alla Vita, autobiografia romanzata dove si celebra, tra bagliori pre-romantici, la vigilia del romanzo italiano; e, soprattutto, alle tragedie, genere che nella nostra letteratura, dopo la fervida restaurazione cinquecentesca, non aveva ancora conosciuto, malgrado diversi tentativi, soprattutto quelli del Della Valle e del Maffei, sicuri traguardi artistici (degni cioè di essere paragonati a quelli raggiunti dalla tragediografia europea tra ‘600 e ‘700).
La stessa scarsa fortuna editoriale delle Rime mostra come queste siano state spesso confinate in una fossa comune, al di fuori del recinto delle opere maggiori. In realtà nella varia serra della poesia arcadico-settecentesca, la lirica alfieriana rappresenta una pianta di grande interesse, ricca di materia autobiografica e temprata da innesti vari, capace di dare frutti che maturano nelle successive stagioni poetiche italiane.
Le rime alfieriane costituiscono un corpus di 315 testi, la maggior parte dei quali sono sonetti, conseguenza di quel petrarchismo metrico tipico della cultura poetica italiana, perdurante nel ‘700 accanto a primi tentativi di “poesia barbara” (sulla base dell’archetipo seicentesco costituito dal Chiabrera). La prima edizione delle Rime, del 1789, è seguita da quella, accresciuta, del 1802 e dalla definitiva e postuma del 1804. Caratteristica fra le principali della lirica alfieriana è quella di essere poesia di occasione, dal forte timbro diaristico (si parla infatti di “diario in versi”); in exergo alla maggior parte dei componimenti l’autore dà notizia della data e del luogo di composizione, esibendo la tipica saldatura tra vita e poesia che è già un carattere ascrivibile al Romanticismo incipiente. È questo un elemento di discreta originalità nella storia della poesia italiana, più facilmente riconducibile a esempi novecenteschi (si pensi all’Ungaretti dell’Allegria) che non ai modelli del petrarchismo, dove il calendario lirico che scandisce le stagioni dell’anima è una metarealtà platonica, sottratta alla mutabilità della storia.
L’idioletto lirico alfieriano è, ad ogni modo, riconducibile a una sorta di petrarchismo, molto lontano però da quello arcadico settecentesco, configurabile come un fenomeno stilistico, un disciplinato e comunque interessante tirocinio retorico. È, quello dell’Alfieri, una specie di petrarchismo michelangiolesco, nella misura in cui riesce a fondere, nella stessa molecola lirica, atomi danteschi e atomi petrarcheschi, esito originalissimo già traguardato per altre vie dal grande artista cinquecentesco nella sua lirica.
Avviando un’analisi testuale, diversi sono i sonetti alfieriani aperti da incipit cum auctoritate, dove sono cioè depositate reminescenze petrarchesche. Esempio famoso è il sonetto scritto visitando la casa del poeta ad Arquà, aperto da una quartina che contiene una vibrante celebrazione del poeta aretino («O cameretta che già in te chiudesti / quel grande alla cui fama angusto è il mondo, / quel sì gentil d’amor mastro profondo / per cui Laura ebbe in terra onor celesti»); il primo emistichio dell’endecasillabo incipitario cita perfettamente il celebre incipit del sonetto petrarchesco “O cameretta che già fosti un porto”. Un altro esempio emblematico è il sonetto aperto dal medesimo verso attraverso il quale Petrarca saluta il Rodano, e cioè «Rapido fiume che d’alpestra vena / con maestà terribile discendi / a te io volgo il tergo», dove una situazione lirica tipicamente petrarchesca, il colloquio fra l’Io lirico e gli elementi della natura, è rivissuta in senso romantico. Altri incipit alfieriani mostrano una più profonda sapienza intertestuale, che orchestra tra loro diversi ipotesti petrarcheschi; è il caso del sonetto “I’ vo’ piangendo e nel pianger m’assale”, dove il primo verso combina, incrociandoli, il ricordo del testo che apre la seconda parte del Canzoniere ( RVF 264 «I’ vo pensando e nel pensier m’assale») con l’inizio del penultimo fragmentum (RVF 365 «I’ vo’ piangendo i miei passati tempi»).
La riorchestrazione di armoniche petrarchesche è dunque, come denunciato da questi primi riscontri, un tratto tipico della lirica alfieriana. Come si diceva prima, la ripresa di questi moduli non è semplicemente un fatto stilistico, ma un’operazione retorica dotata di grande semantica. L’introspezione psicologica di ascendenza petrarchesca è nella poesia alfieriana la corda poetica che risuona con maggiore intensità. Tema di gran parte della poesia alfieriana è infatti la ricerca della propria umanità più autentica, inseguita nel dialogo con i grandi uomini del passato, exempla di virtus austera e pugnace (cfr il sonetto dedicato a Dante: «Grande padre Alighier, se dal ciel miri / me tuo discepol non indegno starmi»), o l’immersione in una natura impervia e inospitale (in linea con i canoni romantici, anche figurativi; si pensi all’arte di Friedrich) e capace di offrire meravigliosi correlativi alle emozioni tradotte in parole.
Nei momenti della lirica alfieriana a cui sono affidati i più severi bilanci esistenziali, accade di rivedere i diversi spunti petrarcheschi risillabati su spartiti michelangioleschi, come nel sonetto “Due fere donne, anzi due furie atroci”, dove la malinconia e l’ira combattono una lotta senza quartiere nel cuore del poeta, riportando alla memoria alcuni momenti di grande tensione esistenziale della lirica michelangiolesca. Aggiungo, a ulteriore dimostrazione della stratificazione intertestuale della poesia alfieriana, che l’incipit del sonetto sopracitato è il rovesciamento, quasi in chiave parodica, di quello dantesco “Due donne in cima della mente mia”, incentrato su una disputatio tra due figure femminili che personificano diverse virtù.
Le presenze intertestuali dantesche nella poesia alfieriana sono un fatto storicamente e culturalmente significativo, in quanto legati alla prima parziale riscoperta settecentesca di Dante, una novità dopo secoli di petrarchismo militante che aveva in parte incastonato, entro precisi canoni formali, la poesia italiana. Tale fenomeno si lascia ricollegare a esperienze poetiche più o meno coeve, come quelle di Varano e di Monti, autori di poemi in terza rima (rispettivamente le Visioni e la Bassviliana) che rappresentano il momento più fervido, in poesia, del dantismo tardo settecentesco.
Il codice lirico alfieriano conosce, attraverso gli inserti danteschi, una profonda escursione stilistica che tocca talora, grazie anche al ricorso a pigmenti del linguaggio comico, profonde punte espressionistiche. Oltre a dantismi lessicali, citazioni dirette, numerosi e interessanti sono i dantismi situazionali della lirica alfieriana. È il caso del sonetto “Tacito orror di solitaria selva”, aperto su un locus horridus non ignaro, probabilmente, del ricordo della selva dei suicidi di Inferno XIII. Il sonetto è, nella fronte, giocato sul lemma «selva», iterato e variato fino a realizzare rime inclusive («inselva/selva») in una dilatazione della semantica dantesca di partenza («onde membrando come io là godea / poscia mia mente tutta si rinselva»).
Oltre a questi registri di grande forza espressiva, esistono, nella lirica alfieriana, tonalità poetiche più lievi che scoprono, talora, la presenza di armoniche di gusto neoclassico, simili a quelle che risuonano, ad esempio, in alcuni momenti della poesia pindemontiana. Si pensi al sonetto dedicato alla Malinconia, orchestrato su un registro dolcemente elegiaco («Malinconia dolcissima che ognora / fida vieni e nvisibile al mio fianco, / tu sei pur quella che vieppiù ristora / benché sembri offuscar, l’ingegno stanco») che ricorda i famosi versi pindemontiani «Malinconia, ninfa gentile / la vita mia affido a te / i tuoi piaceri chi tiene a vile / ai piacer veri nato non è». Il rapporto con il proprio Io, tipico stilema alfieriano, raggiunge delle volte esiti originali, come nel sonetto dell’autoritratto (“Sublime specchio di veraci detti”), che è tra l’altro un forte momento intertestuale con la poesia di Foscolo e di Manzoni, entrambi autori di autoritratti in versi. Già a questa altezza è possibile misurare il grado di ricezione della lirica alfieriana nella nostra letteratura. Ugo Foscolo, autore, nei Sepolcri, della prima agiografia alfieriana in chiave romantica, ripete in alcuni sonetti tipiche movenze del poeta astigiano, come la perentoria esortazione all’anima («Che stai? Già il secol l’orma ultima lascia»).
Non mi sembra sia mai stato segnalato inoltre un possibile contatto intertestuale tra il canone dei “vires illustres”, scandito nel carme Dei Sepolcri (nell’ordine: Dante, Petrarca, Machiavelli, Michelangelo, Galileo), e un sonetto alfieriano scritto a Firenze nel gennaio del 1779, dove nella fronte l’autore rievoca, pur in un ordine lievemente diverso, i medesimi personaggi evocati dal Foscolo. Ecco i versi: «Qui Michelangiol nacque? e qui il sublime / dolce testor degli amorosi detti? / Qui il gran poeta che in sì forti rime / scolpì d’inferno i pianti maledetti? / Qui il celeste inventor ch’ebbe dall’ime / valli nostre i pianeti a noi soggetti? / E qui il sovrano pensator ch’esprime / sì ben del prence i dolorosi effetti?»
Sempre a proposito dell’eredità della poesia alfieriana nelle stagioni letterarie successive, si ricordi almeno come alcune linee critiche abbiano voluto svelare nel presunto titanismo dell’ultimo Leopardi (legato alle pose liriche tracciate in poesie come “Amore e Morte”, “A sé stesso”,“La ginestra”) una radice alfieriana, interrata nella medesima humus dalla quale nascono le tragedie e le liriche.
Al di là del valore artistico della poesia alfieriana, che è sempre, non paia una banalità ripeterlo, il vero merito detenuto da un fatto d’arte, uno dei grandi punti d’interesse di questa lirica è in parte legato alla rifondazione, su basi già romantiche, del rapporto collocutivo dell’Io lirico con se stesso, istanza supremamente petrarchesca, che viene così traghettata verso la modernità. Sulla necessità di una riconsiderazione storiografica non solo della produzione in versi, ma in generale di tutta l’opera letteraria dello scrittore astigiano, che venga cioè liberata dai paramenti e dalle sovrapposizioni posteriori, le quali hanno in parte ridotto la vicenda alfieriana a un’agiografia romanticheggiante (il primo brano di agiografia alfieriana, come si diceva, è proprio quello foscoliano dei Sepolcri, raccontato nei vv. 195-205) giova ripensare a quanto scritto recentemente da Ezio Raimondi: «Se esiste un personaggio problematico che bisognerebbe sottrare ad una specie di museo dove si è troppe volte cancellato in funzione dello statuario ciò che è pittorico, ciò che è ombra, ciò che è elemento patetico è contradittorio, questi è sicuramente l’Alfieri».