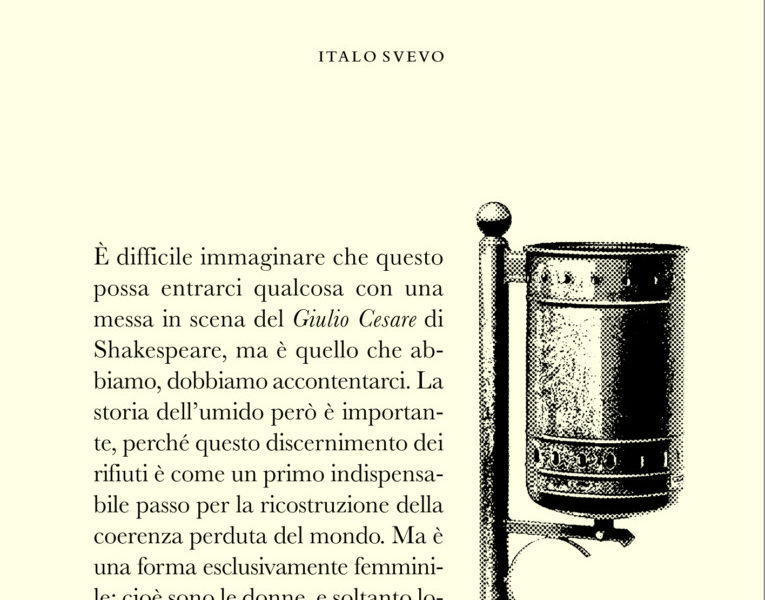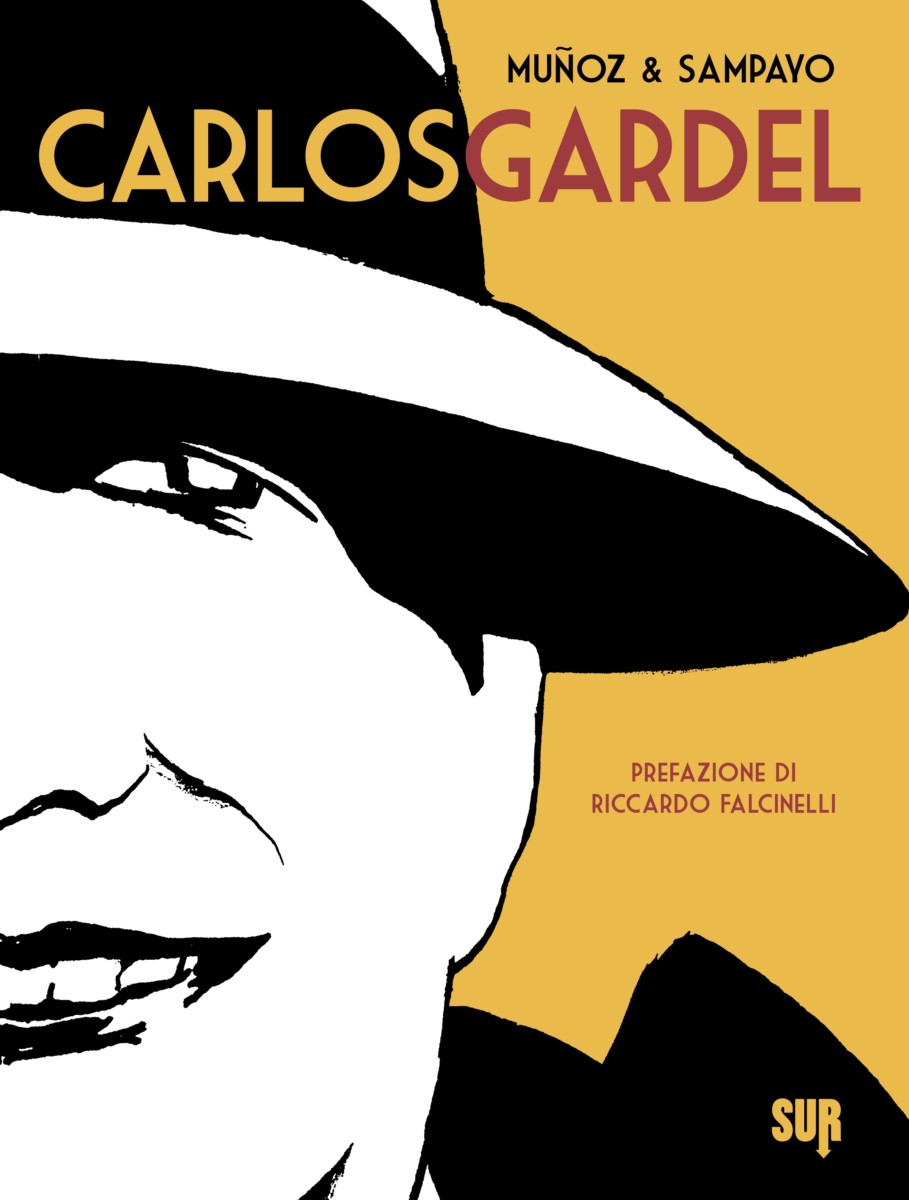Riuscireste in quindici minuti a pensare ai benefici che un povero può trarre dal capitalismo e a organizzare un discorso convincente, sostenuto da valide argomentazioni e presentarlo con discreti artifici retorici davanti a una giuria e una platea di gente pronta a giudicarvi? Sally Rooney, autrice ventisettenne di Parlarne tra amici (Einaudi, 2018), sì. La differenza tra Sally Rooney e tanti altri suoi contemporanei è che il suo apprendistato culturale è stato svolto presso la pratica del debate speech. L’autrice ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del dibattito a diciannove anni ed è diventata campionessa europea durante l’università. Rooney pone questa occasione come punto fondamentale della sua formazione culturale e racconta nel dettaglio della sua esperienza nel microcosmo dei debateer in un articolo scritto per The Dublin Review: «I was nineteen when I started debating competitively, and it’s probably fair to say that most things I did when I was nineteen were motivated by a desperation to be liked». Le abilità retoriche affinate durante quegli anni diventano così una caratteristica della sua scrittura, fortemente impregnata di dialoghi serrati e acume argomentativo.
A venticinque anni inizia a scrivere quello che diventerà Parlarne tra amici, libro definito da The New Yorker «a new kind of adultery novel». Il romanzo si concentra sulle relazioni che legano i quattro personaggi principali della vicenda: Frances, protagonista e studentessa del Trinity College, accompagnata dalla sua migliore amica ed ex ragazza Bobbi, incontra dopo un’esibizione di spoken word poetry Melissa, fotografa affermata nell’ambiente dublinese. Melissa è sposata con Nick, attore di cui la protagonista si innamora e con il quale inizia una relazione.
La protagonista sfrutta la sua abilità retorica per apparire brillante e mascherare la sua difficoltà ad abbandonarsi agli altri; la risposta di Frances alle insicurezze che emergono nelle pagine iniziali è la consapevolezza, a tratti schiacciante e autocritica, che ha di sé. Lucida e analitica, tende a vivisezionare in maniera cerebrale ogni suo rapporto. Le sue conversazioni sono competizioni che ingaggia contro altri retori, altrettanto abili, come Bobbi; il loro rapporto viene analizzato e discusso costantemente grazie alla predisposizione condivisa a intellettualizzare le dinamiche relazionali. La protagonista percepisce anche con Nick questa sorta di competizione negli scambi per e-mail, che in alcuni momenti descrive come un testo che editano collettivamente o come un intricatissimo inside joke mandato avanti battuta per battuta.
Rooney è abile nel ritrarre quella forma di autocoscienza che spesso paralizza i coetanei della protagonista, riuscendo a trasferire nel libro esitazioni provate da chi muove i primi passi in un ambiente sconosciuto e i tentativi di ammantare con l’arguzia la deferenza nutrita verso il mondo borghese nel quale il romanzo si ambienta. Il racconto di Frances che si addentra in punta di piedi nelle ville di giornalisti e attori e nel «mondo delle cose di letteratura» è schietto e autentico, tuttavia la storia non si concentra soltanto sulla soggezione scaturita dal timore reverenziale ma soprattutto sulla risposta e la spinta di autoaffermazione che la protagonista riesce a imporre mentre si interfaccia con questo nuovo ambiente estraneo.
Un’altra delle particolarità più vistose del testo è che spesso Frances sceglie l’e-mail come forma di comunicazione e la struttura narrativa in parte si presenta come una sorta di romanzo epistolare ambientato su Gmail. Pur non andando a tematizzare la questione della conversazione online e offline in maniera esplicita, l’autrice ha affermato programmaticamente di voler parlare della generazione di cui fa parte e ha deciso di farlo scontrandosi con la difficoltà dell’assimilare in letteratura l’evolversi dei rapporti anche attraverso gli scambi virtuali. Questa impostazione è il modo con il quale Sally Rooney rinnova il topos letterario del tradimento e dell’infedeltà, che da un classico come Madame Bovary alla forma epistolare sperimentata da Chris Kraus in I love Dick si trasferisce sui mezzi di comunicazione più attuali e contribuisce a rendere questo ritratto delle dinamiche relazionali contemporanee realistico e sincero.