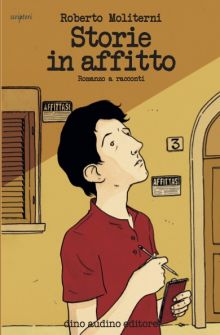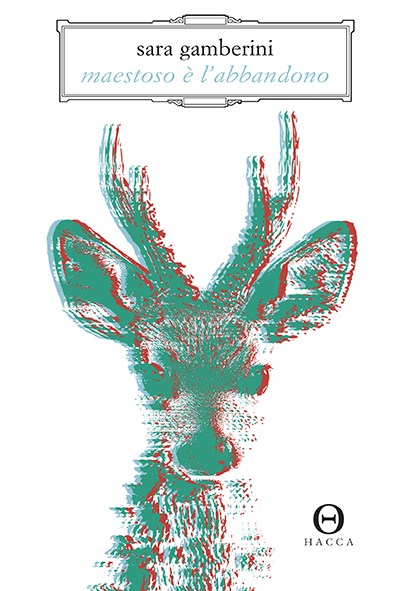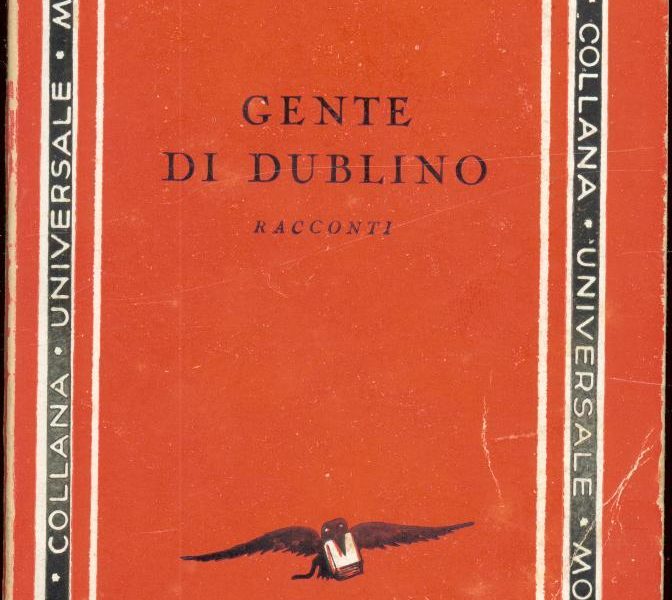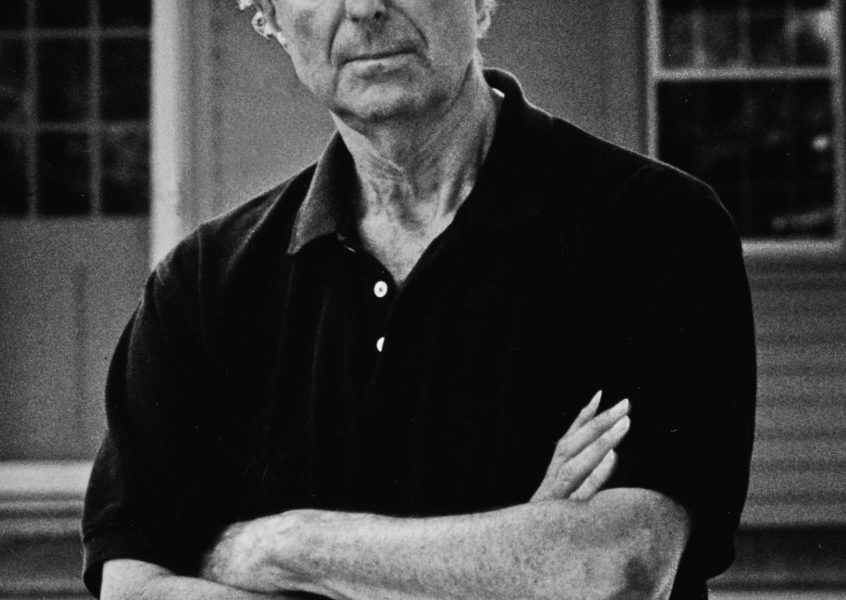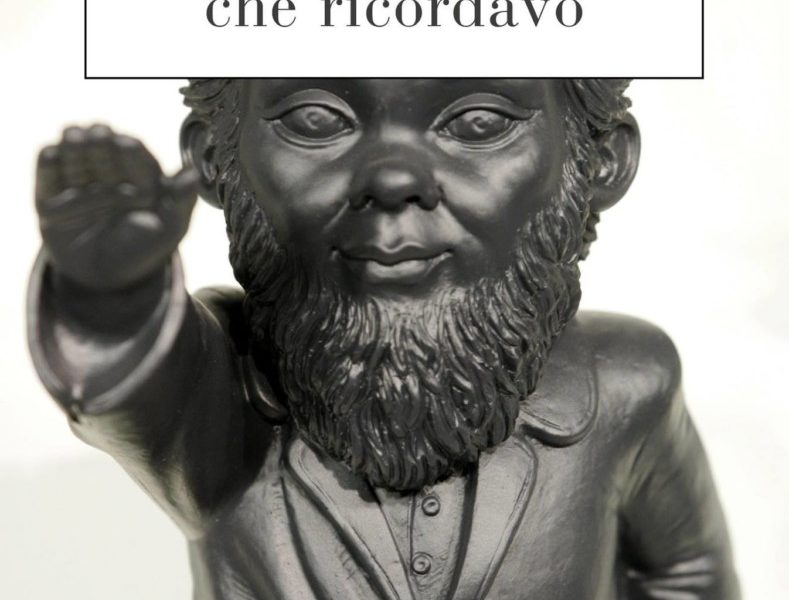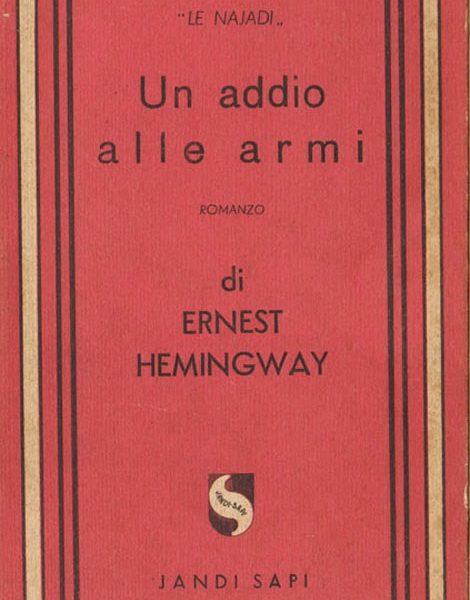Piemonte, 1944. Due giovani fratelli, Michele e Dino, vengono fatti prigionieri dai fascisti. Per loro inizia l’incubo della deportazione in Germania e del lavoro forzato. Tuttavia, per il più giovane dei due la strada sarà più agevole del previsto, perché sarà destinato al campo di Königsbrück, centro d’addestramento truppe tedesco dove ritroverà il suo ambiente ideale: la cucina. Nelle sale dell’Offizierskasino, il Circolo Ufficiali del campo, Dino farà i conti con una verità che finirà per portarsi dentro per sempre: le sfaccettature del mondo – e della verità stessa, e del male – sono innumerevoli.
Esordio di Livio Milanesio, La verità che ricordavo (Codice Edizioni, 2018) è un romanzo che indaga come nel bel mezzo dell’orrore possano esistere isole felici e gesti quotidiani, come i responsabili stessi di quell’orrore possano mostrare al mondo altri volti, non propriamente spaventosi. La storia di Dino è sia avvincente sia straniante. Il mondo in cui si muove il protagonista è un affresco di ciò che normalmente non trova posto nei capitoli dei libri di storia dedicati alla Seconda guerra mondiale: il quotidiano, l’amore, il cibo nella Germania nazista.
La quarta di copertina non lascia spazio a sorprese: questa è una “storia vera”. Partiamo dunque da qui, chiedendo all’autore di raccontare la genesi di questo romanzo e perché, a un certo punto, ha sentito il bisogno di scriverlo.
Mia nonna era una cuoca e ogni domenica la famiglia si riuniva a casa sua, nelle Langhe. Durante gli infiniti pranzi i tre uomini della famiglia parlavano delle rispettive guerre: il marito Bartolomeo della prima, autiere sul Carso, i figli Bernardo (Dino) e Michele della deportazione nella Seconda. Dino era mio padre. Da piccolo i suoi sporadici e insoliti episodi di guerra mi affascinavano e mi tenevano seduto a tavola per tutta la durata del pranzo. Durante l’adolescenza ho cominciato a rifiutare le storie di Dino. Ero diventato un estremista, come molti adolescenti, e mal sopportavo i racconti di tedeschi “buoni” e di un periodo felice durante la più grande tragedia del ventesimo secolo. Col passare degli anni, siamo rimasti solo io e lui della nostra famiglia e ho sentito il bisogno di un riavvicinamento. L’ho fatto raccogliendo la sua storia come un’eredità e l’ho raccontata come se fosse mia. Ho cercato di comprendere immedesimandomi in quel non-eroe che era riuscito a passare quasi indenne attraverso l’orrore.
La verità che ricordavo racconta la storia di due fratelli. Ce li potresti presentare? Chi sono Dino e Michele?
Dino è un ragazzo nato e cresciuto in un’osteria di campagna. E tanto gli basta. Come si legge nel romanzo: «Aveva imparato a scrivere annotando le comande, si era esercitato nell’aritmetica sommando il conto, sottraendo il resto, dividendo la mancia con il fratello, le rare volte che Michele lasciava la camera per dare una mano. Il profumo delle pietanze gli aveva impregnato l’esistenza».
Non conosce il mondo, non gli interessa conoscerlo. L’osteria, il paese hanno tutto ciò che è in grado di desiderare, inoltre ha un aspetto fisico che, in quei tempi, non aiuta ad andare in giro tranquillo.
«Illuminato dal riverbero del grembiule bianco brillava un naso importante, un becco affilato, una curva decisa, impossibile da scambiare per una rottura. Un cespuglio di capelli ricci e scuri a mala- pena tenuti a bada. Neanche i giudei assomigliavano alle loro caricature quanto vi somigliava Dino».
Michele invece è l’opposto: fratello maggiore e partigiano è presente al suo tempo, è schierato, partecipa, cerca di cambiare le cose, di farsi un’opinione. Anche fisicamente Michele è diverso da suo fratello.
Nel libro è presente un personaggio piuttosto particolare: un nano «di eccezionale altezza» che appare in determinate situazioni. Chi è? Esisteva fin dall’inizio o l’hai aggiunto in corso d’opera?
Il nano c’è sempre stato. Dino si lascia trasportare dalla corrente della storia in una maniera talmente inerme che c’era bisogno di qualcuno che ne rallentasse la corsa e lo mettesse di fronte alla realtà. Insomma in questa storia il personaggio più “magico” è quello più legato alla realtà.
In La verità che ricordavo il cibo è un elemento importante, è casa e sicurezza. È la vita di Dino. Credi che il cibo sia importante, in quanto elemento che accomuna tutti, “buoni e cattivi”?
Dino è cresciuto in una cucina e sopravvive alla guerra grazie a una cucina. Manca un pezzo alla storia che un giorno scriverò: alla liberazione Dino continuerà a cucinare per gli americani prima di tornare alla cucina dalla quale era partito. Attorno al cibo, al nutrirsi si sono giocati i destini di milioni di persone di quel periodo, non solo in Europa. Il cibo è importante per tutti, sempre.
Il libro inizia in Piemonte, nel cuneese, là dove sono ambientati tanti romanzi sulla Resistenza. Che cosa è rimasto di quel periodo in quelle zone?
Sono zone che sono state coinvolte direttamente dalla guerra partigiana. Oltre all’ampia letteratura, Fenoglio, Pavese, Arpino, sono rimaste le lapidi (a Narzole, luogo di partenza della storia, ce n’è una che ricorda una strage dimenticata). Ma stanno scomparendo i testimoni (mio padre è morto a maggio dell’anno scorso) e forse sta scomparendo anche una certa familiarità con quel tempo. Ho la sensazione che stia diventando una di quelle “fette” di storia archiviata, come la sconfitta di Alarico a Pollenzo o il passaggio del giovane Napoleone da quelle parti.
Veniamo al cuore del tuo lavoro: il titolo suggerisce che c’è una verità, una verità che cozza con il senso comune. Qual è questa verità? Hai dovuto, in qualche modo, elaborarla?
Il titolo contiene un paradosso che è l’atteggiamento di ogni testimone diretto: è convinto di raccontare la verità, ma è una verità filtrata dalla qualità della sua memoria, non del tutto attendibile, una non verità. Ed è questo che mi interessava: come un evento venga filtrato e rifiltrato dalla nostra voglia di ricordare. Infatti questo non è un romanzo storico né tanto meno un saggio. È il tentativo di guardare un evento con gli occhi di mio padre giovane. In più esiste un elemento “magico”: come ho detto questa è una storia che fa parte di me da sempre e inizialmente non era diversa dalla storia del Barone Rampante o Marcovaldo. E anche qui il concetto di verità diventa ambiguo.
Ho saputo che hai lavorato questo romanzo per molto tempo. Ci sono state molte riscritture?
Cinque. Complete. Oltre a dover fare i conti con un “testimone” reticente come mio padre, ho dovuto imparare a fare il romanziere. E l’ho fatto in modo empirico scrivendo e riscrivendo fino a ottenere una storia soddisfacente. Insomma chi non ha testa abbia gambe.
Come è stato il lavoro di ricerca? Ho saputo che sei stato nei luoghi del romanzo, in Germania. Come è stato vederli dal vivo?
Il campo è stato occupato dai Sovietici nell’aprile del 1945 e mantenuto in funzione fino al 1991. La regione della Sassonia si è trovata per le mani un’enorme zona militare da bonificare senza averne le risorse e per ora l’ha abbandonata. Gran parte degli edifici sono ancora in piedi, compresa la palazzina del Circolo Ufficiali dove fu destinato Dino. Sono stato a visitarlo da solo perché mio padre si è rifiutato di venire. Non ho faticato a comprendere la geografia dei racconti di Dino, ma mi sono reso conto, proprio sulla collina del Circolo Ufficiali, che malgrado fossi immerso nella realtà di quella storia non ne ero ancora entrato davvero in possesso. La sera stessa, in un brutto albergo di Dresda, ho ricominciato la quarta riscrittura. Da zero.
Hai letto molti romanzi ambientati durante la Seconda guerra mondiale? Ti senti di consigliarne alcuni più di altri?
Ho letto soprattutto romanzi perché, come ho detto mi interessava soprattutto “come” veniva raccontata quella vicenda. Tra quelli che mi hanno colpito di più c’è Una vita intera di Robert Seethaler (Neri Pozza, 2015), la storia di un altro “inconsapevole” che riesce a farsi scivolare addosso la guerra. E La via del Ritorno di Remarque (1931), sulle conseguenze di chi rimane. Ma soprattutto Colombe Schneck, Le madri salvate (Einaudi, 2013) dove l’istinto naturale di sopravvivenza supera ogni altra considerazione.
Un consiglio per chi vuole scrivere un romanzo partendo da una storia vera, forte come la tua?
Sono un “giovane” esordiente, non me la sento di dare consigli. Piuttosto mi sentirei di dare un consiglio a chi una storia ce l’ha già. Ci vuole pazienza e perseveranza. Il solo fatto di aver scritto qualche cosa, anche se è una storia vera e importante, non apre nessuna strada. Le strade bisogna aprirsele da soli, a testate. E in questo mi sento ancora diversa da Dino.
(Livio Milanesio, La verità che ricordavo, Codice, 2018, pp. 296, euro 18)