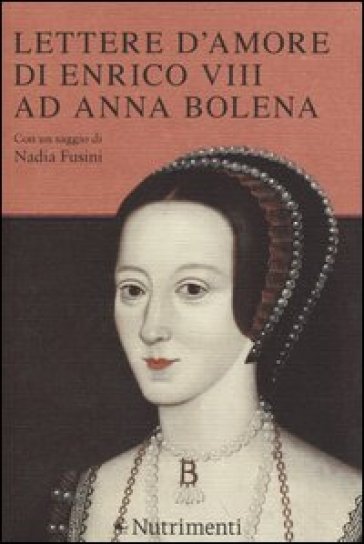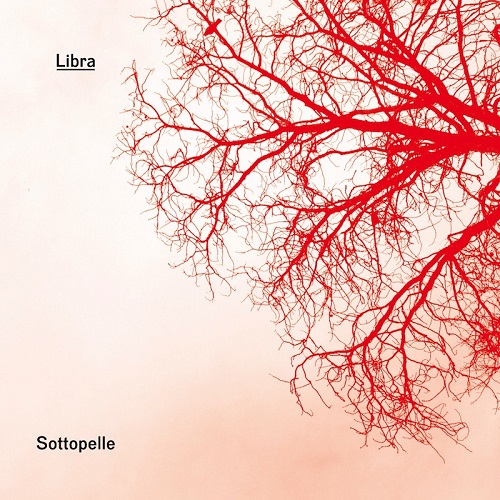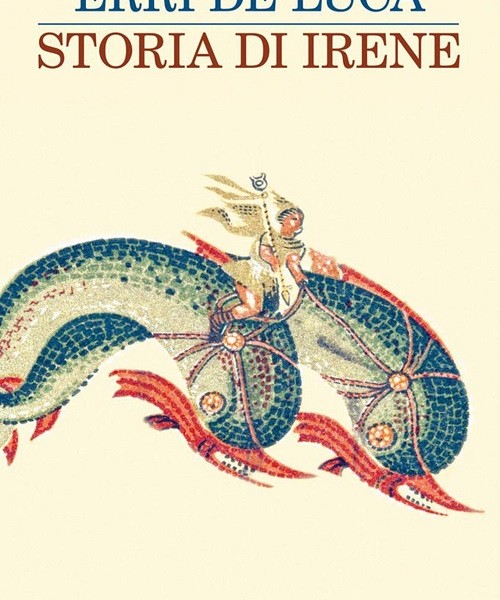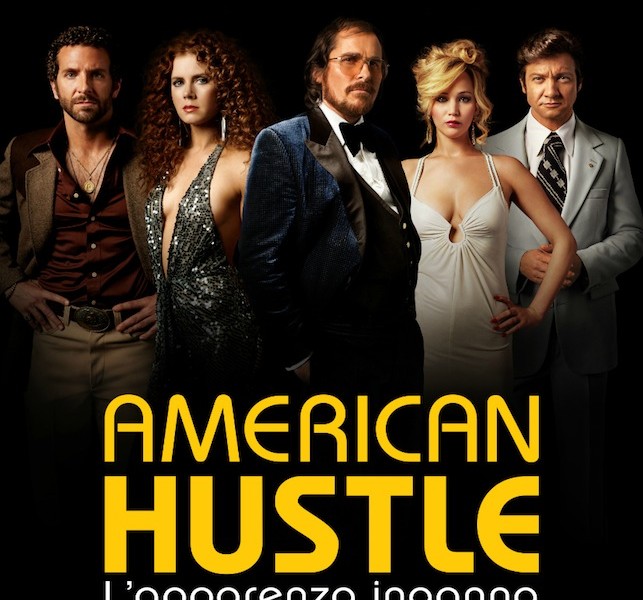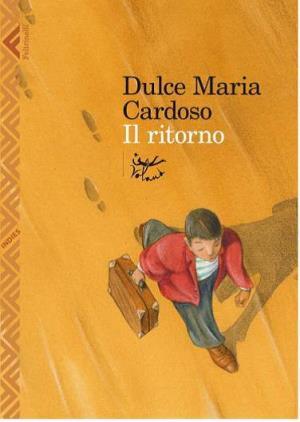Sbirciare dal buco della serratura è un’attività che, in fin dei conti, piace un po’ a tutti. Aggiungiamoci poi che si parla di uno dei personaggi più discussi della corona inglese e di una delle vicende più controverse della storia di tutta l’Europa moderna, ed ecco che le Lettere d’amore di Enrico VIII ad Anna Bolena (Nutrimenti, 2013) assumono un interesse del tutto particolare, sebbene manchino le risposte di Anna al suo re. Per questo motivo si deve accogliere con entusiasmo la prima traduzione italiana delle Lettere, che si basa sull’edizione inglese del 1714, la prima della storia, sugli originali conservati nella Biblioteca Vaticana, in cui sono infine giunti non si sa con certezza attraverso quale canale e dopo che erano praticamente scomparsi per anni.
Si potrebbe rimproverare alla curatrice, Iolanda Plescia, di non essersi basata sulle lettere originali, per altro facilmente consultabili, ma di aver piuttosto preferito basare la traduzione su un’edizione settecentesca, «non perché sia la più accurata», come afferma nel saggio posto alla fine del volume, ma perché: «rimane pur sempre quella che ricorda più da vicino la lingua del re». Anche il commento alle singole lettere appare piuttosto scarno, per lo meno agli addetti ai lavori, poiché vi si annotano di tanto in tanto solo piccoli riferimenti al contesto, quando invece i documenti avrebbero permesso una trattazione più ampia con possibili riferimenti sia ai modelli letterari utilizzati dal re per “sedurre” Anna, sia al contesto storico-politico.
Tuttavia, lo scopo del volume, si difende preventivamente la Plescia, non è quello di fornire una nuova trascrizione a partire dai documenti originali, né di affrontare una vera e propria edizione critica delle lettere di Enrico VIII, ma di «presentare in lingua italiana un documento storico e culturale così com’è stato recepito da quegli uomini e quelle donne d’inizio Settecento». Il merito della traduzione certamente rimane, sebbene appaia più un’opera dedicata al grande pubblico che non invece uno strumento (che certamente sarebbe stato utile) per gli studiosi. Una simile edizione, infatti, avrebbe fornito agli storici un’opera utile e funzionale, senza privare, nel contempo, gli altri lettori della giusta fruibilità, e anzi aiutando questi ultimi assicurandogli un livello di comprensione più profondo e completo.
Proprio al grande pubblico, infine, appare dedicato il saggio introduttivo di Nadia Fusini, che corre in aiuto a quanti non ricordassero con precisione le complicate vicende politico-sentimentali che portarono l’Inghilterra alla riforma anglicana. Bella e interessante appare la lettura del personaggio di Enrico VIII, un uomo, o meglio, un re perseguitato dall’assenza di una discendenza maschile tanto da renderlo folle, che piegato «all’imperativo monarchico della procreazione», si ritrova alla fine con ben sei mogli e due sole figlie femmine e animato da tale ossessione alla fine promulgherà tre editti di successione (che, ironia della sorte, verranno disattesi).
In definitiva, queste Lettere sono il frutto di un uomo innamorato, che si ritrova sposato a una donna più matura per questioni di convenienza politica, ma che per proprie credenze si considera vittima incolpevole delle congiunture, eppure punito da una scarsa discendenza tutta al femminile. Qualcuno ipotizza una malattia mentale o multisistemica, anche se probabilmente si è trattato solo di un miscuglio di credenze popolari, pressioni, attese dinastiche e un grande potere raggiunto in età troppo giovane.
(Lettere d’amore di Enrico VIII ad Anna Bolena, a cura di Iolanda Plescia, Nutrimenti, 2013, pp. 128, euro 12)