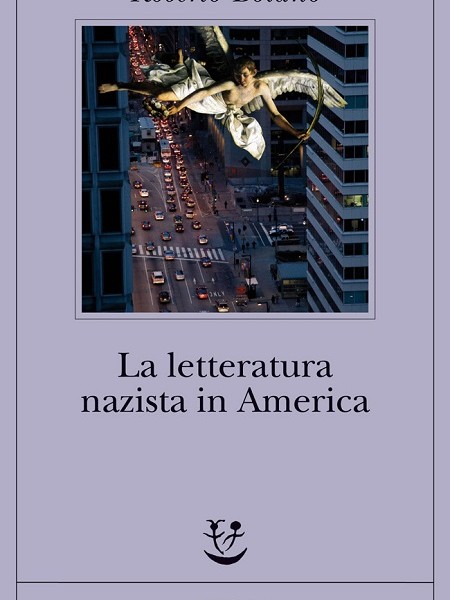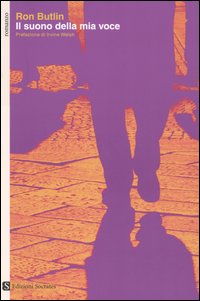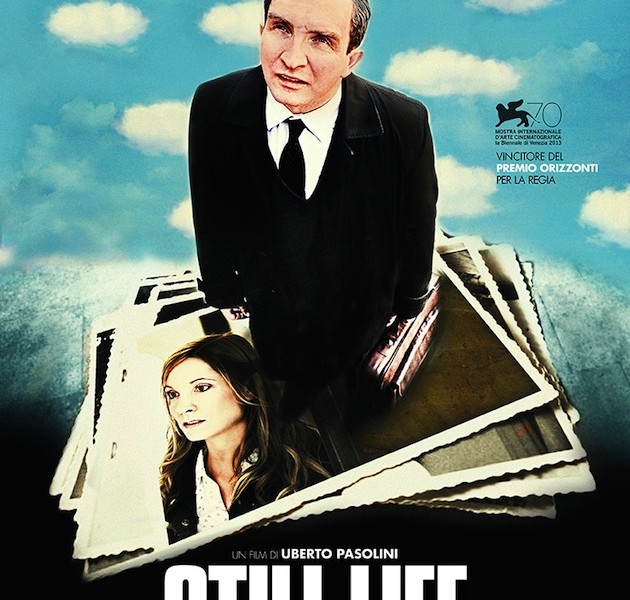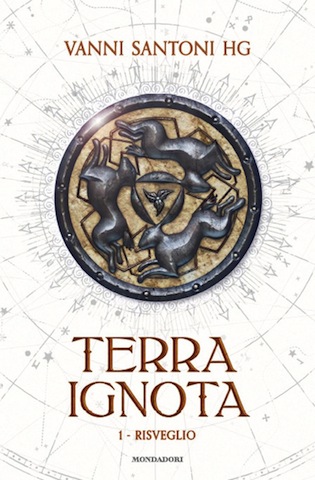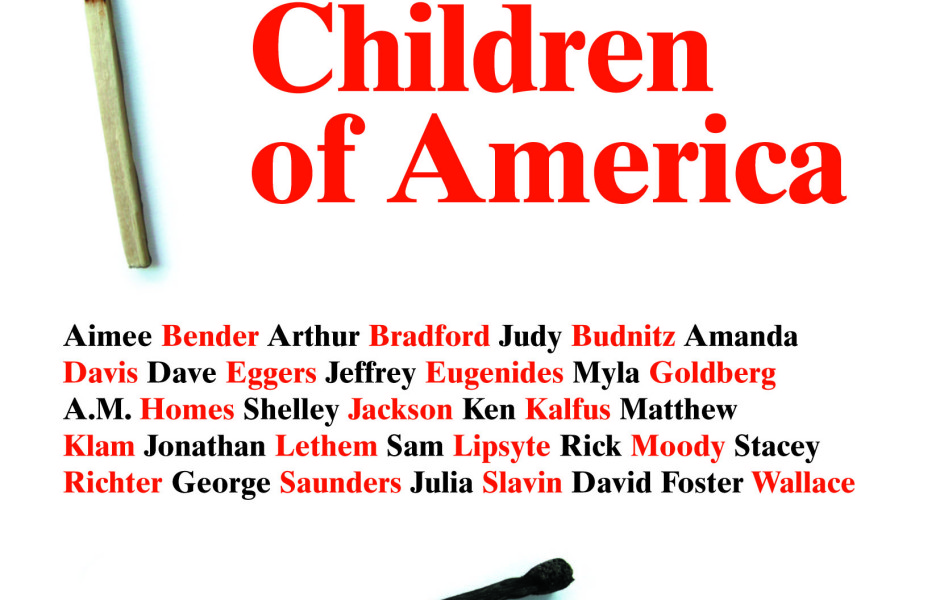Prendete un libro come La letteratura nazista in America (Adelphi, 2013), di Roberto Bolaño. Provate a leggerlo sul treno, in metro, davanti ad altre persone, insomma. Gli sguardi sospetti dei vicini più prossimi, le loro sopracciglia incurvate in maniera anomala, il modo di fissare quasi con disappunto prima il titolo del libro e poi voi che lo state leggendo, già da soli valgono il prezzo di copertina. E non vi venga mai in mente di ricambiare le occhiate con sguardi di scuse, ma rimanete freddi, o al massimo, sfoggiate un sorriso sardonico. Perché solo così dimostrerete di aver compreso, almeno in parte, l’universo Bolaño.
La letteratura nazista in America si compone di trentadue biografie inventate di uomini e donne che hanno dedicato la propria vita alla scrittura, sia essa poesia o narrativa, accomunati dal dato geografico – hanno vissuto tutti nel grande continente americano – e da una particolare simpatia per il nazismo e l’odio razziale, a cui si aggiungono una galleria finale di individui minori, un elenco di case editrici e di riviste, una bibliografia delle più importanti opere citate.
Bolaño racconta di vite bieche, a tratti infime, per lo più brancaleonesche, come quella di Gustavo Borda, «propenso all’amore e all’amor proprio», che si dice «fosse il bersaglio prediletto di tutti i sadici di Hollywood»; come quelle dei due «favolosi fratelli Schiaffino»: l’uno, Italo, autore di manifesti e poemi per la tifoseria del Boca Juniors di cui è capo ultrà; l’altro, Argentino, detto «El Grasa» perché «di statura medio-bassa, grassottello», poeta e ultrà anch’egli, che propone «come risposta latinoamericana al calcio totale l’eliminazione fisica dei suoi migliori esponenti, vale a dire l’assassinio di Cruijff, Beckenbauer, ecc.». O ancora come quella di Carlos Ramírez Hoffman, detto «l’infame», a cui è dedicato l’ultimo capitolo e dalla cui costola nascerà il personaggio di Carlos Wieder, protagonista di Stella distante.
Storie curvilinee, perché capaci di girare su se stesse in maniera inaspettata, che l’autore cileno sviluppa attraverso una scrittura ondivaga, con alti e bassi perfettamente bilanciati nell’alternanza: Jim O’Bannon «conservò fino alla fine il disprezzo per gli ebrei e gli omosessuali; i negri cominciava pian piano ad accettarli quando lo raggiunse la morte»; «Luz Mendiluce fu una bambina bellissima e in salute, un’adolescente grassa e pensierosa e una donna alcolizzata e infelice. […] La famosa fotografia di Hitler con in braccio una bambina di pochi mesi l’accompagnò per tutta la vita».
La letteratura nazista in America è un libro per certi versi geniale, attraverso il quale Bolaño rielabora con la sua particolare verve provocatoria le lezioni di Borges e di Wilcock. Un libro che si autosostiene con rimandi e citazioni interne, con paradossi deliranti, ma spesso anche con riferimenti a persone e dati reali – la vita di Bolaño stesso è parodizzata in alcuni punti –, e che fa dello straniamento, per lo più comico, il fattore primario della sua natura ludica.
(Roberto Bolaño, La letteratura nazista in America, trad. di Maria Nicola, Adelphi, 2013, pp. 250, euro 19)