La settima giornata del Festival Internazionale del Film di Roma si è concentrata sulla presentazione Fuori concorso dell’attesissimo La ragazza di fuoco, secondo capitolo della saga fantasy The Hunger Games, capace con il primo titolo di mettere d’accordo il pubblico adolescente e gli spettatori più esigenti.
Ricapitolando: il mondo non esiste più come lo conosciamo, esiste solo la nazione di Panem con la sua capitale, Capitol City, e dodici distretti periferici intorno ad essa. Per ricordare il fallito tentativo di insurrezione contro il potere della capitale, ogni anno vengono selezionati come Tributi due giovani da ogni distretto per partecipare agli Hunger Games, gioco al massacro in un’arena ripresa costantemente dalle telecamere da cui deve uscire un solo vincitore. La settantaquattresima edizione aveva visto Katniss Everdeen, del dodicesimo distretto, sconvolgere le regole del gioco con il suo partner Peeta Mellark, costringendo gli organizzatori a lasciar sopravvivere i due ragazzi dichiarando quindi per la prima volta un doppio vincitore.
Katniss e Peeta sono diventati delle celebrità ovunque. Con la loro vittoria sono entrati tra i simboli di Capitol City, ma ancora di più Katniss è diventata una speranza per la ribellione. La sua fama fomenta infatti la rivolta dei poveri contro il presidente Snow che cerca, da un lato, di sfruttare la storia d’amore, creata dai due ragazzi come espediente per conquistare favori durante i Giochi, per placare la folla, e dall’altro di neutralizzare lo spirito rivendicativo di Katniss. Decide, quindi, di organizzare un’edizione speciale dei Giochi per il settantacinquesimo anniversario, richiamando da ogni distretto campioni delle precedenti edizioni. Katniss e Peeta si ritrovano così di nuovo a dover combattere nell’arena.
Se nel primo capitolo della serie ci si era concentrati sulle dinamiche dello spettacolo e della rappresentazione del potere che circondano gli Hunger Games, con La ragazza di fuoco la serie assume una sfumatura più marcatamente politica.
È l’uso dell’immagine, della proiezione di sé, che ancora una volta distingue Katniss dagli altri partecipanti agli Hunger Games, la consapevolezza del divario tra messaggio pubblico e messaggio privato e la capacità di gestirlo, apparendo allo stesso tempo come rappresentante del potere e miccia della rivoluzione.
Rispetto al primo capitolo, La ragazza di fuoco si concentra meno sui giochi proprio per far risaltare il contesto socio-politico in cui si agita la rivoluzione: un mondo diviso tra ricchi e poveri sfruttati pronto a esplodere in un conflitto che ha in sé gli elementi di una lotta di classe svuotata di connotati ideologici. La ghiandaia imitatrice della spilla di Katniss diventa sinonimo di rivoluzione. La repressione di Snow si inasprisce mentre la ragazza arriva a sfidarlo apertamente e intorno a lei sempre più persone si mostrano pronte a seguirla.
L’avvicendamento dietro la macchina da presa tra Gary Ross e Francis Lawrence ha dato a La ragazza di fuoco un’impronta più oscura e adulta, più rispondente allo stile del regista (Constantine, Io sono leggenda), che si sposa meglio con il clima cupo di oppressione della trama.
Girato in parte con la tecnologia IMAX, il secondo capitolo di The Hunger Games è ovviamente un tripudio di effetti speciali e CGI perfettamente calibrato che mantiene alto per tutte le sue quasi due ore e mezzo il livello di spettacolarità e di tensione emotiva.
Accanto alla dimensione del puro intrattenimento, e all’attenzione rivolta al suo pubblico specifico, La ragazza di fuoco conferma tutta la capacità della serie di coniugare azione e riflessione, profondità di introspezione e spettacolo puro.
C’è da accettare, ed è un compromesso che le serie cinematografiche richiedono sempre più spesso, l’assenza di completezza di La ragazza di fuoco. Chi non ha visto il primo film si trova senza coordinate per comprendere la trama che si è sviluppata fino a quel punto, e la scelta di rinunciare a un finale vero e proprio, un tempo peccato mortale del cinema, per aprire da subito il collegamento con il capitolo successivo in lavorazione lascia un senso di incompiutezza che prevale, inevitabilmente, sulla attesa per gli sviluppi.
Senza nulla levare agli altri ottimi interpreti (fatta eccezione per il sempre rigido Liam Hemsworth), Jennifer Lawrence, che si conferma attrice di incredibile talento, ha una grande parte di merito per la riuscita del film.
(The Hunger Games – La ragazza di fuoco, di Francis Lawrence, 2013, azione/fantascienza, 146’)




.jpg)










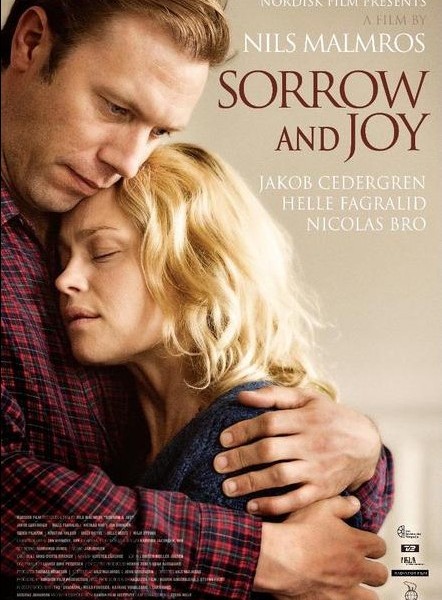
.jpg)

.jpg)





